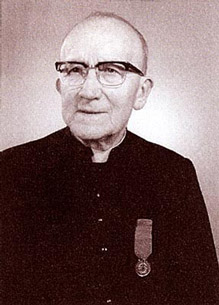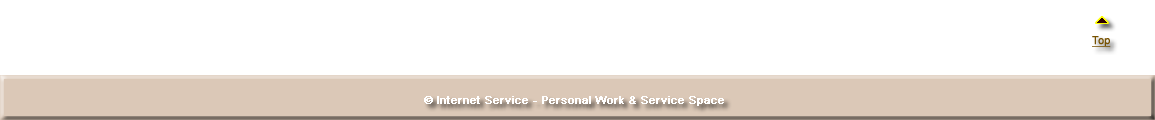Caposaldo «Venere»
Quando si dice la Prima Messa è comune usanza stampare un santino; anch'io l'ho fatto per la mia prima Messa; lo ricordo benissimo; diceva cosí: «Il sacrificio della mia vita che con quello del tuo Figlio da me richiedi, o Dio, salga gradito al tuo cospetto e concedi che ogni giorno te l'abbia ad offrire con la generosità di quest'oggi».
«Ogni giorno» e quindi anche il 16 dicembre 1942, quando "il sacrificio della vita" mi si presentò non piú in una tal romantica prospettiva bella ad accarezzarsi specialmente nel fervore del primo altare, ma in un'urgenza violenta, improvvisa. Quando si cerca di vivere nella fede, si fanno a volte strane preghiere che quasi non si riconoscono come proprie; ma poi, alla luce di quello che accade, ci si accorge che erano quanto mai pertinenti ed allora si ringrazia il Signore perché ce le ha suggerite.
Dai primi di novembre mi trovavo cappellano di collegamento al Comando della Divisione "Pasubio". I cappellani di collegamento erano un'idea del cappellano capo Mons. Pintonello; dovevano servire il Quartier generale, i reparti divisionali e collegare e provvisoriamente sostituire i circa 20 cappellani in forza alla Divisione. A Millerovo avevo lasciato il mio 837 O.d.C. che era in procinto di ricevere gli avvicendamenti; tutti sarebbero rimpatriati in forza del diritto di chi aveva già passato un inverno in Russia; anche io avrei dovuto seguire la loro sorte ma Mons. Pintonello mi aveva persuaso a rinunciare all'avvicendamento. «Ti trasferisco al Comando della Pasubio ed appena passato il Natale, ti mando in licenza in Italia».
Raggiunsi Kantemirowka dopo un viaggio un po' fortunoso; congedatomi dal mio attendente Giovanni Crucianelli, mi trovai nella nuova sede a Malevanni. Celebravo la domenica in un'aula delle scuole dove aveva preso stanza il Quartier Generale; mi diede fraterna ospitalità il ten. Ennio Corte. Durante la settimana mi portavo ai reparti divisionali che, essendo piccole entità non potevano avere un proprio cappellano, quando venni a sapere che il 79º ftr. mancava del cappellano che era stato avvicendato.
Caricai il mio altarino da campo su una slitta e mi portai all'"Olimpo", il caposaldo dove era intanato il Comando del I Btg. del 79; dico "intanato" perché il mammellone da cui si dominava il fiume, il Don, non presentava esteriormente nessuna struttura; sede del Comando, alloggi dei soldati, tutto era interrato.
Pomeriggio del 15 dicembre. Un ufficiale di artiglieria si sta portando al comando della 3a compagnia, al caposaldo "Venere". «Prendimi con te; da un mese i soldati sul fiume non hanno visto il cappellano». L'ufficiale manovra agevolmente la camionetta, mentre mi fa notare le ferite che i mortai russi hanno inflitto al terreno. «Strano che oggi non sparino. Sono appena di là dal fiume».
Arrivati. L'ufficiale va subito in cerca del comandante del caposaldo. Presto ritorna. «Montano, non ti ho detto che c'è un cappellano con me». Il Comandante, in tono un po' seccato: «Cosa viene a fare?!» Prima ancora di essere presentato gli compaio davanti «Scusa, ma da oltre un mese i ragazzi non hanno avuto la Messa; questa sera li vedo e domattina, all'ora che mi dirai tu, farò la Messa, poi me ne andrò».
Ora mi accompagnano giú per una scaletta; mi sembra di scendere in miniera. Distribuisco le sigarette, confesso: domattina troveremo un momento per la Messa. Una bella tazza di caffè e pane, poi a dormire. Montano si corica vicino a me; si alza, sparisce, ritorna. «Che brutta notte, cappellano». Io non ne capisco niente; non sento uno sparo. «Ma perché una brutta notte»? «Perché non sparano. È la prima notte che passiamo in silenzio. Quelli si preparano per qualcosa di serio».
Montano non si è sbagliato. È ancora buio quando un fragore indiavolato di artiglieria scoppia tutt'all'intorno.
Che povero stratega sono io! adesso sto a preoccuparmi per i russi. Ma dove pretendono di arrivare?! Non capiscono che è inutile bombardare, difesi, chiusi come siamo qua sotto! Già; Montano cerca a tutti i costi il collegamento con "Olimpo" ma ben presto la linea si interrompe. È tanto lontano dal pensare che i russi l'abbiano già occupato; con l'idea di un guasto occasionale, manda staffette. «"Tornate con ordini precisi. Ci dicano cosa dobbiamo fare». E le staffette non tornano.
Adesso tutto si fa chiaro; entriamo in ballo anche noi; anche il caposaldo "Zeta" non risponde piú; anche "Marte"; ora i mortai ci pescano direttamente; ora siamo impegnati faccia a faccia con i russi. Io mi sento in mano la valigetta del mio altarino; povero don Enelio, a chi può interessare la tua Messa; sei capitato fuori tempo; ha ragione Montano.
Mi metto in un angolo dove filtra un po' di luce. Stendo l'altarino, apro il Messale; il 16 dicembre; festa di Sant'Eusebio Vescovo e martire; oggi c'è impegno anche per te. Voi, ragazzi, sapete rispondere alla Messa? La sezione di sanità? Per adesso è impossibile raggiungerla. Siate bravi; vediamo di dirla questa Messa. In nomine Patris ... introibo ... ad Deum qui laetificat iuventutem meam. Dio mio, cosa fai dire a questi poveri figli; ma quale gioia; ma quale giovinezza! «Non ce la fai piú? dove hai la ferita?! Aspetta che finisca il Vangelo».
«Cappellano ci sono altri feriti su nel camminamento». «Falli venire; stringetevi un po'; fate posto anche a loro. Del cognac? Sí che ce n'è, vedi nella mia borraccia». Signore, oggi vedo che cosa è la Messa. Il calice del tuo sangue e del nostro sangue, la tua agonia e la tua morte insieme alla nostra agonia e alla nostra morte. «Tu, per favore, vai ad avvertire su nei camminamenti; forse uno alla volta possono venire a prendere la Comunione».
Eccoli; di corsa arrivano, di corsa partono, con il Corpo di Cristo, che li custodisce per la vita eterna. La vita eterna: oggi sapremo cos'é; oggi, 16 dicembre 1942, festa di S. Eusebio Vescovo e martire. Ricompongo il mio altare; tengo fuori la teca con le particole rimaste e il vasetto dell'Olio Santo. Ad un tratto mi compare davanti il Comandante, che si è messo in perfetta divisa. A me che lo guardo meravigliato dice: il nemico arriva: occorre accoglierlo con dignità. Distrugge tutte le carte del Comando e mi dice: «Vieni, non abbiamo altra scelta; di corsa ci portiamo sotto quel costone e tentiamo di raggiungere il comando di Battaglione». Io, gli dico, non posso venire. Perché?! Perché resto con questi! E indico i feriti. Ma non puoi far niente per loro! Sí, lo so, ma resto ugualmente con loro! Ma vi ammazzeranno tutti. Sí, lo capisco, ma preferisco cosí.
Che cosa curiosa! Se tento di analizzare il motivo per cui scelsi di restare, non mi riesce di rispondere. La paura di avventurarmi in una corsa verso l'ignoto, impegnando Montano a difendermi, dato che io non avevo arma e non sapevo usarla e quindi impedendogli libertà di manovra? O era piuttosto la paura della morte incombente che mi portava a farmi schermo dietro quei poveri figli che ora guardavano a me come a un oracolo? Già: io "mi difendevo" dietro loro e loro dietro di me? O una forza disperata che ci univa, nata in noi dopo quella Messa celebrata insieme? Certo, Cristo al mio posto sarebbe rimasto.
Dopo che Montano ha portato in salvo quelli ancora in grado di seguirlo, siamo rimasti in attesa. Noi non possiamo opporre alcuna resistenza; attendere dunque. Attendere chi? I tedeschi sono nella zona; chissà che non vengano a liberarci. Mi affaccio fuori un momento; pallottole si intrecciano a fior di terra; poi silenzio, mi affaccio ancora: un correre concitato sulle nostre teste; sono arrivati finalmente; ecco un tedesco, l'elmetto lo dice; non esito a gridare: «Ragazzi siamo liberi». Evito a stento una raffica di mitra; altro che tedeschi, sono i russi; non c'è piú niente da fare. La somiglianza fra l'elmetto russo e quello tedesco mi ha ingannato. Ora che hanno visto dove siamo verranno a prenderci; noi non ci esponiamo.
Dopo il lancio di una bomba giú dalla scaletta contro il rifugio che ci rinchiude, sentiamo gridare in perfetto italiano: «Uscite fuori; hanno già catturato anche noi del caposaldo Zeta».
Sono all'aperto; mi sento intimare: «Ruki vièr!» («Mani in alto»).
Ho stampata ancora vivissima la prima ora della mia prigionia. Erano giovanissimi i soldati dell'Armata Rossa che ci avevano catturati, ma si sono comportati da veterani nella diligenza con cui ci hanno perquisiti. Dev'essere un rito istintivo ed antichissimo quello del vincitore che mette le mani addosso al vinto e lo spoglia di tutto; ma è un gesto che ti demolisce e ti avverte all'improvviso che tutto per te è cambiato, che non ti appartieni piú; non c'è piú niente in te che meriti rispetto e la tua vita dura fino a quando l'altro non sia stanco di giocare. Tua madre? Eccola lí sulla neve, e quando tu ti chini per raccoglierla una mano te la strappa via e te la straccia sotto agli occhi. Il tuo altarino da campo? Povero ingenuo! Come puoi pensare che te lo lascino?! E se fai il tentativo di raccogliere almeno il crocifisso, il calice, ti arriva una pedata maiuscola che ti rovescia per terra.
Ora, due occhi di bambino mi fissano e una domanda mi inchioda: «Skolko caputt?!» («Quanti ne hai ammazzati oggi?!»). Il russo vuole che risponda subito e mi guarda fondo e non permette che io mentisca; il mitra in mano gli balla, puntato per eseguire la sentenza. «Quanti ne hai ammazzati oggi?!» E io ti guardo, soldatino dell'Armata Rossa e mi è estremamente facile sostenere il tuo esame; se proprio volevi ammazzarmi, non dovevi farmi questa domanda, perché non ho ammazzato nessuno, né oggi, né ieri: «ià nisnàiu striliàt», io non so sparare, gli dico con la gioia di chi esce all'improvviso da un incubo. Senza volerlo mi hai messo in mano l'unica arma con cui posso difendermi; e tu ti accorgi che io sono sincero. Il soldatino è impacciato sotto il mio sguardo che gli dice: - se vuoi essere coerente, non puoi sparare; io non ho ucciso e tu non puoi uccidermi -. A toglierlo dall'imbarazzo sono i suoi amici che hanno scoperto in fondo a un camminamento del "Venere" la marmitta del rancio che il nostro cuciniere aveva regolarmente confezionato. Chiamano anche lui a dividere il bottino.
Quando oggi leggo della "buona cucina italiana nel mondo", con un accostamento grottesco, rivedo quei soldati che si sono dimenticati di noi per correre a dividersi fino all'ultimo sorso il fumante minestrone del caposaldo "Venere".
È già buio quando ci mettiamo in marcia. La tensione rallenta e posso accorgermi del freddo che si fa intenso; avverto lamenti di feriti non raccolti: - sono i nostri? - sono dei loro? Ma perché li lasciano gridare cosí?
Truppe fresche salgono dal fiume, si incrociano con noi; sono artiglieri, ci passano accanto, ora siamo quasi gomito a gomito. Ci guardano, non con disprezzo, non un insulto; non dicono niente. Qualcuno sembra ci invidi come a dire - per voi la guerra è finita -. Sento una pena enorme per noi e per loro; che cosa mostruosa è la guerra! Un ufficiale ci ferma e ci intima: «Giú le mani! Perché le tenete in alto? Tenetele giú e mettetele in tasca». Le guardie di scorta non dicono niente. Mi hai salvato le mani, giovane ufficiale dell'Armata Rossa, mi hai salvato la vita.
Sí, adesso siamo sul fiume. Il ghiaccio resisterebbe al passaggio di un carro armato. Quando stiamo per risalire qualcuno incespica: «Davai, davai» ci incalzano le guardie. Davai, davai - avanti, avanti; dovremo abituarci a sentire "davai"; ce lo grideranno con rabbia, ce lo diranno con calma, ma da ora in poi, ogni giorno fino a quello del rientro, avremo sempre la nostra razione di "davai".
Da quante ore camminiamo nel buio bianco della neve? Ci fermiamo finalmente. Ci stipano in una stanza. Possiamo guardarci in faccia; io non conosco nessuno; i fanti del 79º "Pasubio" non li avevo mai visti. «Sapete chi sono? sono un cappellano. ero al "Venere"; potevo andarmene, ma sono restato volontario per voi». Si voltano verso di me e la riconoscenza che mi manifestano è tale che mi fa nascere dentro una gioia mai provata.
Ora ci ammucchiano in un'isba; qualcuno aveva tentato di appisolarsi, quando si spalanca la porta e uno dei nostri guardiani ci urla forse un ordine. Nessuno di noi si muove; nessuno ha capito niente. Ma afferra il primo sulla porta e lo trascina fuori. Poi viene a prenderne un altro, un altro ancora. Arriva il mio turno. Fuori nel buio della notte vedo le guardie indaffarate; mi tolgono il cappotto e strappano la pelliccia e mi ridanno il cappotto. L'operazione è rapida; in pochi minuti è finita. E adesso? Adesso davai, camminare. Forse è già cominciato il 17 dicembre; ma che importa ormai sapere che giorno é; che importa sapere dove andiamo; io mi sento una foglia a galla di una corrente che mi trascina.

Colonna di prigionieri italiani in Russia
La fotografia è stata tratta dall'Elenco ufficiale dei prigionieri italiani deceduti
nei lager russi, fasc. I, 1986, 12.
L'interrogatorio
Mi fu fatto la sera del terzo o quarto giorno. Ci avevano messo in marcia dopo una breve sosta in un villaggio ma la meta da raggiungere doveva essere lontana se le guardie bloccarono un automezzo e ci fecero salire. Cominciarono ore di spasimo: il freddo che non eravamo riusciti a vincere nella marcia, ci afferrò ora in maniera totale; non era piú freddo, ma gelo. Quando l'automezzo si fermò era già tornata la notte.
Ora siamo fermi davanti a un'isba di un alto comando. Le guardie ci fanno capire che dovremo essere interrogati, ma bisogna aspettare; lí, fuori all'aperto, davanti alla porta. Le guardie ci provano a stare con noi: hanno un cappotto di pelliccia che scende fino ai piedi; in testa hanno un basco spesso di lana ricciuta; agitano le braccia incrociandole, battono i piedi affondati in stivali di feltro imbottito di pelliccia, ma non ce la fanno e ottengono di entrare. Ci lasciano soli; e dove potremmo fuggire? Soli col cappotto ridotto a un velo, con in testa la bustina ad ali abbassate, ai piedi... io veramente ai piedi ho stivaletti di feltro che i russi non mi hanno tolto perché sono rotti.
Io sapevo cos'era il freddo ai piedi, alle mani, agli zigomi; ma il freddo che prende la testa, gli occhi, la schiena, le gambe, che ti fa sentire nudo, ferito in tutte le parti e non hai difesa e dalla bocca paralizzata ti esce un lamento come quello del cane e dondoli bilanciandoti e sai che nessuno avrà pietà di te...
La porta si apre; appare l'interno, dove gente siede attorno ad un'enorme stufa. Uno di noi entra, fortunato lui, ma siamo in tanti, chissà quando verrà il mio turno.
È proprio vero che ogni calvario ha il suo cireneo; una guardia dall'interno ci allunga un barattolo di acqua bollente e non chiude ermeticamente la porta, cosí.. a turno, possiamo incollarci alla fessura e respirare una boccata di aria calda.
Quando finalmente posso entrare e mi mettono a sedere, sento per chi mi siede di fronte un'infinita gratitudine. Ora, per favore, durate il piú possibile a interrogarmi. Preoccupazioni di tradire segreti militari non ne ho; della "Pasubio" in particolare non potevo saper nulla perché ero lí da poche settimane. Tenetemi qui ancora un po', non mandatemi fuori a morire.
Gli occhiali
Stiamo attraversando un villaggio. C'è il sole e la neve acceca. Escono le donne dalle isbe e ci guardano senza commentare. Siamo ripugnanti; da oltre una settimana la barba ci cresce; mai un goccio d'acqua per lavarci; qualcuno di noi si trascina per i piedi congelati. Io guardo le donne e leggo in loro una pena che non possono esprimere; temono la reazione delle guardie che ci scortano. Ma c'è un vecchio che si fa avanti deciso. Cosa cerca? Le guardie lo fermano ma lui dice qualcosa e viene avanti e viene da me e mi sfila gli occhiali e se li mette con naturalezza come se li avesse sfilati da un manichino. Io dico no e mi copro gli occhi, per il bagliore della neve, adesso per me intollerabile, ma ben piú perché la fortissima miopia ora mi impedirà di seguire il gruppo e le guardie mi faranno fuori. Ma gli occhiali non gli vanno bene; è dispiaciuto il vecchio, scuote la testa e me li restituisce. Non è arrabbiato; mentre si allontana mi guarda come per dire: se mi servivano non potevo lasciarteli; ma si vede che c'è una Provvidenza anche per te.
È facile a quelle donne indovinare la fame che ci dilania; il nostro passo denuncia una fiacchezza che è sfinimento. Una si fa coraggio e si accosta a noi con un pezzo di pane. La guardia grida e la minaccia col calcio del fucile. La guardiamo scappar via, ma che fantasia, che cuore, che coraggio, donna mia! Poco dopo eccola davanti a noi che fugge ancora e si volta indietro; la vediamo gettar per terra il pane. E il pane, una briciola per ciascuno, non va perduto. Le guardie non si sono accorte di nulla.
Alla sera in una stalla ci difendiamo dal freddo approfittando della paglia. Le guardie se ne sono andate in qualche isba, quando entra un colcosiano con un secchio e un cartoccio. Si ferma davanti a noi, vuole che gli confermiamo che siamo italiani e ci invita a cantare Verdi, Rossini. Ma che cosa sa questo "mugik" del nostro Verdi, del nostro Rossini?! Ci fa capire che è un grande ammiratore dell'Opera italiana che conosce attraverso i dischi e non gli par vero di potersi gustare qualche romanza cantata dai parenti stretti di Verdi e Rossini. Noi guardiamo il secchio e il cartoccio e lui dice che se canteremo, mangeremo: altrimenti, "niet"! Niente. È deciso e sicuro: se non si canta non si mangia. Ma chi ha voglia di cantare figlio mio, in queste condizioni!? Eppure vi dirò che abbiamo cantato. Abbiamo cominciato con "La donna è mobile" e poi tutto quello che potevamo ricordare, fino a quando quel benedetto secchio non si è mosso e il cartoccio ci è stato distribuito. Anche oggi, grazie a Verdi e Rossini, non siamo morti di fame.
Il 24 dicembre 1942
È già buio quando arriviamo a Kalach. Seguendo le albe e i tramonti possiamo stabilire che è la vigilia di Natale. L'ora non potremo piú saperla perché l'ultimo orologio che uno di noi aveva salvato, è stato venduto poco prima di arrivare a Kalach. Una guardia si è accostata ad ognuno della nostra colonna chiedendo se avevamo anelli, penne stilografiche, orologi, e promettendo in compenso pane, "klieba". «È qui il pane» e mostra una pagnotta da sotto il pelliccione. Ma a chi vuoi darla ad intendere, bel giovane! Se io ti mostro un orologio lo strappi e non mi dai niente. Ma perché, senza tante storie, non mi perquisisci?! Sono i pensieri dei nostri che sono riusciti a salvare ancora qualcosa. In verità quella guardia non perquisí nessuno e riuscí a convincere quello di noi che aveva ancora l'orologio a cederglielo e vedemmo increduli una bella pagnotta di pan nero passare nelle mani del nostro amico. Chi ne capisce qualcosa di questi russi! I primi ci hanno denudati; questi contrattano con noi e rispettano i contratti.
Ora sto per rivivere con voi una delle ore piú angosciose di quella vigilia di Natale. Ci avevano fatto attraversare alcune vie di Kalach fino a farci raggiungere una botola che si apriva su un marciapiede. Saltiamo dentro uno alla volta, stipandoci in uno stanzone buio. Pigiati uno addosso all'altro. La botola si chiude pesantemente togliendoci il piú piccolo filo di luce. Lo so che è la vigilia di Natale; anche i miei amici lo sanno, ma nessuno ne parla; io ne provo rimorso; ho l'impressione che i miei amici si scandalizzino: come mai il cappellano non ci dice niente. Ma io non ce l'ho fatta; eppure il vero Natale era quello: in una tana buia, lontani da casa, spogliati di tutto. La botola si apre; chiamano fuori qualcuno; constatiamo che sono gli ufficiali superiori; questi s'affrettano salutando; quasi chiedono scusa se li attende un trattamento di riguardo. Poco dopo la botola si riapre; arrabbiati e indispettiti li gettano giú come sacchi, i nostri ufficiali superiori. «Pensando che potessimo nascondere chissà che cosa, ci hanno minuziosamente perquisiti e siccome non hanno trovato niente, ci hanno bastonato». Intanto le ore passano e nella tana si ha l'impressione che manchi l'aria. «Io mi sento soffocare», dice uno, «anch'io», dice un altro. «Qui manca l'aria... l'hanno fatto apposta per farci morire». La tana in breve diventa una bolgia; il panico ci prende tutti. Una voce grida: «Io ho un fiammifero. Facciamo la prova. Se si spegne subito vuoi dire che manca l'aria». Lo sfrigolio del fiammifero e una goccia di luce appare, subito spenta. «Manca l'aria, manca l'aria». Ci sentiamo dei condannati a morte e nasce in noi una reazione violenta. «Aprite, aprite». Ora siamo diventati belve e gridiamo disperati, mentre i piú vicini alla botola battono i pugni sul legno «aprite, aprite». Evidentemente i russi si sono preoccupati ed hanno spalancato la botola. Un'onda fredda ci investe, siamo salvi. Fino a qual punto fosse sogno o realtà quella mancanza d'aria anche oggi non lo saprei dire; so soltanto che era la notte di Natale.
Il fenomeno si è ripetuto la notte seguente e con maggiore violenza. Io mi sono trovato a galleggiare, stretto nel fascio dei miei amici, tutti protesi verso l'uscita. Ho avvertito che mi si stava sfilando uno stivale, ma era impossibile far scendere anche una sola mano per fermarlo, tanto ero bloccato in tutti i movimenti.
Santo Stefano 1942
Una mattina splendida, trasparente; un gelo da gran Siberia. Il pezzetto di pane che ci distribuiscono diventa presto un sasso da rosicchiare. Io non lo mangio il pane, anche se la fame è estrema, perché ho il problema dello stivale; non l'ho ritrovato e sento il gelo che mi afferra il piede appena velato da una calza bucata. È finita per me; ma dove sarà andato quel benedetto stivale?! Faccio cenno a una guardia: mi manca lo stivale; riesco a dirgli che l'ho perduto durante la notte. Mi dice di seguirlo. Scendo e guardo in ogni angolo. Non c'è niente. Che faccio? Non posso far attendere di piú la guardia che è stata fin troppo gentile e che si è presa l'arbitrio di portarmi a cercare. «Niet, niet» dico sconsolato, mentre risalgo. Do un'ultima occhiata indietro. Mi pare di vedere emergere un rozzo disegno; faccio un balzo e scrosto il terreno. È il mio stivale. Pestato e ripestato, aveva fatto corpo unico col fondo. Il gelo, entrando, aveva fatto lievitare il terreno.
In guerra succede di tutto: si uccide e non se ne ha rimorso; si rischia per salvare un nemico, senza attendere un grazie. È certo che a quel soldato, che dopo avermi ricondotto nel gruppo è andato a giustificare al suo capo la sua assenza, io non ho detto "spassiba" grazie! E lui non me l'ha chiesto. Glielo dico adesso e il mio grazie lo raggiunga ovunque egli sia, in terra o in cielo. Il suo gesto mi ha salvato la vita.
I trasferimenti in treno
Tutto il 26 dicembre lo abbiamo impegnato in una lunga marcia di trasferimento; per raggiungere una stazione ferroviaria. Cielo pulito, bagliore accecante della neve, fame. Il pezzetto di pane da rodere è finito ben presto ed abbiamo sentito necessità di mettere sotto i denti qualcosa di solido; la neve, sí, abbiamo tentato di considerarla farina, manna; ma era neve e non ci diceva niente. Il ghiaccio! Quello può andar bene. Il ghiaccio è duro: i denti hanno il loro impegno; e poi suona in bocca come se fosse crosta di pane; si può masticare, si mangia; l'importante è "mangiare", mordere qualcosa. Ma non è sempre facile rasentare gli orli dei pozzi per allungare la mano e staccare qualche "candelotto".
Non ho piú dimenticato qualcuno dei miei amici che furono con me fino alla notte del 31 dicembre '42 nel carro bestiame. Il capitano Gullino, che era il piú alto in grado e quindi automaticamente nostro capo; Damiani, Mangone, Berti, Abbamonte, Maltese, Becchina.
Il carro era diviso in due piani; stipato sopra e sotto; nel mezzo, in corrispondenza dei due portali scorrevoli c'era la stufa senza legna. Nell'assito un buco che serviva da gabinetto. Fu per noi una festa quando ci gettarono nel carro pane e pesce salato. Ci fu un po' di confusione e di liti, ma si riuscí a distribuire e tutti avemmo un pensiero: se ci danno da mangiare è possibile continuare a vivere. Notammo infatti che la razione era sufficiente per sopravvivere; e io mi accorsi anche di un'altra cosa: che fino a quel momento non avevo pensato né alla possibilità di vivere né di morire: avevo pensato a niente, come se la stessa idea di morire che era quanto mai logica, fosse un lusso che non mi potevo permettere perché qualsiasi attività anche di pensiero, comportava un consumo di energia e allora, d'istinto, mi ero messo in riserva assoluta. Adesso dunque si può pensare alla possibilità di vivere; ma fu per tanti di noi l'inizio di una orribile fine. Il pesce salato scatenò la sete e non avevamo niente da bere. Quando mi ero trovato precedentemente in un vagone semivuoto, per lo scarso numero degli occupanti, le alte pareti di legno non avevano perso il grosso spessore di brina e i bulloni erano coperti di ghiaccio; raschiando la brina e succhiando i bulloni (con cautela: le labbra potevano spellarsi a contatto col ferro "arroventato" dal gelo), un rimedio si era trovato; i piú lunghi raggiungevano su in alto la brina e ne facevano parte a chi, come me, godeva di un raggio piú limitato. Ma in questo vagone, stipati come siamo, tutto il ghiaccio si è sciolto; chi ha tentato di allungare le mani fuori dalle fessure per afferrare i pendagli di ghiaccio, si è sentito urlar dietro dalle guardie e magari sparare.
«Vodà, vodà» («acqua, acqua») è il grido che ad ogni fermata del treno si scatena, mentre arriviamo a stabilire un turno per ritmare il grido battendo i pugni sulle pareti del vagone. Vodà, vodà; e ad una fermata il vagone si spalanca e una guardia mette su in fretta un secchio d'acqua e rinchiude. È arrivata l'acqua; si muove una valanga: ci troviamo tutti in piedi uno addosso all'altro. Povera la nostra acqua, come sei sparita all'istante! Eccolo lí il secchio: capovolto. E adesso? Se tornassero a darci acqua?! «Cappellano, sarai tu a fare la distribuzione». Non riceverò mai piú in vita mia una consegna di tanta responsabilità e di tanto onore.
Le guardie ci riportarono un secondo secchio pieno. L'istinto fece balzare ancora tutti come prima; ma forte del mandato, io feci un grido e alzai le braccia: guai a chi tocca il secchio. Tutti si fermarono e si fece silenzio. Il secchio era lí, con la sua acqua dove galleggiavano carbone e olio; l'avevano attinta alla macchina del treno. Immersi il gavettino e cominciai la distribuzione. Non ho mai visto gente venire alla Comunione con il rispetto e la devozione con cui in quel momento i miei amici prendevano dalle mie mani quell'acqua. Sorseggiavano adagio, stringendo il gavettino; un silenzio profondo si era fatto intorno. Anch'io bevvi il mio gavettino; la tensione dell'incarico non mi impedí di gustare quella salvezza; poi ancora un giro con poche gocce a testa di supplemento; un grazie corale mi giunse da tutti alla fine del "rito". Quanto tempo sia passato fra la prima e la seconda bevuta, non saprei dire. Il vagone si riaprí e la guardia questa volta disse: scenda uno per andare a prendere l'acqua. Non ci fu contestazione; Cappellano vai tu.
Non me lo feci ripetere; col secchio attraversai i binari. Gente circolava libera sul marciapiede e vidi che molti andavano ad attingere acqua ad un rubinetto fumante. «Tiòplaia vodà», («acqua calda»), dissi alla guardia. «Fammi riempire là». No, l'acqua calda non era per noi; e mi portò ad una fontana che per salirvi si richiedeva una certa abilità, per la colata di ghiaccio attorno. Ora il secchio è pieno; lo prendo, scendo, vorrei chiedere alla guardia di poter bere a parte, ma poi tento una manovra: metto il secchio per terra, mi stendo e affondo la faccia a bere nel secchio. Perché mi stendo? Perché se la guardia mi vuol colpire, mi colpisca, mi pesti, ma io intanto bevo. La guardia lascia fare; io mi rialzo, sorrido alla guardia e risalgo per rifare il pieno al secchio. Sono felice! Quando sarò al vagone posso annunciare: Ragazzi, io ho già bevuto; questa è tutta per voi!
E ricordo una terza bevuta; la piú memorabile. Il treno si ferma in aperta landa; notiamo guardando dalla fessura del portale, che davanti a noi scendono vagone per vagone. Arriva anche il nostro turno. Il vagone si spalanca, scendete, venite con noi. Ora siamo in una larga distesa bianca. La guardia fa alcuni passi, ci indica una polla d'acqua: bevete. Sono sorsi di salvezza; a turno ci caliamo sull'acqua e si beve, si beve, si beve. Quello era un fiume; le guardie col calcio del fucile avevano aperto una larga breccia nel ghiaccio. Risaliamo afferrando ghiaccio e cacciandolo in tasca.
Maltese non ce l'aveva fatta a scendere; era rimasto disteso a lamentarsi al centro del vagone: datemi da bere, datemi da bere! Tutti gli passiamo vicino... «Cappellano, dammi da bere». «Maltese non è possibile; non abbiamo borracce; non ci hanno dato il secchio». Si riparte; ora l'unica voce è quella di Maltese: datemi un po' di ghiaccio. E poi anche la sua voce si affievolisce; nessuno si è mosso. Io mi alzo e nella bocca aperta gli lascio cadere un pezzetto di ghiaccio. Sento il rimorso di non essermi mosso prima e ora vorrei che nessuno, lo stesso Maltese, mi vedesse. Ma lui apre gli occhi. «Grazie, cappellano, grazie».
Torna il silenzio, mentre anche Maltese ora morde il suo ghiaccio. Non mi è ancora passato il rimorso per quella mia avarizia. Maltese, mi sento confuso quando ripenso a quell'ora; tu poco piú tardi, morivi: credo che fu l'ultima tua voce il tuo «grazie cappellano». Ma non lo meritavo, assolutamente no; ben piú che un pezzetto di ghiaccio avrebbe dovuto offrirti il cappellano; o, forse, in quel momento, povero diavolo anche lui, non riusciva a darti di piú.

Attuale cimitero di Oranki (campo n. 74) nella regione di Nisnij Novgorod (Russia)
La fotografia è tratta dalla pubblicazione del
Ministero della Difesa, CSIR-ARMIR. Campi di prigionia e fosse comuni, Gaeta 1996, 74.
Berti, Damiani, Abbamonte
Dal 7 al 19 febbraio '43 durò il nostro secondo viaggio in treno; dal campo 188 di Tambow ci trasferiscono al campo 74 di Oranki. Stessa situazione del viaggio precedente: ancora il dramma della sete. Vedo Berti con un gavettino pieno; lo tiene in mano, guarda e fa per bere. Chi ti ha dato quell'acqua?! Cappellano, mi dicono, sta bevendo l'urina. Gli sbatto per terra il gavettino. Berti mi guarda e non dice niente; è "partito". Eppure si salverà; non solo, ma quando ci troviamo nei raduni, mi ricorda sempre l'episodio: era dunque cosciente di quel che faceva. Damiani no, non si è salvato; una mattina ha steso le mani sulla stufa spenta al centro del vagone ed ha cominciato a dire: "Come si sta bene, che caldo; come si sta bene"; e si fregava le mani. È caduto per terra poco dopo e non si è piú rialzato. Quando qualcuno stava per morire (anche in questo viaggio avevano delegato me nel vagone come punto di riferimento) gli altri mi venivano vicino... "Cappellano, vedi che ho le scarpe rotte, dalle a me le sue scarpe... a me servirebbe il suo cappotto... la sua camicia di flanella...". "Dite piano; non è ancora morto; abbiate pazienza!...". "Cappellano, adesso è già morto". E allora chi era senza scarpe si prendeva le scarpe e cosí via e quel povero figlio, cui era rimasto l'unico conforto di aiutare morendo i suoi amici, veniva messo lí, da una parte, coperto alla meglio da qualche straccio. E continuava ad essere utile; perché nel vagone le razioni entravano in ragione del numero e ci guardavamo bene dal dire che era morto: lui dormiva.
19 febbraio: scendiamo dal treno e via a piedi verso il nuovo campo di concentramento. La strada è lunga e Abbamonte non ce la fa. Comincia a perdere terreno e le guardie incalzano "davai, davai". In due lo sorreggiamo "Abbamonte, non puoi arrenderti adesso. Pensa a casa; gliela devi fare per loro! Per tua madre che t'aspetta: il campo è vicino...". "No, lasciatemi, non ce la faccio piú". Abbamonte si accascia lungo la pista. Noi lo stimoliamo; ma la guardia gli si fa sopra col mitra spianato. "Vedi? Ti spara se non ti muovi"! Il tuo volto, Abbamonte, in quel momento! non una smorfia, non una contrazione; anzi, si illuminò; e continuavi a dire: "sí, sí, sparami per favore"! Invocavi la morte che ti liberasse e chiedevi alla guardia che facesse presto. Avevamo perso il contatto con la colonna; la guardia ci fece cenno perentorio di raggiungerla e rimase sola col mitra puntato su Abbamonte. Poco dopo udimmo la raffica.
Arrivammo al campo; con nostra meraviglia dopo di noi vedemmo giungere una slitta che aveva raccolto quelli che erano rimasti disseminati lungo il cammino. Sulla slitta c'era anche Abbamonte: la guardia aveva sparato a vuoto per intimidirci. Abbamonte morí il giorno dopo.
La Messa secca
La chiamammo cosí la Messa celebrata senza pane e senza vino in una stanza del campo n. 74 di Oranki. Per un momento ritorno al campo 188 di Tambov. A Tambov specialmente, dove la baracca era diventata una bolgia e i nervi a fior di pelle rendevano furiosi i piú miti, come potevo dire: "Ragazzi, preghiamo"! Urla, imprecazioni, bestemmie... chi mi venne in vicino e mi disse: "Cappellano, perché non diciamo il rosario?". I rosari di Tambow nessun regista, nessuno scrittore, nessun artista riuscirebbe mai a ritrarli. Quando io, raccogliendo quella voce, cominciai a gridare: "Ragazzi, qualcuno mi ha chiesto di dire il rosario, io non so quale miracolo abbia portato il silenzio; è stato uno stupore generale, come se nessuno sapesse piú com'era fatto il silenzio. Ed io ho intonato: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti... ho sentito la mia voce; dai ripiani, nella penombra fumosa ho visto le teste che si sporgevano e occhi orientati verso di me; ho sentito voci affratellate, a dire insieme "Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae". Era un sogno per me e per i miei amici; potevamo goderci una tregua, un riposo; la preghiera ci ridava una dimensione umana. Da quella sera era stato agevole per me invitare alla preghiera: era una mezz'ora attesa anche da chi non sapeva l'Ave Maria, mentre io riacquistavo coscienza della mia importanza; quella pausa di mezz'ora dipendeva da me, dal mio Rosario ed era l'unica cura al delirio che ci esauriva.
Ma ora siamo al Campo 74 di Oranki. "Cappellano, dicci la Messa". "Non è possibile manca il pane e il vino"! Mancavano tante altre cose: il messale, i paramenti; ma avvertii subito che le estreme contingenze in cui eravamo, potevano dispensarci dal messale, ad esempio; il canone lo sapevo a memoria. Ma il pane di frumento e il vino d'uva non si potevano rimpiazzare. "Dicci la Messa senza pane e senza vino". E un bel giorno io cominciai la Messa senza pane e senza vino: la chiamammo la Messa secca. Seduto sul mio assito, gli amici seduti o sdraiati all'intorno, cominciai il salmo "Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta..." Quelli che non sapevano rispondere guardavano i fortunati che rispondevano, con una punta d'invidia. "Kirie eleison ... Gloria in excelsis Deo..." tutto bene. "Oremus" e qui ci voleva il messale ma me la cavai benissimo "Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde..." l'Oremus dell'Angelus Domini. Adesso c'è l'Epistola: la lettera di un apostolo... Adesso c'è il Vangelo... Feci il riassunto di non so piú quale lettera di S. Paolo e di quale brano del Vangelo. Dopo il Vangelo, l'Offertorio. C'era da offrire il martirio del Capitano Testone Enrico cui Reginato e Ioli avevano amputato un piede in cancrena con una lametta da barba. Gli avevano detto: "Se non ti lamenti, ti diamo una sigaretta". Finita l'amputazione il Capitano Testone sorrise e gli diedero davvero una sigaretta.
Anche quel sorriso trovò il suo posto all'Offertorio della Messa secca. Al Memento dei vivi c'era stato un attimo di smarrimento perché il pensiero delle nostre famiglie riuscí a superare la prostrazione fisica; al Memento dei morti ricordammo quelli che nella notte ci avevano lasciato. Poi la Comunione spirituale secondo la formula che ricordavo dal Seminario: "Credo, Gesú mio, che voi siete realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare..." La Messa finí fin troppo presto; l'avevamo gustata tutti e la ripetemmo fino a quando non ci rimandarono al Corpus 2 che era quello degli italiani. Dove ci trovavamo in quel momento era l'infermeria: luogo privilegiato dove tutti cercavano di arrivare perché si godeva di un qualche vantaggio. Prima che ci smistassero, morí Castelletti che diceva di essere figlio del Podestà di Varese; un ragazzo mite, fra i piú solleciti nel "servire la Messa". Io mi meravigliai moltissimo della sua morte; pensavo che si poteva morire solo di fame e di sete e lí l'acqua non mancava e neppure un po' di broda calda. Partecipa alla "Messa secca" uno che dice che vuole levarsi la fame. Per due giorni non tocca la fetta di pane che è la razione giornaliera. La mattina del terzo giorno stende davanti a sé le tre fette di pane. Noi lo invidiamo: può mangiare tre fette di pane! Al terzo boccone, piega la testa in giú. È morto. Troppa fatica masticare. Al Corpus 2 una sera il dotto Reginato che rientrava dalla "infermeria" disse: È scoppiato il tifo. E che cos'è il tifo? È un'infezione portata dai pidocchi. Si muore? Sí, può essere anche mortale. Il dialogo finí lí fra l'indifferenza generale; per il solito motivo: avevamo esperienza della morte solo per fame e sete; i pidocchi ci avevano fatto buona compagnia fin dalle prime settimane di prigionia: che significa morire a causa dei pidocchi?
Il tifo
I pidocchi ci fecero morire perché erano infetti. Pungevano come fanno tutti i pidocchi di questo mondo e noi, massaggiandoci (veramente si dice in altro modo qui a Bologna! grattandoci) finivamo per far entrare l'infezione nel sangue ed era la febbre, il delirio, la morte. Reginato cominciò ad annunciare i primi decessi ed allora fui io che al Corpus 2 dissi una sera: "Diciamo il Rosario per quelli che sono morti oggi". Mi seguirono tutti: Bassi, Martelli, Savastano, Tonolini, Codeluppi, Nannini, Lunardini, Ferretti, Monastra, Diliberto, Viroli... Certamente io esagero; qualcuno forse non pregava; Palmieri per esempio si era messo a far ginnastica con flessioni fra due "castelli" come se fosse alle parallele. Ma quando terminammo, mi venne vicino e mi disse: "Cappellano, spiegami un po'; mi pare di aver sentito. Rosa mistica... Turris eburnea... Stella matutina... Ma questa è poesia..." e vivamente mi pregò che gli ripetessi le litanie che non finiva di gustare. Mi disse che gli dispiaceva di non poterci accompagnare perché era ateo; chiese se per caso non disturbasse quella sua ginnastica. Non disturbava affatto.
Palmieri era fra noi il piú vivace di intelligenza; di estrema simpatia quando si metteva a reggere una conversazione. Nel 1946, ritornati dalla prigionia, immaginate dove lo ritrovai! sulla soglia del tempio della Madonna di Pompei; io entravo e lui usciva. Ero a Pompei per incontrarmi con l'amico don Giannone. "Palmieri! Sei tu davvero? Ma che ci fai tu qui"? Palmieri per nulla imbarazzato, ha riso e mi ha fatto capire che la suggestiva poesia ascoltata ad Oranki era diventata anche per lui umile preghiera alla Vergine: "Sono venuto qui a pregare". Dietro al Corpus 2 di Oranki c'era una lunga baracca dove prima di prendermi il tifo, avevo servito come infermiere; là venivano portati gli infetti. Il Comando del campo mi aveva autorizzato a questo compito che consisteva nel portare al bagno i malati, distribuire la zuppa e il pane; per me era molto comodo perché potevo dire una preghiera in piú accanto a chi moriva, e mangiare quello che i malati non mangiavano; ricordo bene che ero ancora abbastanza in forma per interrogarmi con una domanda pertinente: stai volentieri in questa baracca perché puoi fare il cappellano o perché mangi di piú?! Mi rispondevo che era per fare il cappellano; ma anche il secondo motivo aveva la sua parte. Siccome i russi temevano molto il tifo, cercavano di combatterlo; e uno dei mezzi era la pulizia e quindi il bagno.
Ogni settimana i malati dovevano lavarsi; dovevano raggiungere una baracca apposita attraversando il cortile. L'ora del bagno diventava un incubo; nessuno voleva uscire nel gelo del cortile. Qualche anno fa ricordavo ancora il nome del mio amico tremante di freddo che accompagnai e che aiutai a stendersi sul pancone di legno al centro del bagno e che morí mentre io lo lavavo. Per quanto avessi detto alle ragazze russe addette al bagno, che quell'amico stava male, non era stato possibile evitargli quella tortura; soggette esse pure a controlli, guai se fosse risultato che qualcuno non aveva fatto il bagno; che era poi una cosa ridicola, perché per lavarsi c'era solo un catino d'acqua a testa; qualcuno le prime volte quell'acqua se l'era bevuta. Il capitano Gabriele Gherardini ce l'ha fatta a sopravvivere; mi voleva sempre vicino e mi diceva: cappellano, come mi trovi? Bene, capitano; ha un bel colorito e poi lei ha sempre il morale alto. Dicevo cosí perché mi pareva l'unico linguaggio che il capitano potesse gradire. Ce l'ha fatta il dr. Saieva, don Caneva, don Giannone: non ce l'ha fatta il dr. Franchi, un giovane medico di grande nobiltà d'animo e di grande dolcezza: non ce l'ha fatta Mimmo Monticelli. Mimmo Monticelli!
Una mattina mi chiamò e mi disse: "Cappellano, io muoio". Io lo guardai; aveva tanta consapevolezza negli occhi che io non riuscii a dirgli niente. "Cappellano, non avrei mai pensato di morire cosí... quando venni in Russia sapevo che in guerra si può morire, ma non cosí... io ho perso degli amici; sono caduti combattendo, correndo, gridando... Guarda dove mi tocca morire... che squallore, che vergogna...". Io lo ascoltavo e non so cosa mi abbia letto in faccia; l'ho sentito ancora che mi diceva: "...fa niente; è la stessa cosa... dopo tutto, qui come là, faccio sempre il mio dovere... e Dio lo sa...". Si spense stringendo forte le mani. Mi fermai accanto a lui per una preghiera piena di angoscia e di stupore; quel ragazzo di vent'anni moriva con una dignità che mi affascinava. Intanto le mani si erano aperte; notai che un infermiere romeno si era accostato come per afferrare qualcosa. Feci in tempo a fermarlo; stava per portar via una piccola bandiera tricolore: Mimmo l'aveva tenuta stretta in mano come per attingere di lí la forza e il coraggio. Ora di Mimmo ho una foto che sua madre mi diede quando al ritorno in patria andai a trovarla a Fossano. È in divisa da alpino e sul cappello spunta appena la penna. Il volto è di un bambino, pulito e senza inganno; gli occhi mi fissano e io sento le parole della sua morte.
Il tifo non porta particolari sofferenze; quando prese anche a me, avvertii l'ubriacatura di una gran febbre; mi mandarono a fare il bagno dove presi un freddo da morire, mi fecero attraversare un cortile, nudo, con una coperta addosso e fui indirizzato, non alla baracca che conoscevo, ma ad un edificio del campo, anche quello pieno di malati. Passò un medico tedesco che mi scoprí l'addome, ricoprí in fretta dicendo "tifus". Io mi guardai l'addome e lo vidi chiazzato di macchioline rosse. La febbre mi portò al delirio e io mi tenevo la mano al polso e sentendo il battito veloce pensavo: "Senti che febbre ha questo poveretto". Reginato mi spiegò poi che il fenomeno dello sdoppiamento per cui si ha l'impressione di essere uno a custodire l'altro, è tipico del tifo. Non avevo piú fame e potere allungare la razione di pane nero agli amici che riprendevano a vivere accanto a me, era un gesto che compivo con molto compiacimento, anche se non mi costava niente. A gomito con me, sul legno che fungeva da letto, c'era un tedesco; anche se avessi saputo la lingua, penso che non mi avrebbe dato udienza, assorto come era a risolvere il suo problema di non morire. Io lo ammiravo perché ce la metteva tutta: anche lui non aveva fame, ma concentrato in sé stesso si sforzava; un boccone di pane, masticava, e finalmente inghiottiva. Quando morí io non me ne accorsi; continuarono a mettergli vicino la razione di pane ed io la prendevo per darla agli amici. Lo portarono via un mattina, seguendo il rituale che era uguale per tutti ed era molto sbrigativo. Venivano in due con una specie di barella, denudavano il morto, lo coprivano con un panno e via.
C'era in un angolo dell'edificio centrale del campo 74 uno scantinato e lí si scaricavano i morti. Prima che il tifo mi fermasse era capitato anche a me una volta di andare là con la barella. Il mucchio era molto alto e allora mettemmo in atto una particolare manovra: tu lo prendi dai piedi, io dalle mani, lo dondoliamo, uno-due-tre e via: e un altro povero figlio volava sulla catasta. Era una cosa orribile: ossa aride; braccia spalancate, gambe rattrappite, teste all'ingiú, mani ad afferrare il vuoto: composizioni da incubo come se il genio del male avesse voluto divertirsi. Di notte venivano con una enorme slitta tirata dai cavalli; liberavano lo scantinato per far posto a quelli del giorno dopo; portavano fuori dal campo e affidavano i morti alla prima cuna del terreno; ma anche volendo non ci si poteva gettar su neppure una manciata di terra; era troppo il gelo; solo la bufera poteva intervenire con il suo velo di neve a difendere dai corvi quei poveri resti di umanità. Anche Santoro ha il tifo; sta male; è morto, dicono gli amici della sua stanza. Un medico conferma. Arriva Bedogni con la barella; vi stendono Santoro e lo portano allo scantinato. Ma i due barellieri si stancano e lungo le scale Bedogni dice all'altro di fermarsi perché non ce la fa piú. La barella viene abbassata sui gradini. Mentre riprendono fiato, Bedogni guarda la coperta e dice: "Mi pare che si muova!" "Se è cosí - dice l'altro - torniamo indietro". Santoro era ancora vivo; si è ripreso; è ritornato in Italia con noi. Se i due barellieri fossero stati piú in forma, il filo che lo legava alla vita si sarebbe spezzato appena fuori nel gelo del cortile.
Primavera-estate 1943. Oranki, Campo 74
La primavera scioglieva il ghiaccio quando una mattina sentii il desiderio di bagnare un po' di pane nel "ciai" che era una specie di tea e di metterlo alla bocca; mi piaceva; ci provavo gusto; avevo fame! Avevo vinto il tifo. Qualche giorno dopo mi venne all'improvviso la visione di carissimi amici che avevo perduto in quell'inverno e mi trovai che piangevo. Mi meravigliai moltissimo del mio pianto e constatai che in tutti quei mesi non avevo mai pianto; forse avevo riso alle battute di Palmieri, ma pianto, mai: neppure alla morte del mio amico che stavo lavando sul pancone del bagno. Adesso invece piangevo: stavo tornando alla normalità. Ero molto debole; quando mi alzai per fare un certo numero di passi (volevo raggiungere il fondo del corridoio per ricuperare una coperta), mi ritrovai ripiegato a terra. Nessuno mi aveva urtato; non avevo inciampato: anche lí tanta meraviglia di me stesso: stavo tornando alla normalità ma ero fuori uso. La vita che ritornava mi permise di gustare in tutta la sua bellezza il gesto di una dottoressa ebrea, per salvare Giovanni Mannucci che non ce la faceva a saltar su. Addetta alla nostra assistenza ci aveva visti morire senza che avesse potuto farci niente; non c'erano medicine; bisognava morire per forza. Ma come se avesse detto a sé stessa: uno almeno lo debbo salvare, si mise attorno a Giovanni Mannucci con una premura ed affettuosità che ci incantò tutti. Cominciò a portare da casa un uovo e poi qualche pezzetto di cioccolata... noi capivamo che agiva illegalmente; chissà da dove prendeva quella roba... darla poi ai prigionieri... Non piú giovane, seria, parlava poco; Mannucci del resto era ancora nella fase acuta e manco si accorgeva di quelle attenzioni. Mannucci ritornò a vivere e la dottoressa sparí, in me è rimasto uno dei piú forti e soavi ricordi della mia prigionia.
Ritornava l'estate, la prima estate della prigionia. Il sole entrava nel campo al mattino dalle mura di levante e tramontava la sera dietro le mura di ponente; solo allora mi accorsi di essere prigioniero; quel po' di vita che ritornava non aveva altra dimensione che le garitte e il filo spinato. Un'infinita tristezza, illuminata però da una speranza: e se noi scampati dal tifo ce la facessimo a tornare! Seguiva un altro pensiero: se torniamo in Italia, ci chiederanno dei morti! I parenti vorranno sapere da noi cos'è successo. È necessario fissare i nomi degli amici che abbiamo visto morire. Ed ecco allora quello che organizzammo: alla sera quando eravamo sdraiati giú sui nostri legni, ognuno diceva i nomi di quelli che aveva visto morire; c'era chi prendeva nota e compilammo cosí un lungo elenco; accanto a ogni nome si scrivevano i dati: del reparto, dell'indirizzo in Italia. "E se arriviamo in Italia, chi va a dare la notizia"?! "Vado io, che sono della sua città". "Allora - dicevano i cappellani - prendi anche questa medaglietta che aveva addosso quando è morto". Se i russi ci avessero trovato quell'oro, avremmo avuto bei guai; era meglio distribuirlo, affidandolo a chi aveva piú probabilità di recapitarlo. Avevamo fatto un ottimo lavoro; ma un brutto giorno i russi che tutte le mattine ci schieravano in cortile per contarci, non si accontentarono della conta ma ci setacciarono in una minuziosa perquisizione. Noi ridevamo: "pensano che nascondiamo un carro armato"?!
Arrivarono a don Brevi; don Brevi aveva con sé l'elenco dei morti, il frutto del nostro lavoro. Alte grida delle guardie per aver scovato un "documento segreto"; fanno la faccia feroce e trattengono l'elenco e ci minacciano. Tutti prendiamo parte per dire che quei nomi sono dei nostri morti: non c'è nessun segreto; non è un cifrario militare; lo facciano esaminare da chi vogliono; la carta usata è quella che si trova nei cortili del campo: carta da sigarette; è tutto in regola... Niente da fare: l'elenco fu ritirato e non è mai piú comparso, gettato chissà dove. È stato questo uno degli affronti piú gravi che i russi ci hanno fatto. Da quella primavera '43 altri tre anni di prigionia sarebbero trascorsi e i nomi dei morti affidati alle nostre memorie spente (io in qualche momento dimenticai l'indirizzo di casa) non ci sono rimasti dentro che in minima parte. Dove saranno finiti quegli elenchi?! Quante famiglie avrebbero potuto "mettere il cuore in pace" sapendo che non c'era piú da sperare in un ritorno dei loro cari.
Giudicato distrofico e quindi non adatto ai lavori pesanti, vengo mandato allo Skit. Lo Skit è una costruzione in mezzo alla foresta che i monaci ortodossi riservavano ai contemplativi. Stava al monastero di Oranki dove ci trovavamo, come le Carceri di Assisi stanno alla Porziuncola. San Francesco lasciava spesso la Porziuncola per rifugiarsi nella solitudine delle grotte del Subasio. In mezzo alla foresta avremmo dovuto rimetterci, ma troppa era la fame, e allora si andava a caccia di tutto quello che natura offriva dentro al filo spinato. Ci interessò parecchio una quercia grossa di ghiande; una manna! Il figliol prodigo doveva essere un povero figliolo se si lamentava delle ghiande; quantomeno non aveva imparato ad arrostirle; noi le trovavamo squisite; fortunato chi era pronto ad uscire alla prima luce del mattino; piú tardi non si trovava piú niente. Due "foto" mi sono rimaste nella mente dello Skit: la prima di quando con don Giannone sto camminando all'aperto, impegnati a tirar fuori dalla memoria qualche salmo per la nostra preghiera insieme. Don Giannone era bravissimo, aveva conservato piú memoria di me; potemmo riesumare cosí i Vespri della Domenica e i salmi di Compieta e li ripetevamo con tanto gusto, stupiti quanto mai di essere stati portati lí a salmodiare, come a riprendere la lode al Dio dei monaci che i russi avevano soppresso.
Io poi dovevo ricuperare settimane intere in cui non avevo mai pregato; le settimane del tifo; anche in procinto di morire non mi pareva di aver mai fatto un segno di croce. Seconda "foto": è notte e siamo in attesa di dormire. Una lucerna nello scantinato dello Skit manda piú fumo che luce. Qualche breve parlare, poi io dico: capitano Lunardini, ci dica «La pioggia nel pineto». Altri si uniscono a me ad invocare la pioggia nel pineto. Il Capitano Lunardini era un innamorato di D'Annunzio e se con don Giannone io mi consolavo coi salmi, lui si consolava con quanto ricordava di D'Annunzio. E aveva una splendida voce baritonale. Dopo qualche schermaglia, Lunardini comincia. Nel silenzio, nella penombra "piove sui nostri volti silvani, / piove sulle nostre mani ignude, / su i nostri vestimenti leggeri, / su i freschi pensieri che l'anima schiude novella, / su la favola bella / che ieri t'illuse, / che oggi m'illude...". Forse ogni altra bella poesia (tutti eravamo piú o meno reduci da studi letterari) ci avrebbe toccato in quei momenti; ma quei versi parevano particolarmente propri per i sogni e le nostalgie. Le bolge notturne di Tambov di qualche mese prima erano un ricordo; ora si soffriva in silenzio riportati all'improvviso al nostro passato. Stavamo tornando alla normalità: avevamo coscienza del nostro soffrire.

Attuale cimitero di Suzdal (campo n. 160) nella regione di Vladimir (Russia)
La fotografia è tratta dalla pubblicazione del
Ministero della Difesa, CSIR-ARMIR. Campi di prigionia e fosse comuni, Gaeta 1996, 85.
Novembre 1943: da Oranki a Sussdal
Cosa non pagherei per incontrare oggi i soldati russi che via via si sono susseguiti a farci la guardia nella nostra prigionia! Magari qualcuno ha scritto le sue memorie; che idea si saranno fatta di noi?! Chissà dove sono quelli che ci scortarono nel novembre '43 da Oranki, campo 74, a Sussdal, campo 160. Il viaggio in carrozzone bestiame non era stato particolarmente disastroso; pane e acqua e pesce salato credo non ci sia mancato, tanto è vero che non ho memoria di morti; mi pare arrivammo tutti (due-trecento?) alla stazione di Vladimir. Vivi sí ma non in grado di affrontare una marcia di 30 chilometri circa per arrivare a Sussdal. Protestare non serve; appellarci al commissario politico Fiammenghi che aveva fatto il viaggio con noi, tanto meno; mettiamoci in marcia e Dio provvederà, non sarà la fine del mondo; ci hanno detto che si tratta di un'ora o poco piú. La notte nera; facile sbandare sul fondo ghiacciato. Ricordo la protesta vostra, Colonnello Zingales, alta, stentorea, provocatoria; io ammirai il vostro coraggio. Ammirai anche chi volle infonderci coraggio intonando a piena voce una canzone; noi di canti ne sapevamo tanti; se riusciamo a formare un bel coro, il tempo passa in fretta. "Mamma son tanto felice - perché ritorno da te - la mia canzone ti dice - che è il piú bel giorno per me...".
Su, forza! Ma cosa succede?! Ho ancora dentro una delle mie sofferenze piú atroci: dopo due battute il canto si è spento in una stonata disgustosa, come quando negli organi a mantice all'improvviso s'interrompe l'aria. No, non possiamo mentire; non siamo felici e nostra madre è tanto lontana e chissà se torneremo a vederla. Ne seguí un silenzio, amaro, totale; chi protestava non protestò piú, chi cadde non gridò; ognuno si strinse dentro l'improvvisa ferita che quel canto involontariamente aveva aperto. Ricordo benissimo uno disteso sulla strada: chissà in quanti lo avevano pestato; quando gli arrivai vicino d'istinto mi chinai per baciarlo... "questo bacio te lo dà tua madre". Ma ricordo un'altra cosa: che taceste anche voi, soldati della nostra scorta. "Davai davai bistrà" era il vostro grido: ma in quel momento smetteste di gridare. Rivivendo adesso quell'ora, ho l'esatta sensazione che voi avevate capito il tema del canto e il motivo del nostro silenzio. Mamma per voi è "mama"! E voi sentiste che cantavamo alla mamma e ne foste feriti profondamente con noi; anche vostra madre era tanto lontana. E vi prese certamente una grande ira perché eravamo venuti a tirarvi fuori di casa. Ma non gridaste; piú dell'ira fu lo sgomento di fronte al mistero che ci appaiava a camminare, vincitori e vinti, in quella notte nera, l'uno accanto all'altro, uniti dalla stessa pena.
L'asprezza della marcia, che si protrasse fino al mattino, ci impedí di piangere. Quando nel maggio di quest'anno ci siamo trovati, superstiti del campo 160, abbiamo pregato Toti perché ci cantasse il canto popolare russo "Mama". Toti ha ancora oggi una pastosa voce baritonale. La musica è splendida ed anche le parole: "...Mamma: non ci sono occhi piú luminosi, mamma: non c'è parola piú dolce - carasciò mne szit stòboi mama rodnaia - è bello per me viverti accanto, mamma che mi hai dato la vita. - skolko nociéi sogn moi bereglà - quante notti hai vegliato il mio sonno - ora ti vedo vecchia - ora sarò io a vegliare te - mamma...". Nella sala d'incanto si sono cancellati gli anni trascorsi e ci siamo ritrovati nella notte di Vladimir-Sussdal. Si è fatto il silenzio di allora e questa volta abbiamo pianto. Se mi vedete passare per la strada e non vi saluto dite pure che sono distratto: può darsi che in quel momento mi stia ricantando "mama". Me lo ripasso tante volte anche se mi fa soffrire; potrei far sentire anche a voi quelle dolcissime note; non avete che da chiedermelo! Può darsi che non riesca ad arrivare alla fine; per colpa del groppo alla gola. Adesso mi accorgo di aver fatto una grossa dimenticanza; non ho ancora cantato per le mamme dei soldati della nostra scorta di quella notte nera. Intono subito adesso: "Mama niet glaz iarciei miliei...".
Pane di frumento e vino di uva
Private un sacerdote dell'Eucaristia e gli avrete dato la piú grossa mortificazione. Questa mortificazione durò per me dal 16 dicembre '41, da quella Messa, la piú "vera" della mia vicenda in Russia, fino all'8 dicembre 1942, quando, in una scatoletta di legno uso tabacchiera, don Bonadeo mi allungò l'Eucaristia attraverso il filo spinato. Eravamo giunti al campo di Sussdal n. 160 e ci avevano messi in quarantena. Sapemmo da chi ci portava la zuppa, che c'erano in quel campo dei cappellani nostri italiani che celebravano la Messa. La notizia era enorme per me come è facile immaginare e mi misi subito a contatto con alcuni amici che volevano anch'essi interrompere il lungo digiuno, e ad un'ora stabilita si presentò dall'altra parte chi disse di essere don Bonadeo. Non ci eravamo mai visti. Mi guardò, gli dissi che ero cappellano, mi disse che era cappellano, mi allungò la scatoletta. Rientrai al Corpus stringendo il Dono. L'Eucaristia in una tabacchiera! L'Eucaristia custodita nella pisside che dev'essere di metallo nobile, d'oro o almeno dorata la coppa, e poi il piccolo conopeo copri-pisside di stoffa pregiata, almeno due candele quando si fa la Comunione... mi tornò subito alla mente quanto le norme liturgiche prescrivevano e prescrivono perché il Signore abbia il dovuto onore: e io aprivo ora una tabacchiera molto primitiva e dentro qualche briciola. Mi sono messo in ginocchio in un angolo del corridoio; i miei amici, rassicurati dal mio gesto che li garantiva, in ginocchio anch'essi a dire il "Confiteor" e a ricevere dalle mie mani un piccolo frammento, facendo attenzione che ne restasse anche per me. Il tutto un po' in fretta, perché non sapevamo quale reazione poteva seguirne da parte delle guardie. Fu la prima Comunione della prigionia: la cosa che mi sorprese fu l'assenza completa di disagio che provai per un rito cosí povero e inadeguato; anzi, la fede gioiosa che lessi in faccia ai miei amici mi portò un conforto indicibile, perché compresi una cosa: chi piú di tutti si trovava a suo agio in quel momento era il Signore che veniva a visitare i carcerati, a portare la liberazione ai prigionieri. Non eravamo piú soli.
La prima Messa di prigionia la dissi diciotto giorni dopo, il 26 dicembre, finita la quarantena. Sí, a Sussdal già prima dell'arrivo del mio gruppo, i cappellani cattolici avevano qualche volta celebrato. Aveva cominciato P. Alagiagian, armeno, ma cappellano in un nostro reparto. Egli diceva che aveva un permesso particolare del Papa, di celebrare senza pietra sacra, senza paramenti, senza alcun segno esterno col solo pane di frumento e vino d'uva. Come armeno lo considerarono traditore e gli riserbarono un "trattamento" a parte. Nel suo trasferimento i cappellani si chiesero se potevano ritenere delegabili le facoltà particolari di P. Alagiagian; giudicarono di sí: "se il Papa conoscesse la nostra situazione non esiterebbe ad autorizzarci", e celebrarono anch'essi. A me toccò appunto, la prima volta, il 26 dicembre. Non c'era camice, non c'era pianeta, altare era un tavolino traballante, calice un gavettino; c'era una lucerna che mandava un fumo nero e poca fiamma al posto delle candele. Ma c'era in me la lieta indicibile sorpresa di poter ancora celebrare, e non l'avevo messo in conto da quando il mio altarino era stato distrutto al caposaldo Venere. Cominciai a capire che di tutto a noi prigionieri poteva accadere, in bene e in male; sarebbe stato inutile fare previsioni: e fu proprio cosí fino alla fine della prigionia, ogni giorno fece testo a sé e solo quando rinunciammo a indovinare cosa ne sarebbe stato di noi, avemmo un po' di pace. Perché fino all'ultimo ignorammo il nostro destino; nel 1945 le guardie cominciarono "skoro domòi" (presto a casa) e a casa non si tornava mai.
"Skoro domòi" sto pensando adesso che le guardie che forse intendevano consolarci con quelle parole, auguravano a sé piú che a noi di potersene tornare a casa, sapendo che il loro rientro a casa non era meno problematico del nostro; al termine della guerra, quanti militari sovietici anche decorati, sono caduti nella mani dell'inquisizione staliniana, processati, deportati, eliminati. Ringrazio ora gli amici del forno di Sussdal, soldati nostri e russi, che ci diedero farina di frumento per fare le ostie per la Messa; ostie per modo di dire, perché ricavate da due ferri da stiro che schiacciavano la pappetta di farina e acqua; sempre meglio comunque delle briciole. La prima pappetta incollò i due ferri che non si distaccavano piú: parve a me un oracolo l'idea risolutrice di don Caneva, di porre una goccia d'olio sui ferri arroventati; ora le ostie scivolavano via quante ne volevamo; per modo di dire, perché era sempre un piccolo frammento che si dava alla Comunione, nonostante le proteste dei nostri "fedeli" che oltre alla fame dell'Eucaristia avevano tanta fame anche del pane quotidiano, "Cappellano, dammi una Comunione un po' piú abbondante!" E il vino d'uva? Sembra una favola. I russi davano a noi a Sussdal qualche grammo di frutta secca che a loro abitualmente serviva per fare la "compòtt", una specie di tea. C'era in mezzo qualche acino d'uva. Si passava alla raccolta, invitando a dare almeno un acino a testa.
Si formava un bel gruzzolo di acini che mettevamo ad inumidire in un po' d'acqua fino a farli rinvenire; si pigiava ed ecco il vino d'uva: torbido da far paura, ma noi cappellani non avemmo esitazione a dichiararlo materia valida per la Messa. Piú tardi ad un giovane tenente delle guardie che ci decantava un certo negozio di Mosca "dove c'era di tutto", demmo gli inutili rubli con cui i russi ci pagavano il lavoro (inutili perché non ci davano modo di spenderli) ed egli portò da Mosca un quarto di "vinò", vino della Georgia. Ma sarà di uva? Se non fosse stato di uva, le Messe sarebbero state nulle. Ma come si fa a saperlo? Assaggiarlo? A questa prospettiva tutti si professarono enologi provetti, infallibili: sarebbe bastato un piccolo sorso! Ma la bottiglietta era tanto piccola e non si poteva disperderne una goccia; e la prova d'assaggio fu scartata. Dopo mille incertezze e discussioni, il "sinodo" dei cappellani (eravamo in dieci) decise che quello era vino di uva e si poteva usare per la Messa. Veramente la decisione non fu presa cosí alla leggera; io ricordo che, stappata la preziosa bottiglietta, la feci fiutare al cap. Menchetti proprietario di una grossa azienda agricola nell'anconetano, il quale per poco non svenne dall'"ebbrezza" e dichiarò che quello era aroma di vino. Dicemmo cosí, nelle feste, le nostre Messe. I residui dubbi sulla liceità della materia erano vinti dall'urgenza di offrire insieme al sacrificio del nostro Maestro quello di tanti amici che ci erano morti al fianco e le angosce di noi sopravvissuti, ignari fino all'ultimo del nostro destino.
La singolarissima vicenda di Loris Nannini
Non posso fare a meno di dedicare questa pagina a Loris Nannini, mio compagno di prigionia al campo 74 di Oranki e 160 di Sussdal, per la vicenda esemplare in cui è stato coinvolto. Di lui ha parlato Franco Pagliano nel libro «In cielo e in terra» (Longanesi 1969); ma quel racconto non è completo; Nannini ha riservato agli amici i particolari della sua vicenda. Caduto prigioniero il 22 settembre 1941 in Ucraina, primo ufficiale italiano catturato dai russi, fu sottoposto ad una tortura feroce perché si voleva che indicasse dov'era il campo di aviazione da cui era partito. Nannini era tenente di aviazione; colpito il suo apparecchio si era lanciato col paracadute. I russi tentarono il tutto per tutto, ma Nannini non mollò, dimostrando una fortezza e sicurezza tale che il politruk, cioé il commissario politico ad un certo punto lo sottrasse alla furia, lo chiamò nel suo ufficio scusandosi con lui. Il commissario politico era Nikita Kruscev, un carneade qualunque nel 1941; Kruscev, credendo di essersi accattivato Nannini, un giorno blandamente lo invita a dire dov'è il campo di aviazione. Al rifiuto secco di Nannini, Kruscev si arrabbia e comincia a bestemmiare. Nannini, che aveva ormai messa persa la vita, dice a Kruscev che, nel caso in cui lo avesse sentito bestemmiare ulteriormente, avrebbe potuto reagire in modo violento.
Kruscev guarda Nannini in modo divertito: quale reazione avrebbe potuto avere quel ragazzo malcapitato che gli stava davanti!!! E torna a bestemmiare. Nannini spinge Kruscev col tavolo contro il muro. Il piantone di guardia si lancia su Nannini, ma dall'altra parte del tavolo Kruscev grida alla guardia di non toccarlo, fissa a lungo Nannini, poi gli stringe la mano complimentandosi con lui del suo coraggio. Convoca gli ufficiali e Nannini capisce che Kruscev sta facendo loro il suo elogio; lo arguisce dagli sguardi di estremo interesse che piovono su di lui. Gli anni passano e l'oscuro commissario politico ucraino diviene il primo uomo dell'Unione Sovietica. Il 29 ottobre 1956, in un ricevimento al Kremlino, parlando degli italiani da lui conosciuti con la moglie del giornalista Vero Roberti, Kruscev accenna ad un valoroso ufficiale italiano. 1960 - Il Presidente Gronchi va al Kremlino. Kruscev insiste: "Ho conosciuto un bravissimo ufficiale vostro; ricordo che era d'aviazione; non ricordo il nome, se potessi incontrarlo gli stringerei ancora la mano e lo terrei mio ospite: vi ha fatto molto onore." 1961 - a Fanfani, egli pure in missione a Mosca, Kruscev ripete la stessa ammirazione e lo stesso invito. Ma nessuno in Italia riesce a rintracciare questo misterioso ufficiale di aviazione per dirgli che è aspettato al Kremlino da Nikita Kruscev in persona, che vuole ancora congratularsi con lui.
La cosa piú incredibile è che l'interessato aveva letto i giornali, guardato le foto ed aveva ben capito che l'aspettato al Kremlino era proprio lui. Ma non si mosse. Quando il giornalista Franco Pagliano, che si era trovato lui pure al seguito dei nostri ed aveva udito tutto ed aveva giurato a sé stesso che sarebbe riuscito a scovarlo, lo trovò finalmente a Milano e gli gridò che Kruscev lo aspettava, si sentí dire: "Non mi interessa affatto, me ne sto a casa mia". "Lascia almeno che io scriva di te; dimmi cos'è accaduto". E fu allora che Nannini raccontò la sua storia, che Pagliano riportò in un capitolo del suo libro, capitolo intitolato: «Piaceva anche a Kruscev». Perché Nannini non è andato al Kremlino? Lo sappiamo noi, suoi amici, cui ha confidato ben piú di quanto abbia detto nell'intervista a Pagliano; sono innominabili le atrocità cui fu sottoposto in quel settembre 1941; ritornare davanti a quell'uomo sarebbe stato riaprire ferite troppo dolorose. Ma c'è anche un altro motivo: l'estrema modestia, la ripugnanza innata ad ogni forma di esibizione. Ora Nannini vive a Pistoia e quando compare ai raduni dei reduci, di mani ne stringe, ne stringe, a compensarlo anche di una incredibile disattenzione: elogiato dal nemico in una maniera cosí clamorosa, Nannini non ha avuto per quella vicenda un adeguato riconoscimento.
[...]

Don Franzoni visita il monumento ai caduti di Talitza, in Russia (17 luglio 2001)
Una madre
Debbo avere da qualche parte la lettera che mi ha inviato il Col. Catanoso in cui mi ricorda il nome degli otto celoviecchi (uomini) cui ha fatto pervenire al rientro in Italia un encomio solenne, perché nell'inverno '44-45, superando un notevole disagio, avevano tirato la slitta della legna dalla taiga al Campo 160: dieci chilometri andata e dieci ritorno. L'andata era cosa semplice con la slitta vuota; al ritorno... La fatica era improba; non ricordo chi fu il primo a dire "non ce la faccio piú". "E mettiti sulla catasta; proveremo in sette". Le fermate erano sempre piú lunghe; il sudore non finiva di colare. Adesso pare che davvero non ce la facciamo piú. Fortuna nostra che - siamo in gennaio - la "buria" [tempesta] non si scatena. Ma siamo fermi. Non abbiamo manco notato un'isba fra le betulle, ma una porta cigola. Si fa avanti una donna con qualcosa che regge sui palmi delle mani. Dietro, fermi sulla soglia si affacciano quattro bambini. La donna viene verso di noi; si arresta perché ora anche le guardie di scorta si sono voltate a lei. Ma le guardie hanno altro a cui pensare; sono stanche come noi, nel cappottone di pelliccia fino ai piedi e fanno capire che non gl'importa niente. La donna mi viene vicino e mi mette in mano una tonda focaccia. Ritorna indietro, le sue mani s'allungano sui bimbi a farli rientrare in casa. Io guardo la focaccia: gli amici mi sono attorno per quel boccone di grazia. Madre benedetta, cosa hai messo nella focaccia se ora ci sentiamo forti, riprendiamo a tirare, arriviamo al Campo accolti in trionfo?! C'era la carica del tuo gesto per noi; tu avevi visto che eravamo prigionieri; al fronte c'era tuo marito; noi avevamo combattuto contro di lui e tu ci davi la focaccia di patate e farina. Cos'hanno mangiato i tuoi bimbi quella sera?
Due documenti preziosi
Per quanto mi consta, sono 54 i colleghi cappellani deceduti nella campagna di Russia. Di questi, 24 sono morti in prigionia, portati via dal tifo nel primo semestre 1942. Siamo scampati in 12 e ci avevano, in 8, riuniti nel campo 160 di Sussdal. C'era con noi anche Don Andreas Bader e Don Colombos Janos, il primo, cappellano cattolico tedesco, l'altro, ungherese. Diceva spesso Don Andreas fra il serio e il faceto: "Dominus facit nos transire mare rubrum!" (Il Signore ci fa passare attraverso il Mar Rosso). E io aggiungevo: "Utinam perveniamus ad terram promissam!" (Auguriamoci di arrivare alla terra promessa!). Parlavamo in latino che, allora, tutti i preti del mondo conoscevano. Ma non eravamo tranquilli; sapevamo di migliaia di nostri soldati disseminati dalla Siberia all'Usbekistan; perché non fare domande per andare con loro?! Uno resta nel campo 160 e gli altri vanno. Vi trascrivo qui il testo della domanda:
«Al Comando del Campo n. 160 di prigionieri di guerra.
I cappellani militari italiani Ten. Don Enelio Franzoni, Ten. Don Guido Turla, Ten. Don Alberto Valori, Ten. Don Carlo Caneva, Ten. P. Giuseppe Fiora, Ten. Agostino Don Bonadeo, Ten. Don Mario Giannone, Ten. Don Michele D'Auria, sicuri di interpretare il desiderio della maggioranza dei soldati italiani e degli ufficiali che li inquadrano, fanno domanda di essere inviati nei vari campi onde prestare la loro opera di assistenza religiosa e morale.
Ten. Capp. Don Franzoni Enelio
Sussdal 19 maggio 1945».
Poi c'è la traduzione in russo fatta dal Ten. Enrico Giuliano di Torino, padrone della lingua al punto che un giorno le guardie gli chiesero da quale repubblica sovietica provenisse. Il foglietto ritornò qualche tempo dopo, con la risposta; una sola parola scritta in matita rossa ancora oggi ben leggibile, trasversale al testo: "Otkasat" con la firma del comandante Col. Krastin: Otkasat significa rifiutare.
Al ritorno in patria molti soldati ho trovato meravigliati al sapere che c'erano cappellani prigionieri e quando faccio leggere il foglietto commentano l'"Otkasat", il rifiuto: "I russi avran pensato che voi potevate influire negativamente sulla loro propaganda" e ammirano la nitidezza dello scritto dopo tanti anni; merito dell'"inchiostro", il permanganato, che il Dott. Reginato spennellava in faccia contro i funghi della pelle, o dava in gocce contro il mal di pancia. L'altro documento porta la data del primo febbraio 1945. Succedeva che il tenente Usatienko, addetto alle periodiche perquisizioni, piú di una volta aveva minacciato di ritirare i quattro stracci dei paramenti sacri che eravamo riusciti a combinare. Ma ecco il testo che il solito miracoloso permanganato permette di leggere ancora integro.
«Al Comando del Campo 160
Signor Colonnello Krastin
Nell'ultima perquisizione fattasi al Campo, il Sign. Ten. Usatienko chiedeva a me sottoscritto la provenienza degli indumenti di tela (che io ho in consegna) adibiti per il sacro servizio del culto. In seguito mi minacciava del carcere e di tutto sequestrare. Io risposi quanto segue: Quando assieme agli altri colleghi sacerdoti giunsi al Campo, trovai che già si celebrava la Santa Messa. Il permesso era stato accordato dal signor Col. Novikoff, il quale assieme al permesso, aveva dato il necessario per la celebrazione della Messa, cioè gli indumenti di tela che anche oggi ho in consegna e che risultano dall'elenco qui allegato, del quantitativo di circa n. due lenzuola. Nell'estate 1944 noi chiedemmo ed ottenemmo dall'Ufficio di amministrazione del campo, n. 3 lenzuola, con l'impegno di conservarle integre. Le tre lenzuola sono infatti ancora conservate; due soltanto hanno subito un deterioramento in quanto sono state adattate per l'uso per cui sono state richieste. Quello che allora esposi al signor Ten. Usatienko, espongo anche a Voi, signor Colonnello, onde ottenere un permesso scritto, per conservare i detti indumenti di tela e tutti gli altri oggetti in legno ed alluminio che gli Ufficiali del Campo hanno costruito per il decoro del Culto. Con osservanza
Ten. Cappellano D. Franzoni Enelio».
Quante bugie! Non era vero che il Col. Novikoff avesse dato il necessario per dire la Messa; non era vero che ci fossero state assegnate lenzuola per il camice e le federe per far le maniche; le avevamo fatte fuori noi con la complicità del Ten. Casacci addetto al magazzino. Ora mi chiedo: come mai questo lusso di dir bugie quando non c'era niente di piú pericoloso che voler fare i furbi?! Vedo la data: febbraio 1945; la guerra ormai l'avevano vinta; era pensabile che non guardassero a queste sciocchezze. Difatti questa volta la risposta fu positiva: "t. Maiorow, pridmiete obriada nepadliesat isistiu". E Tatiana, cittadina di Mosca ora mia parrocchiana, mi traduce: "Al compagno Maiorow: gli oggetti di rito non sono soggetti a confisca". Segue la firma del Col. Krastin e la data 8 febbraio 1945. Il Magg. Maiorow era l'aiutante di campo di Krastin; aveva fama di essere un duro. Posso aggiungere che al rientro dalla prigionia uscí un "prikaz" o ordine che suonava cosí: "I prigionieri nel lasciare l'Unione Sovietica debbono consegnare tutto quello che appartiene all'Unione Sovietica" e tutto dovetti consegnare. Ma gli amici pedinarono la guardia e ricuperarono la cassetta; dico la cassetta: l'aveva messa insieme il Ten. Brusco con lamiera caduta dal tetto del Corpus 2; l'aveva fatta per sé ma poi s'accorse che non aveva niente da metterci dentro e la diede a me per i paramenti. E mi presentai il piú disinvolto possibile all'ultima perquisizione, rassegnato a tutto. Riconoscerei ancora oggi il sergente che mi aprí la cassetta e mi guardò, meravigliato della mia audacia. Io non so dire cosa mi lesse in faccia; mi guardò ancora; girò gli occhi attorno; nessuno ci osservava; mi spinse la cassetta con un gesto che voleva dire "fai presto, porta via". Ed ho portato a casa il prezioso deposito ed ora nelle celebrazioni con i reduci, guai se non indosso il camice e la pianeta di Sussdal!
"Skoro domoi" (presto a casa)
Da qualche mese era passato il tempo del "davai davai" ed era subentrato il tempo dello "skoro domòi". La guerra terminata, l'euforia per la vittoria, portavano i russi del campo 160 ad un atteggiamento piú disteso; per loro era chiaro: non c'era motivo per noi di restare prigionieri. "Presto tornerete a casa" e aggiungevano sottovoce: "rivedrete la vostra famiglia prima di noi". A pensarli adesso quei ragazzi, fanno una certa compassione; quando noi ci lamentavamo perché non ricevevamo posta da casa, loro ci dicevano: Vi lamentate voi? e allora cosa dovremmo dire noi! Dall'inizio della guerra non sappiamo piú niente delle nostre famiglie.
Presto a casa ma a casa non si andava; stava tornando l'inverno (1945) e una crisi fortissima ci prese; voci si sparsero: non sarebbe tornato nessuno; non avevamo accettato il loro messaggio e non si fidavano a mandarci a casa. Dio ci ha abbandonati, mi dicevano gli amici. Fu allora che ricordai che Qualcuno prima di noi aveva detto qualcosa del genere, ma non parlando a sé: parlando a Dio; "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". "Ragazzi, è cosí che dobbiamo dire; come Cristo; affidiamo a Dio la nostra amarezza; non interrompiamo il filo che ci lega a Lui!" Maggio 1946. Questa volta si parte davvero; siamo relegati al Corpus 2, ogni ora è buona per farci scendere in cortile per l'ultima volta. Cessate anche le perquisizioni, (nell'ultima ci eravamo schierati in cortile, mentre le guardie frugavano nelle nostre stanze a cercare non sapevamo che cosa. Stando in riga, con terrore avevo visto fumare il camino della 48; avevo nascosto nella stufa un preziosissimo libretto fatto con le cartine da sigarette, regalatomi dagli amici nel decimo anniversario della Messa, con tutte le firme. Addio il mio libretto! Quando potemmo risalire mi precipitai; l'ho salvato, anche se porta i segni del fuoco.
Ma torniamo a quei giorni di maggio. Passa il primo e non si parte. Al secondo una cosa sconvolgente: vengono a prelevare una trentina e li portano nel Corpus dirimpetto al nostro. Questi hanno la sensazione che non torneranno piú a casa; molti gridano e attraverso il cortile volano messaggi disperati: dí a mia moglie che la ricorderò sempre... va a trovare mia madre. Io ascolto e il terzo giorno mi decido: affido a Giuliano un messaggio da tradurre e da portare al Magg. Maiorow. Giuliano dapprima si rifiuta: non gli pare ragionevole che io chieda di restare. Io ora attendo; ho pregato Giuliano di non dir niente a nessuno. Ed ecco che il giorno dopo, arriva Timofeo, una delle guardie: "Gdiè Franzoni?" dov'è Franzoni. Eccomi qua. "Davai". Questa volta il davai non era per fare la volontà dei russi ma i russi avevano accettato la mia domanda. Mentre seguo Timofeo spiego agli amici quello che succede: "Mi portano da quelli che non partono, perché ho chiesto di restare con loro". Sei un matto, sei un santo, sei un cretino, hai fatto bene; ognuno dice la sua. Attraverso il cortile; mi portano davvero dall'altra parte. "Ragazzi, i russi hanno accettato la mia domanda; ho chiesto di restare con voi". Quello che successe fu una cosa meravigliosa; mi furono addosso con tanta gratitudine che fui ripagato subito di quella stretta che sentivo dentro e che si traduceva cosí: adesso che fine ci faranno fare? Arrivò l'ora del grande "davai".
Erano circa seicento schierati in cortile. Aver potuto registrare quei commiati e fotografare quei volti, i loro e i nostri! Loro ci guardavano con molta compassione e nessuno aveva il coraggio di dirci: presto verrete a casa anche voi, tanto la cosa sembrava assurda. Poi, nel grande cortile ci fu silenzio. In un momento in cui mi trovai a passeggiare da solo e nella mia preghiera chiedevo al Signore di rendermi forte nella mia scelta, mi si fece incontro il cappellano protestante dei tedeschi. Mi strinse forte la mano dicendomi che avevo fatto bene. Erano rimasti nel campo i tedeschi coi quali molti dei nostri avevano fraternizzato, specialmente per imparare la lingua. C'era anche Henrich Gerlach, l'autore de «L'armata tradita», che scrisse poi in un suo libro «Odissea in rosso» di essere stato aiutato dalla mia scelta, quando anch'egli si trovò in un momento delicato della sua prigionia. Ma c'era un altro motivo per cui avevo chiesto di restare: la malattia di Giulio Leone. Giulio Leone era della mia stanza, la 48, vent'anni, alpino; si era ammalato pochi mesi prima del rientro. Passare tanti guai, superare tanti rischi ed ammalarsi a morte alla vigilia del rientro; era il colmo. Povero Giulio! Tu sai che principalmente a te io pensai quando scrissi il mio biglietto per Maiorow. Giulio, ho ancora scritti in una cartina da sigaretta i turni che stabilimmo subito; i russi permisero di farti assistenza notte e giorno. Ho i nomi dal 4 maggio al 4 giugno: Zacchi, Leonarduzzi, Annoni, Caruso, Sangiorgio, Capuzzo, Castelli... Un giorno che io ero di turno, nel delirio della febbre mi guardasti gridando: scendo in cortile perché mio padre m'aspetta. Non esitai un istante per dirti: Giulio, non vedi? Sono io tuo padre! E tu assentisti, e io piansi di gioia e di dolore.
Il nostro incubo finí all'improvviso alle ore 12 del venerdí 7 giugno. Ci sembrò di sognare quando i russi ci misero in fila e ci dissero: "Davai domòi". Possibile? Ma che scherzo era stato allora l'averci trattenuti! O non ci spediranno in Siberia?! No; Vladimir, Mosca, Odessa fino al 5 luglio, poi a Sighet fino al 9 agosto, il 14 a S. Valentino in Austria, il 22 agosto anche noi eravamo in Italia. Mai saputo il motivo perché non ci abbiano fatto rientrare con gli altri. E Leone? assieme al Col. Zacchi chiesi ancora a Maiorow di restare fino a chiudergli gli occhi. Questa volta non mi ascoltò; meno male che Palacios, Oroqueta, Molero, Asensi e tutti gli altri spagnoli che restavano nel campo, ci tranquillizzarono. Alla finestra della stanza al Corpus dove Giulio agonizzava, ci salutò Palacios e fu lui che tornato in Spagna mi disse che, poco dopo la nostra partenza, anche Giulio era partito; a ricongiungersi alle migliaia di ragazzi morti e sepolti come lui chissà in quale balca, senza croce.
Sono arrivato in Italia...
...alla fine dell'agosto 1946. I primi a salire sul nostro vagone sono stati i carabinieri; a me se n'è accostato uno che mi ha chiesto chi fosse il maggiore Berardi, e subito gli si è messo vicino. Ho saputo poi che al rientro degli amici del campo 160 erano successi dei tafferugli; Marchesi ad esempio si era tolto uno zoccolo e aveva picchiato sodo Piovano; altri ancora erano venuti alle mani contro quelli che risultavano filosovietici. Al nostro arrivo si volevano evitare simili scontri e furono subito piantonati Berardi e i pochi altri filosovietici. Che malinconia! Tornavamo dopo aver visto per tanti anni la morte danzarci attorno e portarci via amici e amici e avevamo ancora voglia, quattro galli di manzoniana memoria, di beccarci fra di noi. Debbo riconoscere però che al rientro si potevano spiegare certe intemperanze verbali e manuali contro chi aveva data l'impressione di una certa collaborazione con i russi ai danni degli altri.
A Milano incontrai don Guido [fratello di don Enelio] che mi confermò la morte della mamma. «E Mons. Sarti è vivo»? Sí, era vivo; Mons. Sarti era stato la mia guida spirituale e mi sentivo a lui molto affezionato. La notizia della morte di mia madre mi era giunta a Sussdal il 26 aprile di quell'anno tramite una cartolina di don Guido, l'unica che mi sia stata consegnata.
«28 agosto 1945
Carissimo don Elio, si parla di ritorni dalla Russia: speriamo anche te fra i (presto) rimpatriandi. Ritengo mio dovere avvertirti che è morta la Mamma; il 12 marzo di quest'anno non per causa di guerra ma di malattia; si è spenta davvero santamente: l'unico non piccolo conforto che tempera tanto nostro dolore. Il Signore ti infonda fortezza per sopportare la piú grande sventura. Mario si sposerà in ottobre. Ti attendiamo.
D. Guido».
La notizia mi aveva colto alla sprovvista; avevo pensato in tante occasioni alla mia morte ma non alla morte della mamma: la piú grande sventura come scriveva don Guido. Furono per me giornate terribili; mi sentii all'improvviso indifferente a tutto: tornare a casa o restare per sempre in Russia era la stessa cosa. Quando rivedo ora gli amici che mi furono vicini allora e mi parlano di quei giorni, mi accorgo di averli stupiti; non pensavano che il cappellano potesse piangere tanto. Il cappellano era quello che asciugava il pianto degli altri; ma chi poteva asciugare il suo?!
Ci provò, ricordo tanto bene, il Gen.le Ricagno... «Cappellano, è inutile che tu pianga; questi sono guai che non passano piú». Che strano modo di consolar la gente! Solo un "soldataccio" poteva esprimersi cosí; eppure quelle furono le uniche parole ad aiutarmi in qualche maniera. Vi ringrazio ancora, carissimo Generale.
A Milano, nella caserma ci fecero la disinfestazione e ci diedero un vestito da civile; terminava cosí il mio servizio militare anche se l'ultima divisa non aveva neppure piú l'ombra del grigioverde; io ero arrivato in Italia con la giacca rumena, i pantaloni ungheresi e le scarpe, una lunga e una corta, di non so quale esercito. Arrivai a casa da mio fratello don Guido a Quarto Superiore; lí c'era mio padre, Mario e Delfa fortunatamente scampati dalla guerra, e la gioia di riverderli accrebbe ancor piú la pena per mia madre; andai subito la mattina dopo a trovarla alla Certosa [il cimitero di Bologna].
Avrei voluto conservare un ricordo del tempo passato, facendomi fotografare nell'abito civile, del mio arrivo a Bologna; don Guido avvertí un fotografo, ma non venne; sapemmo che lo avevano ucciso nel giorno stesso in cui doveva venire da noi.
L'incontro col Vescovo, il Card. Nasalli Rocca, mi confortò immensamente. Salii le scale e mi sembrò di averle scese ieri quando da lui ero partito cinque anni prima; andavo a rendergli conto della mia missione. Mi accolse come un padre... «Don Enelio, quanto hai sofferto! E sono stato io la causa! Io ti ho mandato in quell'inferno!...».
Il mese di settembre lo passai in giro per l'Italia, a portare i pochi ricordi che ero riuscito a portare con me: una catenella alla famiglia Bonafede di Valenza Po, la corona del Rosario di P. Amedeo Frascati ai suoi colleghi missionari della Consolata a Torino, andai a Fossano a trovare la mamma di Mimmo Monticelli; a Firenze dovevo dire alla mamma di Eros Rigatti che Eros mi era morto in braccio ma lei mi bloccò appena su dalle scale quando seppe che venivo dalla Russia; mi portò nella camera di Eros: «...vede, cappellano, ho sempre pronto il suo letto; ogni mattina apro le finestre; deve ritornare anche lui in questi giorni.» mi ritrovai nella strada pieno di pianto senza aver aperto bocca; e andai a Voghera alla casa di Giulio Leone che moriva a Sussdal mentre noi partivamo. La stessa scena di Firenze; mamma e sorella di Giulio a dirmi che avrebbero preso l'aereo per andare a Mosca a trovare Giulio; Giulio stava bene... «lo dica anche Lei, cappellano, lei che lo ha visto, che Giulio sta bene...».
Cari amici, vi confesso, nel congedarmi da voi, che ho fatto piú fatica a reggermi in piedi in quel pomeriggio nella casa di Giulio Leone, che in tutte le marce del "davai".
N. B.
Questi appunti furono scritti da mons. Franzoni a partire dal 1977 per il bollettino della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Bologna.
Breve profilo biografico
Il 5 marzo 2007 si è spento alle ore 15, l'ora della Passione del Signore, a Bologna Mons. Enelio Franzoni.
Era nato a San Giorgio in Piano (BO) ed era stato ordinato sacerdote il 28 marzo 1936. Nel 1941 venne inviato come cappellano militare della Divisione Pasubio in Russia, dove cadde prigioniero il 16 dicembre 1942.
Aveva rifiutato due volte il rimpatrio per continuare ad assistere gli ultimi militari rimasti al campo di Suzdal: un ammalato grave ed altri "colpevoli" di essersi sempre mostrati ostili verso la propaganda comunista. In un contesto di fame, freddo, malattie e maltrattamenti, don Enelio impose al comandante del campo la propria scelta, anche se ciò avrebbe potuto costargli la vita: rimanere con gli ultimi prigionieri del campo.
Dopo il rimpatrio, nel 1946, gli venne affidata la Parrocchia di San Giovanni in Persiceto, poi quella di Crevalcore, dal 1952 al 1967 e, infine, quella di Santa Maria delle Grazie a Bologna. Per essersi prodigato, durante il secondo conflitto mondiale nel salvare la vita dei propri commilitoni, anche a rischio della propria, nel 1951 era stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare
«Cappellano addetto al comando di una Grande Unità, durante accaniti combattimenti recava volontariamente il conforto religioso ai reparti in linea. In caposaldo impegnato in strenua difesa contro schiaccianti forze nemiche, invitato dal Comandante ad allontanarsi, finché ne aveva la possibilità, rifiutava decisamente e, allorché i superstiti riuscirono a rompere il cerchio avversario, restava sul posto, con sublime altruismo per prodigare l'assistenza spirituale ai feriti intrasportabili.
Caduto prigioniero e sottoposto a logorio fisico prodotto da fatiche e privazioni, noncurante di se stesso, con sovrumana forza d'animo, si prodigava per assolvere il suo apostolato. Con eroico sacrificio rifiutava per ben due volte il rimpatrio onde continuare tra le indicibili sofferenze dei campi di prigionia la sua opera che gli guadagnò stima, affetto, riconoscenza ed ammirazione da tutti. Animo eccelso votato al costante sacrificio per il bene altrui».
Fronte Russo, dicembre 1942 - Campo di prigionia, 1942/46.