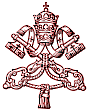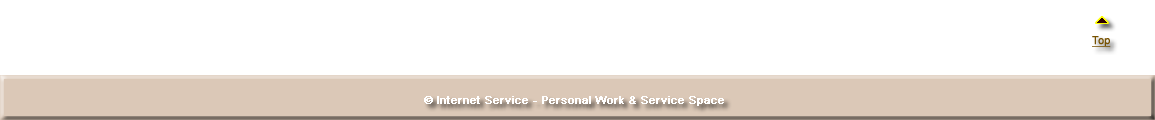I. Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri (cf. Communicationes, 27 [1995] 192-194).
1. Il "Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri", pubblicato dalla Congregazione per il Clero per incarico e con l'approvazione del Santo Padre Giovanni Paolo II, è certamente pervaso, nella sua totalità, da un profondo spirito pastorale. Tuttavia ciò non toglie valore prescrittivo a molte delle sue norme le quali non hanno un carattere soltanto esortativo ma sono giuridicamente vincolanti.
2. Questa obbligatorietà giuridica e disciplinare riguarda tanto le norme del Direttorio che semplicemente ricordano uguali norme disciplinari del CIC (per esempio l'art. 16, § 6) quanto quelle altre norme che determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza (come per esempio gli artt. 62-64).
3. Infatti, le norme di quest'ultimo tipo, che appartengono alla categoria dei Decreti generali esecutori ed "obbligano quanti sono tenuti alle leggi stesse" (CIC, can. 32), spesso sono emanate dalla Santa Sede in Direttori, come è previsto dal Codice di Diritto Canonico (can. 33, § 1).
4. Per quanto si riferisce concretamente all'art. 66 del "Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri", esso contiene una norma generale complementare del can. 284 CIC, con le caratteristiche proprie dei Decreti generali esecutori (cfr. can. 31). Si tratta, perciò, di una norma a cui si è voluto chiaramente attribuire esigibilità giuridica, come si deduce anche dal tenore stesso del testo e dal luogo in cui è stato incluso: sotto il titolo "L'obbedienza".
5. Infatti, detto art. 66:
a) ricorda, anche con rimandi a recenti insegnamenti del Magistero pontificio in materia, il fondamento dottrinale e le ragioni pastorali dell'uso dell'abito ecclesiastico da parte dei sacri ministri, come prescritto dal can. 284;
b) determina piú concretamente il modo di esecuzione di tale legge universale sull'uso dell'abito ecclesiastico, e cioè: "quando non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e conforme alla dignità e alla sacralità del ministero. La foggia ed il colore debbono essere stabiliti dalla Conferenza dei Vescovi, sempre in armonia con le disposizioni del diritto universale;
c) sollecita, con una categorica dichiarazione, l'osservanza e retta applicazione della disciplina sull'abito ecclesiastico: "Per la loro incoerenza con lo spirito di tale disciplina, le prassi contrarie non si possono considerare legittime consuetudini e devono essere rimosse dalla competente autorità".
6. È ovvio che alla luce di queste precisazioni approvate dalla stessa Suprema Autorità che ha promulgato il CIC, dovranno essere interpretati, in caso di eventuali dubbi, anche i Decreti generali emanati dalle Conferenze episcopali come normativa complementare della legge universale sancita al can. 284.
7. In ossequio al prescritto del can. 32, queste disposizioni dell'art. 66 del "Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri" obbligano tutti quelli che sono tenuti alla norma universale del can. 284, vale a dire i Vescovi e i presbiteri, non invece i diaconi permanenti (cfr. can. 288). I Vescovi diocesani costituiscono, inoltre, l'autorità competente per sollecitare l'obbedienza alla predetta disciplina e per rimuovere le eventuali prassi contrarie all'uso dell'abito ecclesiastico (cfr. can. 392, § 2). Alle Conferenze episcopali corrisponde di facilitare ai singoli Vescovi diocesani l'adempimento di questo loro dovere.
Roma, 22 ottobre 1994
+ Vincenzo Fagiolo, Presidente
+ Julián Herranz, Segretario
II. Assoluzione generale senza previa confessione individuale (Communicationes, 28 [1996] 177-181).
Responsum datum ad quemdam Legatum Pontificium qui ab hoc Dicasterio explanationes expetiverat:
Prot. 5309/96
Assoluzione generale senza previa confessione individuale (circa il canone 961 CIC).
I. La normativa del can. 961 relativa all'assoluzione generale, deve essere interpretata e correttamente applicata nel contesto dei canoni 960 e 986, § 1. Il canone 960 recita: "Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest". Il canone sancisce l'obbligo della confessione individuale, con la relativa assoluzione, come "unico mezzo ordinario" per ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Tale modo ordinario viene qualificato come di "diritto divino" dal Concilio di Trento (cf. DS 1707). Il canone accenna ad altre possibili forme di riconciliazione, ma che possono aver luogo ovviamente con carattere straordinario - soltanto quando c'è una impossibilità fisica o morale di realizzare la "individuali et integra confessio atque absolutio". L'obbligo sancito al can. 960 trova riscontro e conferma con la norma stabilita nel can. 986, § 1 che recita cosí: "Omnis cui animarum cura vi muneris est demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri petant, utque iisdem opportunitas praebetur ad confessionem individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis, accedendi".
È questo, infatti, un diritto fondamentale dei fedeli ed un grave dovere di giustizia dei "sacri pastores" (cf. cann. 213 e 843). L'obbligo della confessione individuale sancito dal canone 960 come "unico mezzo ordinario" per la riconciliazione, è stato sottolineato e riaffermato piú volte dal Legislatore, anche successivamente alla promulgazione del CIC del 1983. Ad esempio, nella Esortazione Apostolica postsinodale "Reconciliatio et Paenitentia" cosí si esprimeva: "singularis et integra peccatorum confessio cum absolutione pariter singolari unicum ordinarium modum constituit quo fidelis, peccati gravis conscius, reconciliatur Deo atque Ecclesiae" (AAS, LXX-VII, 1985, p. 270). Dalla normativa suddetta si deduce che quanto è prescritto nel can. 961 circa l'assoluzione generale riveste il carattere di eccezionalità, e rimane sottoposta al dettame del canone 18: "leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi"; essa pertanto deve essere strettamente interpretata. Giovanni Paolo II, nella stessa Esortazione Apostolica, è tornato a sottolineare espressamente questo carattere di eccezionalità: "Reconciliatio plurium paenitentium cum confessione et absolutione generali naturam prae se fert exceptionis neque proinde permittitur liberali electioni, sed disciplina regitur ad hoc instituta" (Esortazione Apostolica "Reconciliatio et Paenitentia" (AAS, LXXVII, 1985, p. 267).
II. Il can. 961, § 1 nn. 1º-2º, presentando il modo straordinario dell'assoluzione collettiva, fissa due condizioni tassative che indicano i soli casi in cui tale assoluzione è lecita:
1º che vi sia un pericolo di morte ("immineat periculum mortis") e per il sacerdote o i sacerdoti non vi sia tempo sufficiente per l'ascolto della confessione individuale. (Riferimento questo, al motivo originario della concessione dell'assoluzione generale nel periodo bellico delle due guerre mondiali).
2º che vi sia una grave necessità ("adsit gravis necessitas"). Lo stato di necessità, spiega il canone, si verifica quando il numero di penitenti e la scarsezza di sacerdoti fa sí che i fedeli, senza loro colpa, rimangono privi, durante un tempo notevole, della grazia sacramentale o della santa comunione. Perché si verifichi tale stato di "grave necessità" devono concorrere congiuntamente due elementi: primo, che vi sia scarsezza di sacerdoti e gran numero di penitenti; secondo, che i fedeli non abbiano avuto o non abbiano la possibilità di confessarsi prima o subito dopo. In pratica, che essi non siano responsabili, con la loro trascuratezza, dell'attuale privazione dello stato di grazia o dell'impossibilità di ricevere la santa comunione ("sine propria culpa") e che questo stato di cose si protrarrà prevedibilmente a lungo ("diu"). La riunione però di grandi masse di fedeli non giustifica per se l'assoluzione collettiva. Perciò è precisato nella stessa norma canonica: "non è considerata necessità sufficiente, quando i confessori non possono essere disponibili, a motivo del solo grande concorso di penitenti, quale si può avere in qualche grande festività o pellegrinaggio".
III. Il canone 961, § 2 stabilisce inoltre che spetta al Vescovo diocesano determinare se nel caso concreto, alla luce dei criteri "concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale", si verificano le condizioni per impartire l'assoluzione generale. Il Vescovo diocesano ha, pertanto, nei casi concreti e alla luce dei criteri fissati dalla Conferenza episcopale, il ruolo di verificare la presenza o meno delle condizioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico. Egli non può stabilire i criteri e non ha in alcun modo il potere di modificare, aggiungere o togliere le condizioni già stabilite nel Codice e i criteri concordati con gli altri Membri della Conferenza episcopale. Il Supremo Legislatore ha ricordato piú volte, nei suoi interventi, la delicatezza di questa norma ed ha piú volte richiamato la responsabilità dei Pastori delle diocesi all'osservanza di essa. Già Paolo VI di v. m., in un discorso ad alcuni Vescovi degli Stati Uniti, ebbe a dire: "Ordinaries were not authorized to change the required conditions, to substitute other conditions for those given, or to determine grave necessity according their personal criteria, however worthy" (AAS, LXX, 1978, p. 330). Giovanni Paolo II nella citata Esortazione Apostolica ha ribadito questo grave dovere: "Episcopus ergo, cuius solius est, intra fines suae dioecesis, aestimare utrum condiciones reapse habeantur... hoc iudicium faciet graviter onerata conscientia pleneque observata lege et praxi Ecclesiae necnon ratione habita criteriorum et mentium directionis, ... cum ceteris membris Conferentiae Episcopalis convenerit" (Esortazione Apostolica "Reconciliatio et Paenitentia", AAS, LXXXVII, 1985, p. 270).
IV. Anche l'iter della redazione del canone 961, sottoposto a suo tempo alla consultazione dell'Episcopato, evidenzia il carattere di eccezionalità della riconciliazione mediante l'assoluzione generale, come si può rilevare attraverso lo studio degli atti pubblicati sulla rivista "Communicationes". Emblematico, al riguardo, è il passaggio da una iniziale formulazione che prevedeva positivamente la possibilità dell'assoluzione generale, ad una formulazione che, al contrario, proibisce direttamente l'assoluzione generale prevedendola soltanto come eccezione. Nello schema "De Sacramentis" del 1975, l'attuale canone 961, che figurava con il numero 132, § 1, appariva redatto in forma positiva: "Firmis praescriptis can. 133, absolutio pluribus insimul paenitentibus, sine praevia individuali confessione, generali modo impertiri potest, immo vel debet...". La possibilità dell'assoluzione collettiva prevista in questa forma positiva rimase immutata anche dopo l'esame delle osservazioni fatte nella prima consultazione (cf. Communicationes 9, 1978, 52-54), e nella stessa forma appare nello "Schema CIC" del 1980, sotto il canone 915, § 1. La modifica venne introdotta in seguito alle osservazioni fatte allo Schema del 1980 dai Padri della Commissione, come risulta dalla relazione pubblicata relativamente a questi lavori: "Ad § 1: 1. Praefertur ut § 1 ita redigatur:" Absolutio pluribus insimul paenitentibus sine praevia individuali confessione generali modo ne impertiatur, nisi... (Alter Pater). 2. Dicatur: "Absolutio... impertiri non potest: 1) nisi immineat periculum mortis... 2) nisi adsit pergravis necessitas..." Formulatio negativa, suppressio verbi "vel debet" et substitutio "gravis" cum "pergravis" sunt omnino necessariae ad abusos vitandos, qui revera iam fere habentur. Formula in textu proposito permulta damna infert vitae spirituali fidelium et vocationibus, quia fideles fere numquam peccata sua confitentur (Tertius Pater)". R. Admittantur: et textus § 1 erit: "Absolutio... impertiri non potest, nisi: 1) immineat... 2) adsit gravis..." (Relatio complectens Synthesim Animadversionum..., in Communicationes, 15, 1983, p. 205). Nello "Schema novissimum" del 1982, il canone 961 è redatto nella forma negativa, che viene definitivamente sancita dal Legislatore nel CIC del 1983.
V. La corretta applicazione delle norme relative all'assoluzione generale esige inoltre l'osservanza di quanto prescrivono i successivi canoni 962 e 963. Il canone 962, § 1 stabilisce un ulteriore obbligo specifico relativo all'assoluzione generale. Perché l'assoluzione generale impartita secondo i criteri canonici sia valida, si richiede, oltre le disposizioni necessarie per la confessione nel modo ordinario, il proposito di confessare in maniera individuale tutti i peccati gravi che non si sono potuti confessare a causa dello stato di grave necessità. In una allocuzione ai Penitenzieri delle Basiliche Romane, Giovanni Paolo II ha fatto cenno a questo aspetto: "Ma voglio richiamare la scrupolosa osservanza delle condizioni citate, ribadire che, in caso di peccato mortale, anche dopo l'assoluzione collettiva, sussiste l'obbligo di una specifica accusa sacramentale del peccato e confermare che i fedeli hanno diritto alla propria confessione individuale" (AAS, LXXIII, 1981, p. 203). Nell'Esortazione Apostolica "Reconciliatio et Paenitentia", dopo aver ricordato che la confessione individuale è l'unico mezzo ordinario della riconciliazione, scrive "Ex hac confirmatione Ecclesiae doctrinae consequitur manifesto ut omne peccatum grave semper sit declarandum... in confessione singulari" (AAS, LXXVII, 1985, p. 270). Il canone 963, sebbene non determini in forma specifica un tempo preciso entro cui effettuare questa confessione individuale, stabilisce però criteri normativi chiari: la confessione individuale deve essere fatta prima di un'altra eventuale confessione generale e deve essere effettuata "quam primum", cioè non appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all'assoluzione collettiva.
Dal Vaticano, 8 novembre 1996.
+ Julian Herranz, Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente
+ Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto, Segretario
III. Obbligo del vescovo di risiedere in diocesi (circa il canone 395 CIC) (Communicationes, 28 [1996] 182-186).
Quaedam Congregatio tres quaestiones de obligatione Episcoporum in dioecesi residendi proposuerat: "... sul preciso significato del disposto codiciale e, in particolare, circa la portata delle eccezioni previste al § 2 del canone 395: 'Praeterquam causa... Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi'. Ci si chiede altresí, se nel computo del mese si debba calcolare o meno il tempo di vacanze".
En textus responsorum:
Prot. N. 5125/96
Obbligo del vescovo di risiedere in diocesi (Circa il canone 395 CIC)
1. La norma che obbliga il Vescovo a risiedere personalmente in diocesi è molto antica nella disciplina ecclesiastica. È già contenuta nel Decreto di Graziano (C. 19-21, 25-26, C. VII, q. 1) e la si ritrova anche nelle Decretali di Gregorio IX (X, III, 4, 9). Numerosi, però, sono stati gli interventi dell'Autorità per richiamare i Vescovi all'osservanza di detto obbligo. [... ] Il Concilio di Trento segna una tappa fondamentale nella storia della norma riguardante l'obbligo di residenza. I Padri conciliari, dopo ampie e vivaci discussioni che toccarono anche la natura di tale obbligo, vi ritornarono sopra con due Decreti successivi (Sessione VI, 13.6.1547: De residentia episcoporum et aliorum inferiorum; Sessione XXIII, 15.7.1563: de reformatione, cap. 1). Il CIC del 1917, accogliendo le normative conciliari e la tradizione che si era formata al riguardo, confermò la disciplina nel can. 338.
2. Il CIC del 1983 ha apportato alcune modifiche che ribadiscono la norma della residenza adattandola alle mutate esigenze della organizzazione ecclesiastica. La normativa del can. 395 non sembra porre problemi la cui soluzione richieda una interpretazione autentica. Essa appare abbastanza chiara nella sua formulazione e le questioni sollevate da codesta Congregazione riguardano piuttosto la retta applicazione della legge. Tre sono le domande poste. Le prime due riguardano l'esatto significato della terminologia del canone in merito alle eccezioni che giustificano l'assenza dei Vescovi dalla Diocesi:
a) la prima eccezione concerne il dovere del Vescovo di assistere alle riunioni della Conferenza episcopale. In merito si fa notare che gli statuti e i regolamenti delle Conferenze determinano quando la partecipazione è necessaria o grandemente utile. Ogni singolo Vescovo conosce la forza della norma che gli impone la propria presenza alle singole riunioni. Pertanto l'assenza dalla diocesi a causa della partecipazione alle varie possibili riunioni della Conferenza Episcopale sarà giustificata soltanto se a norma degli Statuti il singolo Vescovo deve prendere parte a quella riunione,
b) neanche l'altra eccezione cui si riferisce la Congregazione - "aliusve officii sibi legitime commissi" - dovrebbe originare dubbi di interpretazione. Non si tratta, infatti, di qualsiasi ufficio o ministero ma soltanto di quello che al Vescovo sia stato affidato legittimamente. Il Vescovo, oltre che per le riunioni della Conferenza, potrà assentarsi anche per svolgere le mansioni legate a quell'ufficio che gli è stato conferito dall'Autorità a lui superiore. In questo contesto sembra necessario evidenziare che alcune attività ministeriali od accademiche in sé certamente buone, ma che non sono direttamente rivolte alla cura pastorale della Diocesi, non possono essere ricomprese tra quegli altri uffici legittimamente affidati di cui si è ora parlato. Il tempo impiegato per tali attività extra-diocesane che non sono state richieste dalla superiore Autorità deve, pertanto, essere conteggiato nel mese di vacanza. Solo a titolo di esemplificazione, e non per proporre un elenco esaustivo, sembrano rientrare tra queste attività: gli esercizi spirituali predicati fuori Diocesi e diretti a persone non diocesane o che non abbiano particolari legami con la Diocesi, i corsi di lezioni o conferenze, gli "incontri" regionali o nazionali con varie categorie di persone (associazioni, movimenti, ecc.), le missioni al popolo fuori della propria Diocesi, la guida di pellegrinaggi non diocesani organizzati a scopo religioso e culturale, ecc. Si sa, infatti, che l'odierna facilità di comunicazione rende facili e frequenti queste attività, con possibile pregiudizio della necessaria stabilità in Diocesi.
3. In tutti i casi elencati nel can. 395, § 2 l'assenza del Vescovo è legittima e, perciò, giustificata. Tuttavia non sfugge la constatazione che lo sviluppo di queste nuove strutture dell'organizzazione ecclesiastica a livello sopra-diocesano - cui si aggiungono in molte nazioni le conferenze o riunioni dei Vescovi della stessa provincia o regione ecclesiastica - renderebbe problematico l'obbligo della residenza dei Vescovi in Diocesi, se non si ha la prudenza di limitare al minimo strettamente necessario queste convocazioni dei Vescovi diocesani fuori della propria Diocesi.
4. Si potrebbe porre, inoltre, il problema relativo al conferimento ai Vescovi diocesani di incarichi extra-diocesani o sopradiocesani, che devono essere sempre proporzionati ai primari doveri diocesani, specie se si tratta di Diocesi con particolari problemi pastorali: mancanza di vocazioni sacerdotali, crisi disciplinari nel clero, scarsa formazione catechetica dei fedeli, penetrazione delle sette e proselitismo da parte di aderenti ad altre religioni, ecc. Questo, però, è un problema di governo che sembra richiamare piuttosto ad un coraggioso senso di responsabilità, anche per l'esempio che i Vescovi sono chiamati a dare ai presbiteri diocesani, particolarmente a quelli che sono pure essi tenuti al dovere di residenza per analoghi motivi (cf. can. 533, §2; § 3).
5. Altre utili indicazioni e considerazioni per la retta applicazione della normativa codiciale possono essere tratte se il can. 395 lo si interpreta e lo si applica nel contesto della responsabilità pastorale che è propria e personale del Vescovo nei confronti della Diocesi. Il Concilio Vaticano II ha sí indicato le funzioni episcopali in una triplice direzione - in relazione al bene comune della Chiesa universale, con le altre Chiese particolari e con le istituzioni supradiocesane - ma ha anche affermato il diverso grado di responsabilità e di impegno con cui tali funzioni devono essere sviluppate. La "sollecitudine per tutte le Chiese" non può diventare il motivo giustificante gli eccessivi impegni extra-diocesani del Vescovo. Essa, infatti, non significa una chiamata del Vescovo ad uscire dalla propria Diocesi per provvedere altrove al bene di tutta la Chiesa. Per diritto divino il Vescovo è posto a capo di una delle porzioni di Popolo di Dio "in quibus et ex quibus" vive e si manifesta la Chiesa universale. È innanzitutto reggendo la sua Chiesa particolare, in comunione con il Collegio episcopale, che il Vescovo diocesano partecipa alla sollecitudine per tutte le Chiese. Il Concilio, infatti, afferma che "hoc suum episcopale munus, quod per consecrationem episcopalem susceperunt, Episcopi, sollicitudinis omnium Ecclesiarum participes, in communione et sub auctoritate Summi Pontificis exercent" (Christus Dominus, 3). In relazione a tale ministero, però, il testo cosí prosegue: "illud exercent singuli quoad assignatas sibi dominici gregis partes, unusquisque Ecclesiae particularis sibi commissae curam gerens aut quandoque aliqui coniunctim necessitatibus quibusdam diversarum Ecclesiarum communibus providentes" (ibidem). Pertanto, se da una parte c'è da salvaguardare una forma di esercizio della potestà episcopale che si proietta sull'intero Popolo di Dio, questa non può prevalere sul primario compito del Vescovo diocesano che è quello di attendere al bisogni della sua Diocesi dove è stato posto perché adempia al suo dovere di Maestro della dottrina, Sacerdote del culto sacro e Ministro del governo (cf. can. 375, § 1). A questo scopo il Vescovo riceve la pienezza del poteri necessari per l'esercizio nella sua Diocesi dei "tria munera" (cf. can. 381). I singoli Vescovi diocesani "sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari" ed "esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale" (Lumen Gentium, 23).
6. La terza domanda posta da codesta Congregazione è "se nel computo del mese si debba calcolare o meno il tempo di vacanze". Sembra, infatti, che cosí lo richieda una retta applicazione del canone perché:
a) dallo studio degli atti relativi all'iter di revisione dal can. 338 del CIC 17 risulta che, del periodo di assenza, sebbene sia stato ridotto ad un mese, se ne parlava in un contesto che riguardava soprattutto le vacanze (divieto di cumulare l'assenza con le vacanze dell'anno successivo). Il nuovo CIC, cosí come del resto il CIC 17, oltre alle predette cause specifiche indica come motivo che giustifica l'assenza "non ultra mensem, sive continuum sive intermissum") una generica "aequa de causa". L'espressione, che è stata ripresa dalla precedente legislazione, era già stata considerata dai commentatori del CIC 17 come riassuntiva di tutte le possibili giuste motivazioni di assenza, tra cui le vacanze. Scriveva, per esempio, il Cappello, "aequa causa quaecumque intelligitur iusta et rationabilis, etiam levis, v. g. recreatio animi, solatium corporis, etc." (F. Cappello, Summa Iuris Canonici, Roma, 1932, vol. 1, p. 462). Cosi il Regatillo: "abesse possunt: ... d) alia iusta causa, verbi gratia, vacationis" (E. Regatillo, Institutiones Iuris canonici, Santander, 1963 Vol. 1, p. 347);
b) le vacanze sono certamente una "giusta causa" e, atteso che per il Vescovo diocesano esse non vengono menzionate in altra parte del CIC, bisogna concludere che il Legislatore vi abbia provveduto proprio con questa normativa, come fece nel diritto precedente (cf. in merito il criterio interpretativo stabilito nel can. 6, § 2). Pensare invece che il Vescovo diocesano abbia diritto ad un supplemento di giorni di assenza dalla Diocesi per le vacanze è una tesi che manca di fondamento. Ciò, infatti, oltre a non trovare riscontro in una norma del CIC e nella tradizione disciplinare della Chiesa, sarebbe contrario allo spirito della legge che impone al Vescovo il grave dovere pastorale di risiedere nella propria Diocesi;
c) l'analogia, infine, con quanto stabilito per i parroci nel can. 533 richiede, per evitare una grossa incongruenza, che anche per i Vescovi il periodo di vacanza non sia superiore al mese.
Città del Vaticano, 12 settembre 1996.
+ Julian Herranz, Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente
+ Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto, Segretario
IV. La partecipazione in modo stabile dei superiori religiosi alla Conferenza episcopale (Communicationes, 29 [1997] 236-238).
Hoc responsum datum est cuidam Congregationi quae, occasione oblata recognitionis Statutorum cuiusdam Episcoporum Conferentiae, a nostro Dicasterio quaesiverat explanationes quoad quasi permanentem Superiorum Religiosorum participationem in Episcoporum Conferentiis. [...]
2. La modifica proposta non è coerente con la storia e la natura delle Conferenze episcopali. L'attuale proposta di partecipazione generale e quasi-permanente di coloro che non sono né Vescovi né equiparati ai Vescovi diocesani chiaramente contrasta con l'intento del Concilio Vaticano II e del Legislatore. La struttura attuale della Conferenza episcopale è radicata nell'insegnamento del Concilio Vaticano II. Nel 1964, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, trattò delle Conferenze episcopali nel contesto della collegialità dei Vescovi: "Simili ratione Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis affectus ad concretam applicationem perducatur" (n. 23). L'anno seguente, la nozione conciliare di Conferenza episcopale venne approfondita nel Decreto sull'Ufficio Pastorale dei Vescovi, Christus Dominus (nn. 37 e 38). Sia il Decreto Christus Dominus che la Costituzione Lumen Gentium trattano delle Conferenze episcopali nel contesto della cooperazione fra i Vescovi diocesani. Coerentemente a questa visione delle Conferenze, il Concilio determinò che: "Omnes Ordinarii locorum cuiuscumque ritus, Vicariis Generalibus exceptis, Coadiutores, Auxiliares aliique Episcopi titulares peculiari munere vel ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum Conferentiis demandato fungentes ad Episcoporum Conferentiam pertinent" (Decr. Christus Dominus, n. 38, 2). La normativa di questo Decreto conciliare circa la partecipazione alle riunioni delle Conferenze episcopali fu oggetto di una interpretazione da parte della Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis nel 1970. La Commissione determinò che: "Cum Conferentiae Episcopales sint coetus episcoporum, eaedem ex episcopis et viris ecclesiasticis in iure ipsis aequiparatis tantum constant, iuxta praescriptum Decreti de pastorali episcoporum munere in Ecclesia Christus Dominus, n. 38,2: alii vero, presbyteri, religiosi et laici invitari possint a Conferentia Episcopali, ad normam statutorum, singulis tamen in rebus et causis et cum voto consultivo tantum" (AAS 62 [1970] p. 793). La nozione di Conferenza episcopale nel Codex Iuris Canonici (1983) trova il proprio fondamento nell'insegnamento conciliare. Infatti, come fu già stabilito in Lumen Gentium e Christus Dominus, il can. 447 del CIC definisce la Conferenza episcopale come un "coetus episcoporum". Similmente, il canone 450, seguendo i criteri già stabiliti dal Concilio, determina tassativamente coloro che possono essere membri de iure delle Conferenze: "Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiare munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes...".
3. L'iter di formazione del can. 450 indica che i criteri determinati per stabilire i membri di diritto e quelli specificamente invitati alla Conferenza furono discussi e scelti con accurata attenzione e precisione. Durante il lavoro di preparazione della nuova legislazione canonica, la citata interpretazione della Commissio Pontificia fu certamente tenuta presente dal Coetus studiorum, "De Populo Dei", nel 1980, nella quinta sessione. Infatti si legge nel relativo verbale: "Si discute sulla proposta di un Organo consultivo se sia il caso di invitare con voto solamente consultivo sacerdoti, religiosi e laici per lo studio di alcuni problemi particolari. Non viene accettata la proposta" (Communicationes 12 [1980] p. 267). Nonostante l'assenza di ulteriori spiegazioni, si può dedurre che per avere il CIC applicato la normativa del Concilio in merito, è evidente che la Commissione Codificatrice, nei suoi lavori, e successivamente il Legislatore, nel rivedere ed approvare il progetto, avevano un criterio ed una "mens" concordante con quella della Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis, la cui interpretazione era stata approvata dal Romano Pontefice il 30 ottobre 1970. L'edizione del "Codex Iuris Canonici fontibus auctus", pubblicato nel 1989, riporta detta interpretazione come una delle fonti per il canone 450. Essa continua ad essere punto di riferimento necessario per una corretta interpretazione del canone 450.
4. Come rilevato nell'appunto di codesta Congregazione, la modifica proposta non è necessaria neanche in seguito all'Esortazione post-sinodale "Vita Consecrata" del 24 marzo 1996 (AAS 88 [1996] p. 423). L'Esortazione sottolinea l'importanza di un rapporto fra i delegati delle Conferenze dei Superiori religiosi e le assemblee delle Conferenze episcopali, ma la frase, "secondo modalità da determinare" non obbliga a stabilire che i delegati religiosi debbano essere invitati a partecipare permanentemente ai lavori dell'assemblea. L'Esortazione, inoltre, non ha introdotto alcuna esplicita modifica della normativa codiciale; ciò che, del resto, non poteva avvenire, vista la natura giuridica di una Esortazione che non è un atto pontificio di carattere legislativo. Essa va quindi letta e interpretata nel contesto della legislazione universale vigente nella Chiesa. È certamente importante coltivare i rapporti fra la Conferenza episcopale e le unioni di Superiori religiosi, ma ciò deve avvenire, per quanto riguarda le riunioni della Conferenza, entro i limiti già chiaramente determinati dalla natura stessa della Conferenza episcopale come voluta dal Concilio Vaticano II e dal diritto vigente (singulis tamen in rebus et causis et cum voto consultivo tantum).
Città del Vaticano, 30 novembre 1996.
+ Julian Herranz, Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente
+ Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto, Segretario
V. Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del vescovo Marcel Lefebvre (Communicationes, 29 [1997] 239-243).
Quoad notitias varias mediis communicationis recenter diffusas hoc Pontificium Consilium opportunum duxit publici iuris facere hanc notam explicativam Congregationi pro Episcopis ab ipso datam.
Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis
Città del Vaticano, 24 agosto 1996
Prot. N. 5233/96
Eminenza Reverendissima, Con lettera del 26 luglio c.a., Prot. N. 329/94, l'Eminenza Vostra Reverendissima inviava a questo Pontificio Consiglio una lettera di S. E. Mons. Norbert Brunner, Vescovo di Sion nella Svizzera, nella quale il Presule - attese alcune confuse informazioni di stampa - chiedeva l'interpretazione autorevole del Motu Proprio "Ecclesia Dei" e del Decreto successivo di codesta Congregazione concernenti la scomunica comminata nel confronti del Vescovo Marcel Lefebvre, dei quattro Vescovi da lui ordinati e del Vescovo emerito Antonio de Castro.
Nel contempo, l'Eminenza Vostra domandava il parere di questo Dicastero circa i termini della risposta da dare al su menzionato Presule. In merito, mi pregio significarle che il problema prospettato dall'Ordinario di Sion non sembra esigere una interpretazione autentica né del Motu Proprio "Ecclesia Dei" del 2 luglio 1988, né del Decreto di codesta Congregazione per i Vescovi del 1 luglio 1988, né dei canoni relativi del CIC: 1364, § 1 e 1382.
Il Presule infatti fonda la Sua richiesta su esigenze d'indole pastorale, per porre fine ad erronee interpretazioni, ma non offre alcun elemento che prospetti l'esistenza o la probabilità fondata di un autentico "dubium iuris" nella normativa dei predetti documenti, condizione indispensabile per una "interpretazione autentica". Ciononostante, per venire incontro alla richiesta di codesto Dicastero, si offrono nell'unita Nota, alcune considerazione e suggerimenti con la speranza che possano essere di utilità per la risposta chiarificatrice che codesta Congregazione intende dare al Vescovo di Sion.
Se invece, la confusione di cui parla li Presule nella Sua lettera fosse rilevante dal punto di vista pastorale, anche perché estesa ad altre diocesi e nazioni dove opera il movimento lefebvriano, si potrebbe ipotizzare una dichiarazione generale della Santa Sede, da preparare in collaborazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede (cf. Nota, n. 5). Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di profonda venerazione dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Dev.mo
+ Julian Herranz, Arcivescovo tit. di Vertara, Presidente
Marino Maccarelli, Sotto-segretario
Con allegato
Allegato al Prot. N. 5233/96
Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi
Nota
Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al
movimento del Vescovo Marcel Lefebvre
1. Dal Motu proprio "Ecclesia Dei" del 2 luglio 1988 e dal Decreto "Dominus Marcellus Lefebvre" della Congregazione per i Vescovi, del 1 luglio 1988, appare innanzitutto che lo scisma di Monsignor Lefebvre è stato dichiarato in relazione immediata con le ordinazioni episcopali compiute il 30 giugno 1988 senza mandato pontificio (cf. CIC, can. 1382). Tuttavia appare anche chiaramente dal predetti documenti che tale gravissimo atto di disobbedienza ha costituito la consumazione di una progressiva situazione globale d'indole scismatica.
2. In effetti, il n. 4 del Motu proprio spiega quale sia stata la "radice dottrinale di questo atto scismatico" e il n. 5 c) ammonisce che una "adesione formale allo scisma" (dovendosi intendere per tale "il movimento dell'Arcivescovo Lefebvre") comporterebbe la scomunica stabilita dal diritto universale della Chiesa (CIC, can. 1364, § 1). Anche il decreto della Congregazione per i Vescovi fa esplicito riferimento alla "natura scismatica" delle predette ordinazioni episcopali e ricorda la gravissima pena di scomunica che comporterebbe l'adesione "allo scisma di Monsignor Lefebvre".
3. Purtroppo, l'atto scismatico che ha originato il Motu proprio ed il Decreto non ha fatto altro che portare a termine, in un modo particolarmente visibile ed inequivoco - con un gravissimo atto formale di disobbedienza al Romano Pontefice - un processo di allontanamento dalla communio hierarchica. Finché non vi siano cambiamenti che conducano al ristabilimento di questa necessaria communio, tutto il movimento lefebvriano è da ritenersi scismatico, esistendo al riguardo una formale dichiarazione della Suprema Autorità.
4. Non si può fornire alcun giudizio sulle argomentazione della discussa tesi del Murray perché non è nota, e i due articoli che ne accennano appaiono confusi. Comunque non può essere ragionevolmente messa in dubbio la validità delle scomuniche dei Vescovi dichiarata nel Motu proprio e nel Decreto. In particolare non sembra che si possa trovare, quanto all'imputabilità della pena, qualche circostanza esimente o attenuante (cf. CIC, cann. 1323-1324). Quanto allo stato di necessità in cui Mons. Lefebvre pensasse di trovarsi, va tenuto presente che tale stato deve verificarsi oggettivamente, e che non si dà mai una necessità di ordinare Vescovi contro la volontà del Romano Pontefice, Capo del Collegio dei Vescovi. Ciò infatti significherebbe la possibilità di "servire" la Chiesa mediante un attentato contro la sua unità in materia connessa con i fondamenti stessi di questa unità.
5. Come dichiara il Motu proprio n. 5 c), la scomunica latae sententiae per scisma riguarda coloro che "aderiscono formalmente" a detto movimento scismatico. Anche se la questione sull'esatta portata della nozione "adesione formale allo scisma" andrebbe posta alla competente Congregazione per la Dottrina della fede, sembra a questo Pontificio Consiglio che tale adesione debba implicare due elementi complementari:
a) uno di natura interna, consistente nel condividere liberamente e coscientemente la sostanza dello scisma, ossia nell'optare in tal modo per i seguaci di Lefebvre che si metta tale opzione al di sopra dell'obbedienza al Papa (alla radice di questo atteggiamento vi saranno abitualmente posizioni contrarie al Magistero della Chiesa);
b) un altro d'indole esterna, consistente nell'esteriorizzazione di quell'opzione, il cui segno piú manifesto sarà la partecipazione esclusiva agli atti "ecclesiali" lefebvriani, senza prendere parte agli atti della Chiesa Cattolica (si tratta comunque di un segno non univoco, poiché c'è la possibilità che qualche fedele prenda parte alle funzioni liturgiche dei seguaci di Lefebvre senza condividere però il loro spirito scismatico).
6. Nel caso dei diaconi e dei sacerdoti lefebvriani sembra indubbio che la loro attività ministeriale nell'ambito del movimento scismatico è un segno piú che evidente del fatto che si danno i due requisiti di cui sopra (n. 5) e che vi è quindi una adesione formale.
7. Nel caso invece degli altri fedeli è ovvio che non è sufficiente, perché si possa parlare di adesione formale al movimento, una partecipazione occasionale ad atti liturgici od attività del movimento lefebvriano, fatta senza far proprio l'atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento. Nella pratica pastorale può risultare piú difficile giudicare la loro situazione. Occorre tener conto sopratutto dell'intenzione della persona, e della traduzione in atti di tale disposizione interiore. Le varie situazioni vanno perciò giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e foro interno.
8. Comunque sarà sempre necessario distinguere la questione morale sull'esistenza o meno del peccato di scisma dalla questione giuridico-penale sull'esistenza del delitto di scisma e la sua conseguente sanzione. A quest'ultimo vanno applicate le disposizioni del Libro VI del CIC (anche i cann. 1323-1324).
9. Non sembra consigliabile formalizzare di piú (ma bisognerebbe interpellare in merito il Dicastero competente: cf. Cost. Ap. "Pastor Bonus", art. 52) i requisiti per il delitto di scisma. Si rischierebbe forse di creare piú problemi mediante un irrigidimento normativo di tipo penale, che non colga bene tutti i casi: lasciando fuori casi di scisma sostanziale, o contemplando comportamenti esterni che non sono sempre soggettivamente scismatici.
10. Sempre dal punto di vista pastorale sembrerebbe anche opportuno raccomandare ulteriormente ai sacri Pastori tutte le norme del Motu proprio "Ecclesia Dei" con le quali la sollecitudine del Vicario di Cristo stimolava al dialogo e a porre i mezzi soprannaturali ed umani necessari per facilitare il ritorno dei lefebvriani alla piena comunione ecclesiale.
Città del Vaticano, 24 agosto 1996.
N.B. Si raccomanda la consultazione dei testi originali presso il sito della Santa Sede. È inoltre possibile richiedere i documenti presso il sito della Libreria Editrice Vaticana.