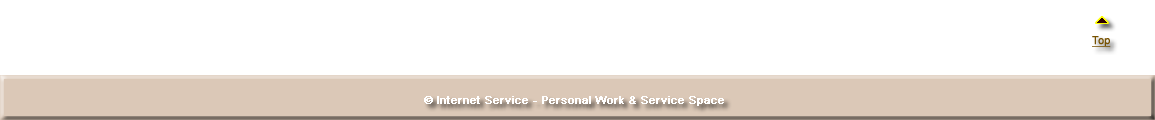Miei carissimi sacerdoti, accompagno anche quest’anno l’indicazione degli appuntamenti comuni, fissati per sostenere il nostro personale e comunitario impegno formazione permanente, con alcune riflessioni che - almeno questa è loro intenzione - potranno aiutarci a meglio intenderla e piú efficacemente realizzarla.
Lo scorso anno - ricorderete - ho richiamato il rapporto tra la formazione permanente, la nostra vocazione al ministero sacerdotale e la nostra missione. Insieme con una vocazione al sacerdozio, c’è “una vocazione nel sacerdozio”, ci ricordava Giovanni Paolo II nell’esortazione apostolica Раstоrеs dabo vobis (cf. n. 70). Da qui deriva prima di tutto la necessità di una formazione permanente. Essa, inoltre, aiuta a rendere nostro ministero sempre piú attento e capace di interpretare l’annuncio nella fedeltà а Dio e all’uomo. Trattando, da ultimo, dei diversi livelli su cui è possibile attuare la formazione permanente, richiamavo importanza di quello soggettivo, in quanto il primo responsabile della formazione permanente è il sacerdote stesso. Niente e nessuno potrà mai sostituire la disponibilità e l’impegno personali. Si tratta di questioni davvero importanti e, perciò, da non dimenticare.
Per questo anno pastorale desidero mettere in luce un tema che è stato sottolineato durante la 56a Assemblea Generale della CEI del maggio scorso nella quale, come di sicuro ricorderete, i Vescovi hanno diffusamente trattato della vita e del ministero dei presbiteri. I testi di alcuni brani dell’intervento del papa Benedetto XVI e della parte della prolusione del cardinale Presidente della CEI dedicati al ministero presbiterale, insieme con l’ampia relazione introduttiva del vescovo di Piacenza-Bobbio, Mons. Luciano Monari che ha introdotto la discussione e con la sintesi dei lavori gruppo sono ora pubblicati in un apposito fascicolo, disponibile nelle librerie cattoliche. Al tutto è premessa una semplice e breve Lettera ai sacerdoti italiani. Certamente vorrete leggerla e meditarla anche personalmente.
Proseguendo, allora, nella proposta di alcuni qualificanti la formazione permanente, vorrei adesso sottolineare riguarda l’importanza, per noi sacerdoti di avere una regola di vita. Si tratta, in altre parole, della necessità di pervenire ad una disciplina interiore ed esteriore, senza la quale non è possibile vivere bene.
La “regula”, la “forma” e la “formula vitae”
Inizio con alcune annotazioni sul significato del termine “regola” nella tradizione spirituale cristiana, da cui può anche arrivarci un aiuto per intuire il profondo valore di una regola di vita, che non può essere intesa come precetto esterno da osservare, ma piuttosto come interiore convinzione da cui scaturiscono scelte consapevoli.
Viviamo nell’era delle programmazioni al punto da sentirci un po’ tutti dei “programmatori”. Non, evidentemente, nei senso tecnico e specifico dell’informatica, ma almeno per quanto riguarda le nostre attività e il nostro tempo. Facciamo, infatti, programmazioni per le nostre parrocchie, ogni anno pastorale stiliamo calendari, piú o meno dettagliati e affollati, riguardo agli impegni e alle scadenze settimanali, mensili, annuali; abbiamo gli orari per la celebrazione delle Sante Messe domenicali - festive e feriali, per la catechesi, per particolari celebrazioni e scadenze...
È giusto che questo sia. In tutto questo “programmare”, però, sorge una domanda che ci sollecita a procedere oltre i nostri impegni e le nostre attività. Si tratta, infatti, un interrogativo che ci riguarda personalmente e ci. domanda di trasferirci dal pur importante livello del fare a quello, piú profondo e fondamentale, dell’essere. La domanda è la seguente: Iso previsto una”pro azione”per la mia vita? Diciamolo meglio: c’è una regola per la mia vita? Qual è? Cosa, piú in particolare, può voler dire avere una regola di vita? Per dare una prima risposta a questa domanda osserviamo anzitutto, per quanto rapidamente, il termine “regola”.
Esso deriva dalla lingua latina, da cui assume il primo significato di norma, di guida m l’agire e via per l’operare. Nella letteratura cristiana dei primi secoli, però, questa accezione si specifica come maniera di vivere conforme ad un modello originario, specialmente quello di Gesú coi suoi apostoli. Si passa successivamente ad un significato piú formale per indicare una serie di testi, a volte carattere spirituale e altre volte di carattere normativo destinati a coordinare la vita di una comunità religiosa. Universalmente nota è la Regula di San Benedetto, quale da buon maestro non trascura di lasciare una sorta di spiegazione del termine: Regula appellatur ab hoc quod oboedientum dirigat mores, “è chiamata Regola perché dirige la vita di quelli che obbediscono” (dall’Incipit). Consideriamo brevemente questo insegnamento spirituale.
La regola benedettina è una direttiva morale, un modello di esistenza che si propone a ogni uomo, senza che lo si imponga ad alcuno. Cosí spiegava San Bernardo, che aggiungeva: le regole sono state inventate e istituite non perché non fosse lecito vivere altrimenti, ma perché siano a servizio della carità (pro caritate inventa fuerunt, SAN BERNARDO DA СHIАRАVАLLЕ, De praecepto et dispensatione II, 5). Anche una regola di vita, allora, deve scaturire non da una legge esterna, ma dal vincolo di amore che ci lega a Cristo e ai fratelli. Ce lo conferma San Tommaso d’Aquino, il quale trascorse nel cenobio di Montecassino nove anni della sua fanciullezza e della sua adolescenza ricevendone nell’animo un segno indelebile. Spiegava, dunque, che il primo interesse di San Benedetto nel redigere la Regola non era la sua osservanza, quanto piuttosto il progresso spirituale del monaco, il quale mediante la professione monastica promette a Dio la conversione dei costumi secundum regulam (cf. Quodlibet. I, q. 9, a.4 co.). La conversione, allora: è questo il primo scopo di una regola di vita, secondo il detto di Gesú: Convertitevi e credete al Vangelo (Mc 1,15).
Altra Regula famosa nella storia della Chiesa e, per chi è cura animarum, con la stessa importanza di quella benedettina per la vita monastica, è quella pastoralis di San Gregorio Magno. Benedetto XVI nell’Angelus del 3 settembre scorso ne ha sintetizzato cosí il contenuto: “La vita del pastore d’anime deve essere una sintesi equilibrata di contemplazione e di azione, animata dell’amore che ‘tocca vette altissime quando si piega misericordioso sui mali profondi degli altri. La capacità di piegarsi sulla miseria altrui è la misura della forza di slancio verso l’alto’ (II, 5). A quest’insegnamento, sempre attuale, si sono ispirati i Padri del Concilio Vaticano II per delineare l’immagine del Pastore di questi nostri tempi”.
Durante questa brevissima carrellata sul termine “regola”, però, non abbiamo ancora trovato esplicitamente l’espressione regola di vita. Qualcosa di molto simile, invece, si trova nella regola che San Francesco d’Assisi scrisse per i suoi frati. Essa è una regula vitae, una regula vivendi: osservarla vuol dire assumere una forma particolare di vita, un modo di vivere che rispecchia il Vangelo (cf. FF 75).
In questo senso la regola è pure una formula vivendi, o una forma vitae (cf. FF 2745). Vivere la regola, in altre parole, significa dare alla propria vita la forma del Vangelo, la forma di Gesú. Francesco, difatti, diventerà anche visibilmente cristiforme mediante l’impressione delle stimmate che - per le parole di San Bonaventura - trasformeranno l’amante nell’immagine perfetta dell’Amato (Leggenda minore IV: FF 1377).
Nella tradizione ecclesiastica, ad esempio nella Regula “primitiva” dell’Ordine Carmelitano (1206/1214), troviamo pure l’espressione formula vitae (cfr. nn. 3.24). In questa regola саrmelitanа (la piú breve tra le “Regole” conosciute) si vede chiaro che la formula vitae ha lo scopo, mediante il richiamo dei precetti biblici, di dare “forma” (formula) ad un progetto di vita perché esso giunga al suo compimento.
Dare forma alla vita
Queste rapide annotazioni storiche ci aiutano a comprendere che l’unico modo per dare valore di crescita personale ad una “regola di vita” è di riconoscerle il carattere della formazione e d’inserirla nel proprio progetto di formazione permanente.
La “regola di vita” è ciò che segue necessariamente a chi avendo ricevuto un dono da Dio sa di avere il dovere di ravvivarlo ed è proprio questo lo scopo della formazione permanente. Lo spiegava bene il papa Giovanni Paolo II nella Pastores dabo vobis. Commentando il testo di 2Tm 1,6: Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, il Papa scrive: “L’Apostolo chiede a Timoteo di «ravvivare», ossia di riaccendere come si fa per il fuoco sotto la cenere, il dono divino, nel senso di accoglierlo e di viverlo senza mai perdere o dimenticare quella «novità permanente che è propria di ogni dono di Dio, di Colui che fa nuove tutte le cose, e dunque di viverlo nella sua intramontabile freschezza e bellezza originaria. Ma quel «ravvivare» non è solo l’esito di un compito affidato alla responsabilità personale di Timoteo, non è solo il risultato di un impegno della sua memoria e della sua volontà. È l’effetto di un dinamismo di grazia intrinseco al dono di Dio: è Dio stesso, dunque, a ravvivare il suo stesso dono, meglio, a sprigionare tutta la straordinaria ricchezza di grazia e di responsabilità che in esso è racchiusa” (n. 70).
Con la “formazione” si dà forma alla propria vita e questa, a sua volta, raggiunge il suo scopo proprio quando l’uomo è formato. R. Guаrdini ha scritto in proposito delle pagine molto interessanti. Cito solo alcune righe da un libro, che ha alta attinenza con la ars celebrandi, termine privilegiato in questo anno pastorale 2006-2007: “Formato in senso giusto è un uomo che é plasmato nell’essere, nel pensare е nell’agire secondo un modello interiore naturale” (Formazione liturgica, ed. Milano it. 1988, p. 32). S’intende che un uomo può dirsi davvero “formato” quando la vita interiore e spirituale regola l’agire е si esprime adeguatamente nella corporeità. La formazione, per questo, è un dovere quotidiano (permanente).
Opportuna in proposito è l’osservazione dei Vescovi riportata nel quinto punto della sintesi delle relazioni dei gruppi di studio cui accennavo all’inizio: “E necessario anzitutto che vescovi, preti e seminaristi concepiamo la vita come un prodotto da finire, un progetto da portare a compimento, e non semplicemente come la possibilità di consumare le tante esperienze che in essa ci possono essere offerte. Se partiamo dalla prospettiva che la vita è un compito da realizzare al meglio con tutta la genialità, la pazienza e la forza che il Signore dà, il discorso della regola viene di conseguenza... Certo, la regola deve scaturire dall’interno, ma è indispensabile per raggiungere gli obiettivi che stanno a cuore a ogni prete”.
Avere una regola di vita significa, lo ripeto, dare forma alla propria vita, plasmarla quotidianamente, rimodellarla ogni giorno. E l’impegno che ci giunge dalla stessa parola “forma”, intesa secondo la filosofia scolastica. In questo senso come l’anima forma corporis è un principio interiore che vivifica una realtà corporea e la rende capace di operare, cosi una regola è forma vitae quando dà una direzione alla vita e la orienta verso un retto agire, verso il compimento dei suoi fini, verso il vero, il buono, il bello. Dare forma alla propria vita comporta dunque un impegno creativo, che intende come imitare l’opera creatrice di Dio il quale, come leggiamo nel Libro della Sapienza, ha “ordinato ogni cosa con misura, numero e peso” (11,20).
Il testo biblico che ho appena citato e che è formulato con categorie proprie della filosofia greca, ha avuto un enorme successo nella storia del pensiero cristiano. Letteralmente essa intende affermare che a Dio in quanto creatore del mondo non mancano né la forza, né i mezzi per annientare e sterminare gli empi e ciò senza turbare l’ordine della creazione. I medievali, soprattutto, hanno ripreso piú volte questo brano, interpretandolo in senso allegorico e morale.
Basti citare per tutti San Bonaventura, che scelgo sia perché, insieme con San Tommaso, è tra i sommi maestri del pensiero medievale, sia perché egli fu cardinale vescovo di Albano e deve esserci anche per questo particolarmente caro. Ora, commentando il racconto biblico dell’opera dei sei giorni, il nostro santo dottore ripete il testo sapienziale e lo commenta spiegando che proprio per questo la creazione porta il segno della Trinità. La misura, il numero e il peso, difatti, manifestano la sapienza di Dio e il suo mistero trinitario, come l’orma il piede (cf. Collationes in Hexaëmeron II. 23). È solo uno dei molti passaggi coi quali Bonaventura esprime la sua idea di un mondo ordinato secondo rapporti matematici.
Misura, numero e peso, sono l’orma di Dio sulla creazione, Dante tradurrà poeticamente cosí: “La gloria di Colui che tutto muove / per l’universo penetra e risplende una parte piú e meno altrove” (Paradiso, I, 1-3). La conseguenza, prosegue Bonaventura, è che dalla misura, dal numero e dal peso come da un’impronta, l’intelletto può elevarsi alla conoscenza della potenza, della sapienza e dell’immensa bontà di Dio (cf. Itinerarium mentis, I, 11). Possono anche essere la sua impronta sulla nostra vita.

Una Regola di vita è ordinare se stessi
Cosa, allora, potrebbe significare dare alla propria vita il senso della misura, del numero e del peso perché ciò sia per noi una regola di vita, forma vitae?
I. Il senso della misura, anzitutto. Mi pare che esso implichi almeno due cose, cui la prima è avere il senso del confronto. Misurare, difatti, vuol dire individuare una quantità (per la materia), o un’estensione (per lo spazio), o una durata (per il tempo) ignote per mezzo di un’altra conosciuta. Senza questa comparazione, senza un tale confronto sarebbe impossibile dire che una quantità è piú pesante che una estensione e piú ampia... Per essere compiute, tutte queste affermazioni hanno bisogno di un confronto.
Ugualmente, anche una vita “misurata” è consapevole di non essere un assoluto e sa di dovere vivere in confronto, meglio in relazione con altre vite, con altre storie personali con cui incontrarsi e dialogare. Chi si ripiega nell’egocentrismo e si chiude ad una positiva relazione con l’altro si avvia inevitabilmente verso una vita sregolata. Come pure sregolata è la vita di chi non ha il senso del limite, poiché proprio qui s’individua un’altra caratteristica della vita “misurata’’.
Qualcuno a proposito ricorderà l’espressione oraziana est modus in rebus, “ogni cosa ha la sua misura”. Essa corrisponde alla categoria aristotelica della mésotes o mediocritas, che all’epoca non aveva la connotazione negativa moderna di “mediocrità”, ma costituiva il cuore profondo del sistema generale della virtú. Lo stesso San Tommaso pose al centro della propria idea di etica la coltivazione della virtú e della felicità virtuosa. “Tutte le virtú morali - insegna A. Tanquerey, un classico maestro di ascetica - mirano a serbare il giusto mezzo tra gli opposti eccessi: in medio stat virtus. Devono infatti seguir la regola segnata dalla retta ragione illuminata dalla fede. Ora si può mancare a questa regola oltrepassando la misura o rimanendone al di qua: la virtú quindi consisterà nello schivare questi due eccessi”.
In un suo recente volume di carattere antropologico, il noto neurologo e psichiatra V. Аndrеоli ha dedicato un saggio “anatomico” all’uomo sregolato osservando che oggi, purtroppo, l’unica regola è fissare regole e non seguirle (cf. Dietro lo specchio. Realtà e sogni dell’uomo di oggi, Milano, 2005, p. 35). Qualcuno, ricorderà pure la canzone di Vasco Rossi intitolata “Vita spericolata”. E un testo che descrive in modo abbastanza efficace quella che potremmo chiamare una vita sregolata: “Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film, voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen, voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte cosí... E poi ci troveremo come le stars a bere del whisky al Roxy bar, o forse non c’incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi”. Alla fin fine c’è una morale anche in questa canzone: una vita esagerata e senza misura conduce all’isolamento e all’incomunicabilità.
2. Quanto al senso del numero potrebbe voler dire che occorre dare alla propria vita quel ritmo che è proprio dei numeri, anzi quell’armonia che gli antichi filosofi pitagorici scoprivano nei numeri e riconoscevano presente e operante nel cosmo come nella stessa vita umana. Ancora da San Bonaventura cogliamo un’interpretazione fatta alla luce della tradizione pitagorica nota ai medievali attraverso autori classici e cristiani, principalmente attraverso gli scritti sulla musica di Sant’Agostino e di Boezio: “Poiché dunque tutte le cose sono belle e in qualche modo dilettevoli; e poiché non c’è bellezza e diletto senza proporzione; e la proporzione si ritrova principalmente nei numeri, ne consegue che tutte le cose siano costituite da numeri; e perciò “il numero è il piú importante esemplare nell’animo del Creatore» e nelle cose il piú notevole vestigio che guida alla Sapienza...” (Itinеrаrium mentis, II, 10).
Vita ordinata sul senso del numero, allora, è una vita equilibrata tra contemplazione e azione, che riconosce e distingue quando è il tempo del silenzio e quando quello della parola, il tempo dello stare fermi e quieti e quello del darsi da fare perché qualcosa finalmente si ottenga... Giustamente, Mons. L. Monari diceva cosí nella sua relazione ai Vescovi italiani: “Difendere ritmi equilibrati e distesi: il riposo e il lavoro, la preghiera e il servizio, il rapporto con gli altri preti e quello coi parrocchiani, lo studio e la distensione... L’equilibrio tra questi diversi momenti va cercato e deciso consapevolmente. Non si può vivere «sul momento» e sperare che le cose si equilibrino da sé e si aggiustino sé; questo soprattutto in una società caotica e liquida come la nostra”.
Molto opportunamente, poi, si pongono in maggiore risalto alcuni ritmi fondamentali nella vita di un prete: fra questi, il ritmo fra riposo e lavoro sicché non si è di sicuro indolenti, o fiacchi, o negligenti, o pigri, ma neppure degli stacanovisti della pastorale. Un prete stressato è a rischio quanto un prete svogliato.
Da qui, il bisogno di prevedere già all’interno della propria giornata il momento in cui sospendiamo il nostro fare per accedere alla quiete e al riposo.
Ha avuto molta fortuna una sentenza di Aristotele, ripresa pure da San Tommaso d’Aquino il quale la ripete cosí: in quiescendo et sedendo, anima fit sарiеns et prudens, “quando uno entra nella quiete acquista la sapienza, poiché è proprio nella quiete e nel riposo che l’anima diviene saggia e prudente” (De anima, I, 8, 19).
La medesima legge interiore vale per la nostra vita spirituale, che esige il ritmo tra preghiera e ministero. “Il tempo che riserviamo alla preghiera - ha detto proprio a noi Benedetto XVI durante l’incontro del 31 agosto scorso - non è tempo sottratto alla nostra responsabilità pastorale, ma è proprio «lavoro» pastorale, è pregare anche per gli altri... [il] dialogo con Dio è opera pastorale”.
È dunque necessario vivere il giusto equilibrio tra lavoro e riposo, ferialità e festività, tra dovere e distensione, “ ma anche tra Marta e Maria, tra la gente seguire e il Maestro da ascoltare, tra lo studio personale е le attività da organizzare...” (А. СЕNCINI, Il respiro della vita. La grazia della formazione permanente, ed. San Paolo 2002, p. 120).
3. Il senso del peso ritengo possa intendersi come capacità di individuare е riconoscere l’esistenza di una gerarchia nei valori e nelle verità, come pure nelle scelte pastorali da fare. Quanta sapienza nelle parole del Papa quando nel dialogo con noi si confidava: “Tante cose succedono giorno per giorno e non sono grado di rispondere a tutto. Faccio la mia parte, faccio quanto posso fare. Cerco di trovare delle priorità”.
Non si tratta semplicemente di rinunciare a comportamenti negativi (giacché i comandamenti “al negativo”, ossia non fare, non dire..., valgono pure per noi sacerdoti), oppure di non compiere attività superflue e inutili, se non addirittura controproducenti. Si tratta, piuttosto, di mettere ordine anche fra le cose fare, anche tra quelle necessarie. Tutto questo si farà ritenendo che lo stesso imprevisto nella propria giornata, se pure in principio può comprensibilmente essere percepito con senso di timore e anche fastidio, esige, in ultimo, d’essere interpretato come sorpresa e interpellanza di Dio.
Riconoscere una gerarchia nei valori e nelle verità non significa affatto sostenere che un valore lo sia meno di un altro, o che una verità sia “meno verità” di un’altra. Tra valore e disvalore, tra verità e falsità non c’è una via di mezzo. Tutti i valori, tuttavia e tutte le verità prendono il loro principio e la loro validità da una Verità e da un Valore, cui sono in vario modo collegati e da cui dipendono, come lo sono i punti dislocati su di un raggio dal centro alla circonferenza. L’esistenza di una hierarchia veritatum, insegnata dal Vaticano II in ragione del differente rapporto di ciascuna verità col fondamento della fede cristiana (cf. Unitatis redintegratio, 11), ha la sua rilevanza non soltanto nel contesto del dialogo ecumenico, ma per ogni forma di dialogo e per tutta la vita di relazione. Anche per la vita personale e per la relazione pastorale. Torno, allora, a citare dalla relazione di Mons. L. Monari: “Se ci lasciamo «portare» dalle urgenze immediate, il ministero diventerà necessariamente frammentato e alcune attività pastorali saranno trascurate (il confessionale; la visita agli ammalati...). Bisogna che la scelta delle diverse attività nasca da una riflessione vera е propria, da una scelta consapevole”.
Conclusione
Occorre, in ultima analisi, che ciascuno di noi risponda alla domanda: su cosa definitivamente io regolo la mia vita? Su me stesso, sugli amici... oppure su Cristo e la Chiesa, che è il suo Corpo? Giacché poi sono ministro della Chiesa e sono posto a guida di una comunità di fedeli, regolo la mia vita sulla Chiesa? Accetto pure di ricevere una regola dalla Chiesa (cfr. CIC can. 276)?
Sono propositi di non poca importanza: dare a se stessi una regola di vita; accogliere dalla Chiesa una “regola” per il proprio stato di vita...
Al compimento della nostra vita terrena tutti noi saremo misurati come leggiamo nell’Apocalisse: “Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: «Alzati e misura il santuario di Dio e l’altare e il numero di quelli che vi stanno adorando. Ma l’atrio che è fuori del santuario, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani...»“ (11,1-2).
In tale contesto, carissimi sacerdoti, vogliate inserire pure le indicazioni riguardo alle offerte di iniziative comunitarie per la formazione permanente in questo anno pastorale. Esse guardano sostanzialmente verso due direzioni:
- la via di Emmaus con il suo impegno a celebrare nelle nostre comunità una liturgia seria, semplice e bella;
- un deciso impegno nella pastorale vocazionale che conduca a rendere vocazionale tutta la nostra pastorale.
Albano Laziale, 26 settembre 2006
Memoria di S. Senatore, martire
+ Marcello Semeraro