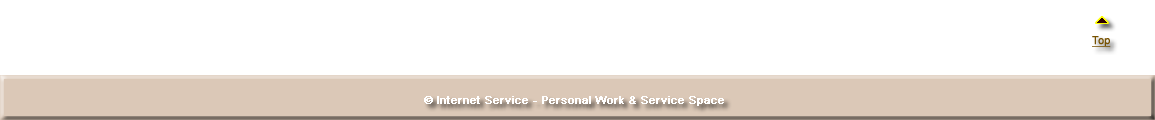L'aldilà, ovviamente, esiste?
[...] Ernst Bloch fu messo in crisi nel suo giovanile fervore di marxista bigotto quando venne a sapere che, sul letto di morte, buona parte dei burocrati del partito mettevano da parte i loro sacri testi e facevano chiamare di nascosto il prete o il pope. Giunti su quella soglia oltre la quale non c'è che mistero, pare dunque che nessuna dialettica, per quanto sofisticata, basti a rassicurare.
Posti in concreto davanti all'enigma, neppure i custodi dell'ortodossia ateistica si fidano della loro fede. C'è da capire i loro dubbi, visto che, in una delle sue spiegazioni più note, il marxismo cerca di giustificare il sorgere della universale credenza nell'aldilà rinviando addirittura alla esperienza degli antichi popoli cacciatori: «Constatando il rinnovarsi indefinito della selvaggina, per quanto la si abbattesse, quei primitivi si convinsero che la vita sfida la morte e giunsero così a credere a una sopravvivenza...».
Questa, come tante altre che ti risparmio, è spiegazione che può forse impressionare i militanti di poche pretese di una sottosezione della provincia balcanica. Ma che non sembra convincere neppure i divulgatori se, quando le parole fanno posto all'angoscia e al tormento del mistero, si scomodano nottetempo gli uomini delle religioni, con le loro risposte irrise in pubblico e perseguitate come mitologiche. Troppo facile l'ironia davanti a teorie, come quella della selvaggina, scovate a posteriori per giustificare gli a priori ideologici. Non sembrano davvero appartenere a "popoli cacciatori" i milioni di giovani operai, studenti, intellettuali, professionisti, che rendono così agitato il sonno dei Signori dell'Est. Dopo tanti decenni di persecuzione e di propaganda sul dopo-la-morte-il-nulla-come-dice-la-scienza, il risultato è che la percentuale dei praticanti nella stessa Unione Sovietica è superiore alla percentuale della Francia e della stessa Italia. Ancora più alto, in quel Paese di martellante "ateismo scientifico", il numero di coloro che per sé e per i propri cari cercano di avere funerali religiosi.
Davanti alla misteriosa angoscia della morte, lo stesso Leonid Breznev, Capo dei Capi di tutte le Russie, buttò a mare i molti volumi editi dall'Istituto per l'ateismo di Leningrado e - alla pari di un pellegrino a Lourdes, a Epidauro, a Benares, a La Mecca - ritornò ben volentieri a quella che i suoi propagandisti chiamano "mentalità prescientifica". Per allontanare lo spettro della fine, il compagno Breznev, il massimo custode dell'ortodossia, si affidò così a un'intera équipe di guaritori, sensitivi, santoni, sciamani: tutta gente, insomma, che con i suoi poteri - veri o presunti che siano - va ben al di là delle tranquillizzanti teorie materialistiche e apre strane prospettive su una dimensione "altra" di cui si beffava l'ingenuo positivismo ottocentesco di un Marx e di un Lenin. Anche Leonid Breznev era tenuto a beffarsene: ma dal podio del Comitato Centrale, quando la morte è lontana; non in privato, quando quel mistero incombe (cfr. MESSORI V., Scommessa sulla morte. La proposta cristiana: illusione o speranza?, Torino 19823, 130-131).
___________________
Metempsicosi, reincarnazioni
[Alla] base di ogni concezione reincarnazionista c'è uno "spiritualismo", c'è un credere di dover salvare, nell'uomo, soltanto l'"anima"; atteggiamento cui fatalmente corrisponde indifferenza se non disprezzo per il corpo.
Per il cristianesimo, invece, l'uomo - ogni uomo: bello o brutto, nobile o plebeo, genio o beota - è un'unità inscindibile e irripetibile di elementi spirituali e materiali. Il nostro corpo non è un vestito che si possa cambiare né un involucro provvisorio da lasciare al suo destino per trasferirci in un altro vestito, in un altro involucro. Noi non abbiamo un corpo, noi siamo anche un corpo, dice il sano "materialismo" cristiano. Oggetto dell'amore di Dio nel crearci, nel redimerci e infine nel farci godere di Lui eternamente non è un'"anima" ma una persona umana nella sua completezza. Come già insegnava san Tommaso d'Aquino nel suo linguaggio medievale, "questa mia anima è 'forma sostanziale' di questo mio corpo", non può dunque trasmigrare altrove, nell'angoscioso itinerario dei cicli metempsichici. Per il Vangelo, tutto l'uomo, non una sua parte soltanto, è immortale: il Cristo, nel suo Regno, non è il "re delle anime" purificate da penose reincarnazioni; è il "re degli uomini", salvati, risorti gioiosamente per sempre nella loro individualità irrinunciabile. Coloro che credono sia "più moderno" prendere sul serio la metempsicosi invece che l'escatologia cristiana, non si rendono forse conto che si tratta di un pauroso salto all'indietro.

È un ritornare all'idea greca del corpo come prigione dell'anima; è un unirsi al disprezzo, talvolta all'orrore e all'odio asiatici verso la "materia" - a cominciare da quella che ci permette di vivere nel mondo con il nostro corpo - per combatterla, ignorarla, superarla, umiliarla, vincerla, annientarla.
Non ci si rende conto che la millenaria lotta cristiana contro ogni fede nella reincarnazione è anche difesa del concetto di "persona" come realtà unica, irripetibile e dunque più che ogni altra preziosa.
Non ci si rende conto che il "no" cristiano è anche la riaffermazione dell'assoluta dignità e preminenza dell'uomo [...] (Idem, 192-193).
Per un peccato
Ricorda il Vaticano II, richiamandosi all'insegnamento cristiano di sempre: «L'uomo sarebbe stato esentato dalla morte corporale se non avesse peccato». Si rinvia così a ciò che con efficacia sintetizzava san Paolo: «Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato» (Rom. 5,12). In tal modo, «la morte è il salario del peccato». (Rom. 6,23). Il "solo uomo" cui allude l'apostolo è Adamo, il "peccato" è quello che dalla teologia cristiana è tradizionalmente indicato come "originale". Un termine - peccato originale - che risale a sant'Agostino e che è forse da rivedere: ma sembra proprio non sia da rivedere, se non per ribadirla con forza, la realtà misteriosa che sta dietro a quelle due parole. È una realtà che è essenziale alla fede, contrassegnata dalla sequenza: Adamo-Gesù; peccato dell'uomo-redenzione del Cristo.
Pochi aspetti del cristianesimo come il "peccato originale" (o come lo si voglia chiamare) sono rifiutati dalle culture moderne, tutte basate sulla presunzione di innocenza dell'uomo, tutte convinte che il solo vero male sia parlare del male. Ed è, lo vedemmo, una negazione tanto violentemente isterica da far insospettire che dietro si nasconda qualcosa. A soccorso dei troppi "innocentisti" corrono - ça va sans dire - i soliti teologi spensierati, quei chierici superficiali e bonaccioni che già conosciamo, quelli convinti che fra gli "umanesimi" moderni dalle conseguenze così tragiche e la visione cristiana dell'uomo le differenze non siano che di dettaglio, frutto di banali equivoci da sfatare facilmente, con qualche appropriata "rilettura". Mentre proprio qui, sul peccato, si spalanca il «grande abisso» (Lc. 16,26) che separa la fede in Gesù dalla fede in ogni mito "mondano". Varrà la pena di ritornarci sopra con abbondanza in una prossima occasione, se il tempo e le forze saranno conservate. Non da oggi, infatti, tento di approfondire un punto come questo, così imprudentemente dimenticato eppure così decisivo. Sin da ora, però, è doveroso avvertire che, qui più che mai, conviene informarsi prima di beffarsi (ils rient de ce qu'ils ignorent), stando attenti a non scambiare la credenza nel peccato originale per la solita, ingenua favola cristiana, adatta a bambini, contadini analfabeti, ritardati mentali.
«Il peccato di Adamo è follia davanti agli uomini, ma noi lo presentiamo appunto per tale. Non dovete dunque rimproverarmi il difetto di ragione in questa dottrina, perché io la do proprio per tale. Eppure, questa follia è più saggia che tutta la saggezza degli uomini. Nulla è più incomprensibile del peccato originale; ma tutto diventa incomprensibile se lo si nega». Così, nel Seicento, Blaise Pascal che ancora non immaginava come la storia seguente, con lo scatenamento degli infernali disastri che contrassegnano la "modernità", avrebbe reso assai meno assurdo questo aspetto della fede. È certamente possibile ironizzare sul "vecchio mito della mela e del serpente", soprattutto se si ignora che ciò che importa alla fede (e dunque ciò che il cristiano deve credere) non è necessariamente l'esistenza storica di un uomo chiamato Adamo, di una donna chiamata Eva. Alla fede importa ciò che quei "simboli", quei "miti" (simboli e miti, è noto, sono "falsità" solo per il rozzo razionalismo moderno occidentale, mentre per ogni altra cultura sono verità di un ordine superiore) vogliono indicare: una misteriosa frattura, cioè, una deviazione, una ribellione al piano di Dio sin dall'inizio della storia.
Chi è consapevole di quel che vuol dirci la fede nelle prime pagine della sua Scrittura chi conosce l'uomo e il suo cuore e la sua storia; costui potrebbe alla fine scoprire che i veri ingenui sono quelli che si vantano di essere ormai liberi dal "tabù repressivo del peccato", come dicono con disarmante superficialità scambiata per profondità intellettuale. Chi cerca, chi riflette, può scoprire che il "peccato originale" non è essenziale solo per la fede - e ciò valga per i troppi cristiani che oggi lo negano o lo ignorano - che senza di quello vede il Cristo Redentore e Salvatore ridursi a un qualunque "signor Gesù", un saggio, un moralista, un contestatore come tanti, ma abbastanza blando per rischiare un Nobel per la pace o un premio dell'ONU, dell'UNESCO o di qualche altra costosa ipocrisia del genere. Ma chi cerca, chi riflette può scoprire che tener conto della ipotesi-peccato originale può essere essenziale anche al di fuori della fede, per chiunque voglia capire la tragedia di ogni uomo e della storia intera. «La dottrina del peccato originale e del peccato dell'uomo in generale è forse la sola credenza cristiana che possa essere verificata empiricamente, quasi scientificamente, da chi guardi con oggettività dentro e fuori di se stesso; da chi guardi alla malizia che, impastata al bene, sta al fondo del suo cuore e alla malvagità, mescolata all'eroismo, che constata nella storia». Così Rudolf Niebuhr, il teologo americano, esponente cioè di una cultura tra le più ottimiste e innocentiste della storia.
Per la fede la morte è dunque catastrofe di tali proporzioni che Dio stesso avrebbe dovuto patire e morire per vincerla con la risurrezione. Il peccato originale, questa misteriosa realtà all'inizio della storia, ogni peccato poi, gli innumerevoli peccati che hanno seguito quel primo, separano l'uomo da Dio. Ed è proprio questa separazione ad essere morte: morte spirituale, innanzitutto, di cui la morte fisica non è che un segno. Così che - per la fede molti che sembrano vivi sono morti, anche se non lo sanno; e molti morti sono più vivi dei vivi. Dico "molti morti" perché, se per qualcuno la terribile possibilità chiamata inferno si è concretizzata, ebbene costui è davvero morto e in modo radicale, pur misteriosamente abbastanza vivo per soffrire in eterno il suo definitivo no all'Amore: è nel "dannato", infatti, che il peccato (e, dunque, la morte) hanno vinto in modo totale e definitivo. Peccato = morte: in questo legame individuato con tanta chiarezza dalla tradizione biblica, e da quella sola, ci sono verità che sfuggono soltanto a chi non vuol vederle. È sempre stato evidente che il peccato (personale e sociale) non ha unicamente la dimensione verticale visibile al credente; ma ha anche una dimensione orizzontale, ben evidente a tutti: genera infatti morte sotto forma di omicidi, guerre, sfruttamenti, ingiustizie, violenze di ogni tipo; tra le quali, oggi, anche avvelenamenti e inquinamenti della terra e degli uomini.
Ma, nel legame peccato-morte additato dalla fede, ci sono anche profondità meno evidenti che soltanto ora cominciamo a intravedere, con stupore. «Chi non ama rimane nella morte» constata l'apostolo Giovanni (1 Gv. 3,14). Noi oggi sappiamo "scientificamente" che è il non amare, che è l'odio - che è dunque il peccato - a nascondersi dietro tanti nostri guai, tante malattie, tanta morte. Noi oggi sappiamo, ancora una volta "scientificamente", che amare - dunque opporsi al peccato guarisce, porta la vita. George Vickers, il grande psicologo inglese, dice quel che in mille forme conferma una folla di suoi colleghi: «La più significativa scoperta della scienza odierna è forse il potere dell'amore di proteggere la salute psicofisica e di ristabilirla». Tutta la medicina più moderna, quella che dalla sua parte ha il futuro - la "psicosomatica" - smaschera la cecità arrogante della medicina illuminista che guarda all'uomo come a un semplice complesso di reazioni chimiche e di leggi fisiche, da curare così come si aggiusta una macchina. La psicosomatica insegna invece - esperienze concrete alla mano - che la malattia si manifesta nella carne ma nasce nello spirito. I "nuovi medici" sanno che l'amore dà la vita, che il peccato - che è sempre non-amore - dà la morte. È la disarmonia dello spirito che spezza l'equilibrio del corpo e delle sue funzioni. Pare che persino il cancro, questo flagello del secolo che non crede al peccato, spesso non sia che peccato: altro non sia, cioè che la rivolta delle cellule, impazzite per la violenza che l'uomo fa alla sua vocazione profonda quando si orienta (o è obbligato a orientarsi dalla pressione di una società disumana) verso l'odio di sé e degli altri. Non si parla, è chiaro, in senso moralistico: si parla di "colpa" incosciente, di atteggiamento errato davanti all'appello ad amare nascosto nella nostra stessa struttura di persone.
Mentre i camici bianchi delle multinazionali americane e degli istituti statali sovietici si affannano - patetici alchimisti senza la sapienza segreta dell'alchimia - alla ricerca della "pastiglia", della "iniezione" miracolosa che distruggano il tumore, c'è un cancerologo d'oggi che si spinge a riconoscere: «Non sapremo mai quanti mali anche fisici ha evitato all'uomo il cristianesimo, esortando all'amore, alla preghiera, al perdono dei peccati, alla pace con se stessi e con gli altri. È comunque un fatto che la curva del cancro e dell'infarto cresce sempre più proprio nei Paesi dove diminuisce sino a scomparire la curva della visione religiosa della vita». Un caso? Chissà. Sappiamo però che, nel suo istinto profondo, ogni lingua ha sempre usato lo stesso termine - corruzione - per indicare gli effetti sia del peccato che della morte: la "corruzione" morale porta alla "corruzione" della carne, alla morte. Sia chiaro: per la fede non è la morte in quanto fatto biologico ad essere legata al peccato. È sicuro che, nell'insondabile piano di Dio, anche senza la "caduta di Adamo" ci sarebbe stato per l'uomo un qualche decesso, un passaggio a qualche forma di vita diversa e superiore. Il peccato non porta, dunque, la morte come serena, naturale fine biologica di un ciclo, come trasformazione. Il peccato porta la morte come tragedia, come rottura dolorosa, come esperienza di perdita e di angoscia. Il peccato imprime cioè al morire il ghigno che gli conosciamo: da fatto naturale lo trasforma in pena, lo lega alla solitudine, perché la colpa rompe la comunione con Dio e, attraverso lui, con tutte le creature.
La morte - questa morte - non si addice dunque all'uomo, non rientra nel piano originario della Creazione. È la più grande delle catastrofi nel senso etimologico: è cioè "capovolgimento", "rovesciamento". Per questo la Chiesa reagisce contro tutti coloro che, pur dicendosi credenti, banalizzano il morire, ne fanno un falso problema. La Chiesa condanna sia il materialismo che riduce quel dramma a cosa ovvia, naturale, sia certo spiritualismo sedicente cristiano, secondo il quale la morte non sarebbe che un facile, sereno passaggio da una vita "inferiore" a un'altra "superiore". Come semplicemente si trattasse di aprire una porta, liberandosi con sollievo del fardello del corpo. Una simile visione non è cristiana perché non è biblica. Per la fede, la fine dell'attività fisiologica del corpo non è affatto come voleva farci credere Platone sulle orme di Socrate - la gioiosa liberazione dell'anima dalla prigione della carne: soma-sema, il corpo è tomba, diceva il gioco di parole dell'antico greco. Non è neppure una disgrazia che tocchi una sola parte di noi, quella fisica. È invece la fine dell'uomo, che soltanto attraverso quella "carne" - così stoltamente disprezzata dagli spiritualismi di ogni risma ma non dalla Bibbia - può vivere con se stesso e con gli altri. Così che per Paolo il corpo non è "tomba" ma, semmai, "tempio" (1Cor. 6,19). Soltanto l'onnipotenza divina, la forza misteriosa e irresistibile che promana dalla risurrezione del Cristo possono rimediare a quel disastro radicale. Banalizzare la morte significherebbe banalizzare anche la risurrezione promessa. La quale non è solo coronamento delle attese ma anche clamoroso rovesciamento; non è l'ovvio, il normale, ma piuttosto un colpo di scena dell'imprevedibile fantasia divina.
Così che, davanti alla morte mia e dei miei cari, il «non esitare con incredulità», il «rafforzarsi anzi nella fede», il «convincersi pienamente che quanto egli ha promesso sia anche capace di portarlo a compimento» , il credere, cioè, nella finale, generale risurrezione della carne; tutto questo non è (sottolinea con forza san Paolo da cui traiamo le espressioni) un facile abbandono, un agevole fidarsi. Ma è piuttosto l'incredibile spes contra spem, lo «sperare contro ogni speranza» (Rom. 4,18 e 20 s.) (Idem, 316-322).
N.B. Si raccomanda la consultazione del testo integrale (con le note critiche).
Le immagini presenti in questa pagina non fanno parte del testo originale.
Sito della Società Editrice Internazionale