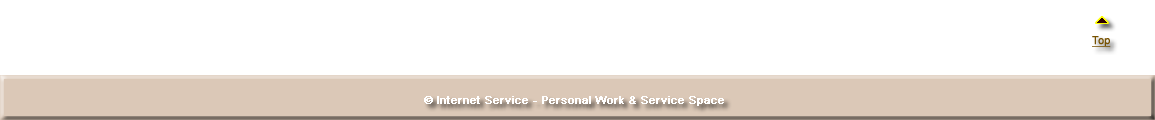Mai, eravamo andati a portare e a difendere la pace cosí lontano.
Nemmeno quando si era trattato di spedire i nostri militari a salvar vite in posti come il Congo, la Somalia, il Mozambico o il Ruanda.
Nemmeno all'epoca di due delle tante missioni semi-dimenticate delle Forze Armate italiane.
La prima, condotta nel 1979 da una squadra navale rischierata a 6.500 miglia dalle basi di partenza, si era conclusa con il salvataggio di quasi mille boat people vietnamiti abbandonati alla deriva nel Mar della Cina Meridionale.
Giusto l'anno seguente sarebbe toccato alla nostra Aeronautica Militare realizzare, stavolta sotto le insegne della Croce Rossa Internazionale, un memorabile ponte aereo umanitario tra Bangkok e Phnom Penh nel pieno della spaventosa guerra civile che stava insanguinando la Cambogia. Per la verità, un nome famoso nella storia militare patria era stato prossimo a toccare con un secolo abbondante di anticipo gli scenari che fanno da sfondo alla vicenda di questo libro. Ma il personaggio in questione si era arrestato qualche stazione prima, là dove l'estremità settentrionale dell'isola di Sumatra s'infila come il muso di un immenso drago marino tra gli stretti di Malacca e delle Mentawai. È qui, sotto i palmizi dell'antico sultanato di Aceh, una muraglia di vulcani e di giungla tropicale che fa praticamente da porta al labirinto sterminato dell'Arcipelago della Sonda, che Gerolamo Bixio, detto Nino, morí stroncato dal colera nel dicembre del 1873.

Monsignor Carlos Felipe Ximenes Belo - Arcivescovo di Dili
Premio Nobel per la pace 1996
Atlante alla mano, dunque, la sola idea di spedire truppe e mezzi aeronavali all'altro capo del mondo (con l'inevitabile corollario di problemi organizzativi, logistici e di comunicazione con la madrepatria che ciò avrebbe comportato) era di quelle da far tremare i polsi. Tuttavia, la distanza senza precedenti - quasi 16.000 chilometri - non costituiva certo l'unica incognita con cui misurarsi. Una volta compiuto il grande balzo, il nostro corpo di spedizione si sarebbe trovato immerso in un contesto operativo e ambientale straordinariamente complesso. Tanto per cominciare, il nuovo impegno nasceva e si sarebbe snodato al di fuori del tradizionale sistema di Alleanze (un coinvolgimento diretto della NATO era stato escluso in partenza dopo che il recente summit per il cinquantennale dei Patti di Washington aveva ribadito l'indisponibilità dell'Alleanza Atlantica a vestire i panni di gendarme mondiale.
Di conseguenza, il fatto stesso di doversi integrare in una coalizione di nazioni assolutamente inedita (problema per altro comune a ciascuno dei nostri partner) spostava ancora piú in su la soglia fatidica del one team, one mission, al di là della quale inizia il successo di qualunque missione a carattere multinazionale. Quanto al tempo a disposizione per poter raccogliere ed elaborare le informazioni essenziali circa la effettiva situazione del "teatro", meglio sorvolare. L'unico elemento sui cui non si potevano nutrire dubbi di sorta, al riguardo, era rappresentato dalle condizioni climatiche e igienico-sanitarie: 35-40 gradi di temperatura media e un tasso di umidità del 90 per cento anche nella stagione secca, il tutto guarnito dal piú completo campionario di malattie tropicali disponibile nell'area asiatico-pacifica. A cominciare dalla micidiale "encefalite giapponese".
L'ultima volta in cui dei militari europei avevano operato in un ambiente naturale altrettanto ostile era stata durante la Seconda Guerra Mondiale. Infine, bisognava fare i conti con un ultimo scoglio, sotto alcuni aspetti il piú alto di tutti. Ci trovavamo, infatti, nella fase di massimo impegno del nostro strumento militare a partire dalla nascita della Repubblica. Un dato certificato indirettamente dallo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, che nella sua ultima visita in Italia aveva tenuto a sottolineare come il nostro Paese occupasse ormai saldamente il terzo posto al mondo per numero di militari impegnati in operazioni internazionali di pace. Sommando fra loro i reparti di Esercito, Marina e Aeronautica, avevamo qualcosa come oltre 10.000 uomini (in realtà il triplo, considerando gli indispensabili avvicendamenti) sparsi un po' ovunque sulle frontiere piú calde del Pianeta. E poi, c'era appena stato il Kosovo. Dove, a giudizio degli osservatori piú autorevoli e neutrali, avevamo fornito alla campagna aerea contro la Serbia di Slobodan Milosevic un contributo di rango pari a quello degli Stati Uniti. E dove oltre 5.000 italiani in divisa di Esercito, Carabinieri e Aeronautica, per non parlare degli equipaggi delle unità navali in servizio permanente sul fronte degli approvvigionamenti logistici e della sorveglianza dell'Adriatico, continuavano a difendere giorno e notte le ragioni della convivenza pacifica e della riconciliazione interetnica in un settore cruciale ai fini della rinascita dell'intera regione balcanica.
Perché decidere di andare, allora? Non eravamo forse già sufficientemente "esposti" sul proscenio internazionale? Non si rischiava di oltrepassare il grado massimo di impegno complessivamente sostenibile da parte delle nostre Forze Armate? Per quanto assolutamente fondati, simili interrogativi si intrecciavano, però, con un'altra domanda non meno difficile da eludere. Dopo il Kosovo, appunto, sarebbe stato moralmente e politicamente accettabile rimanersene alla finestra adesso che i massacri e le deportazioni non avvenivano piú a due o tre ore di volo da Roma? Volendo esaminare il problema da un'angolazione ancor piú ampia, poteva la bandiera della "Pax Europea", che proprio noi avevamo contribuito in modo determinante a rilanciare nel tormentato scacchiere balcanico, risultare completamente assente solo perché, stavolta, non erano in gioco né la sicurezza né gli interessi strategici del Vecchio Continente? Fortunatamente, questo è un Paese in cui certi artificiosi distinguo tra politica estera e politica di difesa, cosí come tra il sentire profondo dell'opinione pubblica e la funzione incarnata dalle nostre Forze Armate fuori e dentro i confini nazionali, non hanno piú la benché minima ragion d'essere da un pezzo. E quando si è questo genere di Paese, la discussione sul "se" sia opportuno rafforzare o meno la nostra presenza nella trincea della difesa dei diritti umani finisce, ben presto, per concentrarsi sul "come".
Del resto, anche altre capitali europee, come Parigi e Londra, stavano ponendosi problemi di coerenza analoghi ai nostri. Sotto l'incalzare degli avvenimenti prendeva cosí corpo l'ipotesi di un'autonoma disponibilità di alcune delle maggiori potenze continentali a sostenere una soluzione della nuova crisi imperniata sulla riaffermazione del ruolo dell'ONU quale principale garante della pace, della sicurezza e della legalità in campo internazionale. Subito opportunamente raccordata in sede di reciproche consultazioni (come è normale che avvenga fra alleati cosí stretti), tale disponibilità sarebbe risultata, di lí a poco, la chiave decisiva per consentire il varo di una forza multinazionale di pace da schierare oramai, una e indivisibile. Che la sovranità della dignità umana doveva avere la precedenza sulla sovranità degli Stati. Che le prime parole con cui si apre la Carta dell'ONU «Noi, il popolo delle Nazioni Unite...» non si riferivano solo ai fortunati abitanti di ben determinate aree geopolitiche della Terra. In ultima analisi, era dunque questa la sfida che Roma, Parigi e Londra si apprestavano a raccogliere insieme anche in nome e per conto dell'Europa. D'altra parte, la sequenza sempre piú agghiacciante di notizie e di immagini rilanciate dai principali media mondiali la diceva molto lunga circa i ritardi già accumulati dalla comunità internazionale in quell'Eden trasformato in un infernale campo di sterminio chiamato Timor Est.
GENESI DI UN MASSACRO
La tragedia di questa terra e del suo popolo, per l'85 per cento di religione cattolica, era iniziata all'alba del 7 dicembre 1975. Quel giorno, Radio Dili aveva lanciato al mondo il suo ultimo, disperato appello: «Ci uccideranno tutti. Ripetiamo, ci uccideranno tutti. Vi scongiuriamo, fate qualcosa per fermare l'invasione». Fino a quel momento la porzione orientale dell'isola era appartenuta al Portogallo, che aveva fatto di Timor un proprio possedimento coloniale a partire già dal XVI secolo. Quella occidentale, invece, era stata ceduta agli Olandesi nel 1618. Solo nel 1946 l'Olanda l'aveva ceduta alla Repubblica Indonesiana, che con i suoi 200 milioni di abitanti sparsi su 14.000 isole è il primo paese mussulmano del mondo.
Nel 1974 la storica vittoria della cosiddetta "rivoluzione dei garofani" non solo sancisce la fine del lunghissimo regime salazarista e il ristabilimento per via pacifica del sistema democratico in Portogallo, ma apre anche la strada dell'indipendenza alle ex colonie di Lisbona. E siamo già al dramma anticipato via etere dai microfoni di Radio Dili. Seguendo l'esempio di Angola e Mozambico, Timor Est dichiara, il 28 novembre 1975, la propria sovranità piena. Meno di dieci giorni piú tardi (a dimostrazione dell'esistenza di un piano messo a punto da tempo) le truppe indonesiane la invadono. Negli anni che seguiranno, la spietata repressione dei soldati di Giakarta, concentrata sui timoresi di fede cattolica, farà qualcosa come 200.000 vittime, un quinto esatto della popolazione originaria, scesa oggi a circa 800.000 abitanti. La resistenza armata contro gli occupanti è condotta dai guerriglieri del Falintil, braccio armato del Fretilin (Fronte rivoluzionario di Timor Est) guidato da José Alexandre Gusmao, detto Xanana. Catturato dagli indonesiani nel 1992 e condannato all'ergastolo, Xanana ottiene gli arresti domiciliari nel febbraio del 1999. Contemporaneamente, grazie alla mediazione di Stati Uniti e Portogallo, le autorità indonesiane accettano un referendum sull'autodeterminazione di Timor Est da celebrarsi sotto l'egida e la supervisione delle Nazioni Unite.
La consultazione si tiene il 30 agosto 1999 in un clima di sostanziale regolarità, reso possibile anche dall'accordo raggiunto fra le milizie indipendentiste e quelle filoindonesiane per la messa al bando delle armi durante la tornata elettorale. Appena mezz'ora dopo l'apertura dei seggi, circa il 50 per cento dei timoresi dell'Est ha già deposto la propria scheda nell'urna. Uno di essi ha un nome un po' lungo, ma che vale la pena di mandare a memoria per esteso, trattandosi di Monsignor Carlos Felipe Ximenes Belo, l'Arcivescovo di Dili, Premio Nobel per la Pace 1996 insieme a José Ramos-Horta, un altro protagonista dell'eroica lotta di questo piccolo grande popolo. Alla fine della giornata, Monsignor Belo sarà stato imitato da 430.000 suoi fratelli timoresi, il 98 per cento degli aventi diritto al voto. La sera del 3 settembre Kofi Annan in persona, preoccupato per i rapporti sui primi gravi incidenti provocati dalle milizie pro Giakarta, annuncia l'esito del referendum. Che è tale da non lasciare spazio alcuno alle interpretazioni. La percentuale di coloro che si sono espressi a favore dell'indipendenza tocca, infatti, il 78,5 per cento. Dopo secoli di dominazione coloniale, seguiti da cinque lustri di sanguinosa repressione, Timor Est è entrata nel novero delle Nazioni libere. Ma il suo martirio è tutt'altro che finito.
I responsabili dell'UNAMET (United Nations Mission in East Timor) non fanno in tempo a ufficializzare il risultato del voto che la violenza delle formazioni paramilitari filoindonesiane si scatena in tutta la sua bestiale ferocia, senza peraltro trovare nella Tni e nelle Kopassus (rispettivamente l'esercito regolare e le forze speciali di Giakarta) il benché minimo freno. Anzi... Sarà una nuova, mostruosa ondata di massacri che non risparmierà nessuno, a cominciare da sacerdoti, suore e personale delle organizzazioni umanitarie. E che, nel volgere di pochissimi giorni, farà centinaia e centinaia di morti e oltre 250.000 sfollati, questi ultimi in buona parte profughi o deportati nella zona occidentale e, lí, ridotti di fatto allo stato di ostaggi da esibire beffardamente in faccia al mondo attonito.
CORSA CONTRO IL TEMPO
Di fronte a un tale scempio, ogni ora lasciata scorrere inutilmente significava la perdita sicura di altre vite umane destinate a venire immolate sotto i colpi dei machete e nei roghi delle capanne e delle chiese prese d'assalto dalle bande ubriache di droga e sangue, padrone ormai assolute del campo. Non solo. Accettare che la violenza del piú forte sovvertisse l'esito di una libera consultazione democratica promossa e avallata esplicitamente dalla comunità internazionale avrebbe finito per infliggere un colpo durissimo alla credibilità delle stesse Nazioni Unite, messa già a dura prova dalla tremenda vicenda del Kosovo.

Pattuglimento fra le rovine di Dili
II 7 settembre, sotto la spinta della pressione internazionale, il governo indonesiano proclama lo "stato di emergenza" in tutta l'isola. Nelle stesse ore l'ONU minaccia per la prima volta, attraverso un vero e proprio ultimatum, l'intervento di una forza internazionale composta da 5-7000 uomini. Nonostante ciò, l'escalation della violenza appare sempre piú inarrestabile. A muovere gli squadroni della morte è, indubbiamente, un impasto perverso in cui l'odio fondamentalista contro la maggioranza cattolica dei Timoresi si mescola con la sete di vendetta innescata dall'esito del plebiscito. E, tuttavia, aumentano di ora in ora gli indizi che fanno pensare a uno stretto collegamento fra le stragi e l'oscura lotta per il potere che si sta giocando contemporaneamente a Giakarta. Qui, l'unico collante in grado di puntellare l'establishment politico-militare al potere appare l'interesse comune delle varie fazioni in campo a scongiurare, agitando lo spettro del terrore, il diffondersi del virus indipendentista in qualche altro angolo del "gigante" indonesiano. In questo clima, l'azione combinata delle forze di sicurezza indonesiane e delle milizie Aitarak continua a evocare con impressionante analogia un altro infamante "gioco di squadra" andato in scena, assai recentemente, alle porte di casa nostra. Perfino il ricorso sistematico al sequestro e alla distruzione dei registri parrocchiali delle nascite e dei battesimi rivela un identico disegno volto a cancellare alla radice la memoria e l'identità di un intero popolo.
La speranza di una soluzione interna della crisi diversa dall'olocausto dei Timoresi che si sono pronunciati per l'indipendenza cade definitivamente allorché le agenzie di tutto il mondo battono la notizia dell'eccidio di un centinaio di persone consumato a Suai, 100 chilometri a sudovest di Dili. Le vittime, per la maggior parte donne e bambini, sono state sorprese tra i banchi della chiesa parrocchiale dove avevano trovato rifugio e qui falciate a colpi di mitra e di granate. La stessa fine riservata anche al gesuita Tarcisius Dewanto, a padre Francisco Tavares dos Reis e a padre Hilario Madeira, i tre sacerdoti che fino all'ultimo avevano tentato di opporsi al massacro. E il bollettino dell'orrore continua ad allungarsi. A Baucau, secondo centro di Timor Est, sei religiose canossiane, tutte timoresi, vengono assassinate a sangue freddo. Anche il vescovo locale, Monsignor Basilio do Nascimento, rimane ferito da un colpo di machete. L'uccisione del direttore della Caritas di Timor Est Francisco Barreto e di una quarantina di suoi collaboratori coincide con l'inizio dell'evacuazione di tutto il personale della missione UNAMET. Anche il Vaticano, per bocca del proprio "ministro degli esteri", Monsignor Jean Louis Tauran, si pronuncia ufficialmente perché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adotti al piú presto una risoluzione in favore della creazione di una forza internazionale di pace.
La presa di posizione della Santa Sede suona come una diretta risposta all'appello lanciato per primo da Monsignor Belo. Questi, scampato per miracolo all'incendio della propria abitazione, è riuscito a mettersi in salvo a Darwin, in Australia, da dove è subito ripartito alla volta dell'Europa deciso a tornare «con qualsiasi forza di pace». Dopo la prima tappa in Portogallo, il Vescovo di Dili giunge il 13 settembre in Italia. II primo ad accoglierlo, nella residenza estiva di Castel Gandolfo, è un Giovanni Paolo II visibilmente ansioso di abbracciare il suo indomito presule.
Ventiquattr'ore piú tardi, Monsignor Belo sale al Quirinale per essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Successivamente, incontrerà il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema e il Ministro degli Esteri Lamberto Dini. In tutti i colloqui, il Premio Nobel insiste su di un unico punto («occorre far presto») fatto proprio sia dal Presidente Ciampi che dal premier D'Alema, il quale ha già dichiarato che «il Governo italiano considera intollerabile quanto sta avvenendo a Timor Est», aggiungendo che «la comunità internazionale non può assistere impotente ai massacri e che è mia personale convinzione che le Nazioni Unite debbano esaminare seriamente la possibilità di un intervento». Dichiarazione subito ripresa dall'allora titolare del dicastero della Difesa, il Senatore Carlo Scognamiglio, con una precisazione che sa di annuncio: «Concorreremo con la comunità internazionale alle decisioni che verranno prese in ambito ONU, anche se l'interesse che la sicurezza del nostro Paese aveva e ha in altri scenari come i Balcani è ovviamente maggiore. Ma questo significa solo che non ci verrà domandato di compiere il massimo sforzo chiesto e ottenuto in quei casi». È la conferma che, pur non essendo ancora maturi i tempi di un'autonoma capacità d'intervento dell'Europa in una situazione di grave crisi internazionale, l'Italia si sta muovendo nella direzione di un coinvolgimento diretto proprio e di alcuni singoli Paesi dell'Unione nella missione a Timor Est.
Sulla base delle decisioni prese congiuntamente da Kofi Annan e dal Primo Ministro australiano John Howard, sentito anche il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, l'operazione dovrà scattare non appena possibile e sarà affidata alla guida di un generale di Canberra (la scelta piú naturale essendo l'Australia la potenza regionale di riferimento nell'area asiatico-pacifica, nonché il Paese piú direttamente interessato alla stabilità e alla sicurezza della regione). Questi è stato già individuato nella figura del Generale Peter Cosgrove, un veterano della guerra del Viet Nam decorato con la Croce Militare, una delle massime onorificenze australiane, per il coraggio dimostrato sul campo. II 15 settembre 1999, dopo che il Presidente indonesiano pro-tempore Habibie aveva dichiarato solennemente di accettare l'invio di truppe ONU a Timor Est, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva all'unanimità la risoluzione n. 1264. II testo della risoluzione autorizza il dispiegamento di una forza multinazionale a Timor Est sotto egida ONU denominata INTERFET (International Force in East Timor) con il mandato di ristabilire condizioni di pace e di sicurezza per tutta la popolazione, proteggere e supportare la missione degli osservatori dell'UNAMET e agevolare le operazioni delle diverse organizzazioni umanitarie operanti sul territorio. La risoluzione fa esplicito riferimento al capitolo VII della Carta dell'ONU. Ciò significa che i militari della operazione Stabilise potranno adottare ogni misura ritenuta idonea - ivi compreso il ricorso all'uso della forza - per attuare l'insieme dei compiti loro assegnati. Precisazione quanto mai opportuna, considerato ciò che li attende.
Timor Est brucia. Anche la sede di UNAMET, appena abbandonata dagli ultimi funzionari dell'ONU, è stata data alle fiamme e saccheggiata. Le strade sono piene di Aitarak armati fino ai denti che si stanno preparando allo sbarco imminente dell'invasore straniero al grido di «Berremo il sangue dei bianchi». No, non si tratterà di una passeggiata. «Se non fossimo stati consapevoli della serietà dei rischi a cui nostri uomini andranno incontro, avremmo deciso di mandare i boy-scout e non dei soldati», commenta il Ministro Scognamiglio a decisioni ormai prese. Che, per quanto concerne l'Italia, vengono formalizzate dal nostro governo lo stesso giorno dell'approvazione al Palazzo di Vetro della risoluzione n. 1264.

Il Comandante di INTERFET, Generale Peter Cosgrove,
saluta il Generale degli Alpini Giorgio Cornacchione
Intanto, lo Stato Maggiore della Difesa italiano ha già completato la pianificazione del nostro contributo alla missione. L'Italia parteciperà con un gruppo tattico di 250 paracadutisti della Brigata Folgore comprendente alcuni distaccamenti del 9º Reggimento d'Assalto Col Moschin e un'aliquota di circa 50 Carabinieri del Reggimento Tuscania. Un'altra pedina fondamentale sarà rappresentata dal San Giusto, una delle navi da trasporto e sbarco LPD (Landing Platform Dock) della nostra Marina Militare. L'unità anfibia (sulla quale saranno impegnati circa 300 uomini fra equipaggio, Fucilieri di Marina del Reggimento San Marco e incursori subacquei del Comsubin) trasporterà i mezzi pesanti della componente terrestre e assicurerà il supporto logistico e operativo in zona di operazioni, grazie anche ai quattro elicotteri (tre SH-3D Sea Stallion e un AB-412) imbarcati a bordo.
Inoltre, il moderno reparto ospedaliero (comprendente anche una sala chirurgica) di cui è dotata la nave resterà attivo per l'intera durata della missione. La componente aeronautica, anch'essa determinante in un'area di rischieramento cosí remota, sarà imperniata su un nucleo di due G-222 della 46a Brigata Aerea di Pisa con il relativo personale di volo e quello addetto all'assistenza tecnica. Nell'insieme, circa 600 uomini, rappresentativi di ciascuna Forza Armata. Un contingente di non grandi dimensioni, ma pur sempre bene equipaggiato e sostanzialmente pari al contributo fornito da nazioni come Francia e Gran Bretagna che con noi formano il nocciolo duro della partecipazione europea, senza la quale ben difficilmente l'Indonesia avrebbe accettato la forza di pace. Soprattutto, gente con una lunga esperienza alle spalle in fatto di impegni all'estero. Un dato che accomunava, indifferentemente, paracadutisti (molti dei quali erano stati allertati per la nuova destinazione pochi giorni prima di ripartire per la Bosnia), avieri, marinai, carabinieri e ufficiali medici. La missione piú lontana, adesso, era là che aspettava ognuno di loro.
MISSIONE COMPIUTA
IL SALUTO
L'ultimo ammainabandiera dei soldati italiani a Timor Est avviene lunedí 14 febbraio [2000]. Per la cerimonia - ma l'emozione che si respira nell'aria è talmente forte da rendere l'espressione decisamente inadeguata - è stato scelto un luogo pieno di significati simbolici: il piazzale antistante alla Cattedrale di Dili. Le immense navate bianche del tempio fanno da sfondo agli uomini perfettamente allineati del gruppo tattico Folgore, i quali sono stati "accompagnati" al punto dello schieramento da un Ufficiale australiano. Un onore che ci si scambia solo fra militari che hanno imparato la difficile arte di amare e rispettare la bandiera altrui come la propria. II primo a prendere la parola è il Generale Cornacchione. Probabilmente a causa dei 14 chili persi nel corso della missione, questo Generale degli Alpini che si è trovato proiettato dall'oggi al domani nel bel mezzo di uno scenario da romanzo salgariano sembra piú allampanato del solito. L'intonazione della voce, però, è quella sicura e sincera di sempre.
«Per la maggior parte di voi, questa non è stata la prima operazione condotta al di fuori dei confini nazionali. Però lasciate che io vi dica un convinto "bravi" per questi cinque mesi di duro lavoro svolto con impegno, serietà e professionalità elevatissima. E per avere dimostrato a un popolo vittima di sofferenze enormi che non tutte le uniformi militari sono sporche di sangue». Quindi, tocca a Cosgrove. Già durante uno degli ultimi briefing si era lasciato andare a una confessione a dir poco irrituale: «Se dovessi comandare nuovamente un contingente multinazionale, per primi vorrei gli italiani». Adesso, sceglie le parole una a una, quasi a voler dimostrare di non essersi fatto prendere la mano nel pronunciare quel giudizio. «Giorno dopo giorno, sono stato sollevato e ispirato nel constatare sia il coraggio spontaneo e la disciplina di ferro che avete opposto a coloro che vi volevano male, sia la compassione e la generosità che avete messo al servizio dei meno fortunati. In questo Paese devastato avete faticato e lavorato sempre in pericolo, ma sempre preoccupandovi di proteggere e di rassicurare il popolo. Ognuno di voi ha contribuito in modo vitale a tutto ciò che abbiamo compiuto a Timor Est. Ora, la missione di INTERFET è compiuta. Sono estremamente fiero di voi. È con onore che ritornate dai vostri cari».
Monsignor Belo, presente anch'esso e non certo per ragioni di pura cortesia, non prende la parola in considerazione del carattere particolare della manifestazione. Piú tardi, però, il padre spirituale di Timor Est dichiarerà alle agenzie che la partenza dei nostri militari «costituisce una grave perdita per il mio Paese».Non resta molto da aggiungere alla cronaca da Timor Est di questo 14 di febbraio dell'anno 2000. Se non ricordare che la stessa data segna anche il passaggio ufficiale del testimone al contingente portoghese della missione UNTAET che prenderà in consegna l'area di responsabilità controllata, finora, dagli italiani. E per fissare nella memoria il fotogramma del commiato tra due mondi che tornano a separarsi. C'è tutta Dili sul molo, a salutare per l'ultima volta i nostri parà.

Nave San Giusto per compiere la missione a Timor Est ha navigato per
quasi 26.000 miglia, una volta e mezzo il giro del mondo
Nave San Giusto si è avvicinata di nuovo alla costa e ora si dondola pigramente sull'oceano mantenendosi alla solita distanza di sicurezza di circa due chilometri, la bocca spalancata del bacino di poppa che sembra voler dire «andiamo». Tra le onde sono riapparse pure le tozze sagome dei men che vengono a prelevare mezzi e uomini, i quali se ne stanno accovacciati in ordine lungo la spiaggia, gli zaini appoggiati al proprio fianco. Quando la prima lancia butta giú la rampa sulla battigia, un parà lí vicino si inginocchia nella sabbia e rimane assorto per qualche secondo con il volto rivolto verso la striscia di palme che abbraccia il porto. Poi si rialza, e senza piú voltarsi, sale a bordo insieme ai suoi compagni. Tutti si lasciano dietro un record praticamente irripetibile: una missione intera "tirata via" dall'inizio alla fine con lo stesso gruppo tattico e senza mai un rimpiazzo. E una lapide di marmo nero piantata nel giardino di quella che, per tutto questo tempo, ha fatto loro da casa e da caserma insieme. Prima di andarsene, però, questi soldati hanno dato vita ancora una volta a un'azione assai poco militaresca. Quintali di panini e di farina preparati e sbarcati dal San Giusto e consegnati nelle mani delle impareggiabili "suorine" di Dili. Sono proprio queste ultime, canossiane e salesiane mischiate attorno a suor Jolanda, a tributare l'estremo "presentatarm" ai nostri.
Con le chitarre al posto dei fucili da combattimento, e i grani dei rosari a far da bandoliera. L'ultimo a imbarcarsi è il Tenente Colonnello Mazza. «Ragazzi, si torna a Livorno tutti salvi. Sani... è da vedere!», esclama saltando a bordo e suscitando l'ilarità generale degli uomini che lo hanno preceduto sul men. Le risate si smorzano rapidamente in un silenzio che solo gli accordi delle chitarre delle religiose riescono, in qualche modo, a tamponare. Una di loro, suor Carla, si avvicina al barcone che sembra non voler piú lasciare l'arenile. Si porta due dita alla bocca, le appoggia sulla fiancata del mezzo da sbarco e si fa il segno della croce. II Tenente Colonnello Mazza la raggiunge e la bacia sulle guance dicendole: «Questo bacio è per tutte voi». Quindi, arretra di qualche passo. E rivolgendosi al pilota della lancia, con un groppo alla gola che gli strozza la voce, fa: «Vai, maledizione. Vai».
Cfr. AGNETTI PINO, Pace senza confini. La missione delle Forze Armate Italiane a Timor Est, Novara 2000, 10-24; 90-92.

«Pace senza confini. La missione delle Forze Armate Italiane a Timor Est»
La storia della missione INTERFET italiana è edita a cura di:
Stato Maggiore della Difesa - Istituto Geografico De Agostini - Iniziative speciali
Legittima difesa e legge marziale