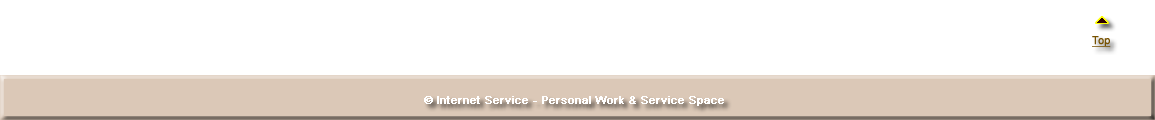L'Annuario Statistico della Chiesa 2003 constata che nel 1978 i sacerdoti religiosi erano 158.000, mentre nel 2003 erano diminuiti fino a raggiungere le 137.000 unità.
I religiosi professi non sacerdoti nel 1978 erano oltre 75.000, ridotti poi a poco piú di 54.000 nel 2003.
Le religiose professe, che erano poco meno di un milione nel 1978, nel 2003 non superavano le 770.000 unità.
Secondo alcuni autori sono scomparsi il 76% degli Ordini o congregazioni fondati prima del 1500, il 64% di quelli fondati prima del 1800 e il 39% di quelli fondati verso la metà del secolo XX.
E tuttavia la vita religiosa continua ad andare avanti.
Nonostante questi dati molti hanno affermato che c'è bisogno piú che mai della vita religiosa e per questo essa merita "una critica affettuosa e da dentro".
1. I pericoli di una visione ideologica: dal francescanesimo al "francescanismo".
Timeo hominem unius libri diceva san Tommaso d'Aquino, ma potremmo dire anche Timeo lectorem unius libri. L'interpretazione di questo detto, come si sa, è duplice, tuttavia la prenderemo nella sua accezione negativa. Interpretare la realtà basandosi su una visione unilaterale o ideologica del mondo è pericoloso. È per questo che dalle ideologie non scaturisce mai una visione armonica e integrale delle cose ma solo parziale e opprimente, quando non addirittura fatale.
Possiamo chiederci se anche il francescanesimo possa incorrere nello stesso rischio, ossia degenerare in una visione unilaterale della realtà. La risposta è purtroppo affermativa. Anch'esso è esposto a questo pericolo e la sua storia ce lo documenta ampiamente. Basti pensare, per esempio, al movimento ereticale dei "fraticelli" e alla sua visione assolutizzata della povertà minoritica (DS 910-916). Giustamente l'autentica teologia francescana considerò la carità e non la povertà come la principale delle virtú: «Si sola charitas respicit finem ultimum immediate, aliae virtutes non erunt ad finem ultimum nisi mediante charitate, sine qua non possunt sic ordinari» (DUNS SCOTUS, Ox. III, d. 36, q. 26); cosí quando nell'Ordine minoritico Ubertino da Casale († 1329) tentò di spostare l'essenza della perfezione dalla carità alla povertà, provocò una violenta reazione che portò alla sua condanna (cfr. BALCALONI L., La carità caposaldo della spiritualità francescana e cristiana, in Studi Francescani 27 (1930) 1-30).
La grandezza profetica di Francesco d'Assisi sta nella scelta radicale di un amore evangelico, universale e senza riserve: questa è la ragione della perennità della sua testimonianza che tuttavia va sempre contemplata nel contesto del patrimonio multiforme della Chiesa la quale attinge ogni bene dalla ricchezza inesauribile di Cristo. Francesco ha saputo percorrere il cammino indicatogli da Cristo e lo ha fatto da uomo del suo tempo: egli, ben presente agli uomini della sua epoca, seppe camminare in mezzo al mondo, beneficando tutti (cfr. At 10,38), senza smarrire la via. Era davvero nel mondo ma non del mondo (Gv 17,14). Non per questo egli era esente dai limiti di un uomo che ha incarnato il Vangelo e le sue esigenze in un contesto sociale ed ecclesiale che è quello del Duecento; un uomo, per la sua epoca, di ampio respiro e larghe vedute ma pur sempre legato ai condizionamenti culturali del tempo. Chi ignora la sua figura o ne ha una conoscenza superficiale a stento lo riconoscerebbe nella severità con cui correggeva alcuni frati, soprattutto se eretici o detrattori. Cosí egli scrive nel suo Testamento:
«E se si trovassero dei frati che non recitano l'ufficio secondo la Regola o volessero comunque variarlo, o non fossero cattolici, tutti i frati, ovunque sono, siano tenuti per obbedienza, appena trovato uno di essi, a consegnarlo al custode piú vicino al luogo dove l'avranno trovato. E il custode sia tenuto fermamente per obbedienza, a custodirlo severamente come un uomo in prigione, giorno e notte, cosí che non possa essergli tolto di mano, finché personalmente lo consegni nelle mani del suo ministro. E il ministro sia tenuto fermamente per obbedienza a farlo scortare per mezzo di frati che lo custodiscano giorno e notte come un prigioniero, finché non lo consegnino al cardinale di Ostia che è signore, protettore e correttore di tutta la fraternità» (Test 31-33: FF 126).
La cultura laicista odierna con la sua artificiosa e pluralistica tolleranza condannerebbe Francesco e, se lo conoscesse davvero, sarebbe ben lungi dal servirsene spesso come portabandiera di un buonismo politically correct.
Nella Vita seconda di Tommaso da Celano scritta tra il 1246 e il 1247 cosí viene descritta la reazione di Francesco di fronte ai detrattori:
«Un giorno udí un frate che denigrava il buon nome di un altro, e rivoltosi al suo vicario frate Pietro di Cattanio, proferí queste terribili parole: "Incombono gravi pericoli all'Ordine, se non si rimedia ai detrattori. Ben presto il soavissimo odore di molti si cambierà in puzzo disgustoso, se non si chiudono le bocche di questi fetidi. Coraggio, muoviti, esamina diligentemente e, se troverai innocente un frate che sia stato accusato, punisci l'accusatore con un severo ed esemplare castigo! Consegnalo nelle mani del pugile di Firenze, se tu personalmente non sei in grado di punirlo!" (chiamava pugile fr. Giovanni di Firenze, uomo di alta statura e dotato di grande forza)» (2Cel 182: FF 769).
Questi appena citati, a causa del loro rigore, sono testi accuratamente evitati dai moderni e popolari sponsor mediatici del francescanesimo - inclusi quelli religiosi - ma l'uomo Francesco d'Assisi è anche questo: ama e difende la verità e la giustizia senza esitazioni e compromessi perfino nella liturgia, anche in quanto primaria forma di comunione e catechesi.
In questo ricorso alla coercizione e alla forza, oggi meno comprensibile che in passato, si evidenzia un tratto tipico della mentalità dell'epoca a cui neppure egli sfuggiva del tutto. Lungi dal fargliene una colpa, diremo che si tratta di quegli inevitabili condizionamenti che influiscono sulla lettura e sull'interpretazione dello stesso messaggio evangelico. Cosí, rifiutando i cliché mediatici e i luoghi comuni sulla sua figura, possiamo, anzi dobbiamo chiederci: quali sono i limiti degli strumenti culturali grazie ai quali oggi possiamo accostarci ad esso e offrirne un'interpretazione e un'attualizzazione? Possiamo ampliarne gli orizzonti? Non certo nel senso di un'esegesi piú accomodante, ma piú profonda, piú autentica, piú esigente, piú equilibrata e, proprio per questo, piú realistica e rispondente al nostro tempo.
Certamente Francesco non poteva e non può dirci tutto su Cristo e sul suo Vangelo, né ha mai avuto tale presunzione. Fra i peggiori torti che gli potremmo fare v'è quello di trasformare la sua testimonianza in una sorta di dogmatica weltangschaung, cioè di una serie di postulati ideologici socio-religiosi nei quali rischiamo di cadere piú di quanto non si pensi. Alcune riflessioni antiche e moderne sulla povertà e sulla minorità fanno pensare proprio a una simile tentazione. Se in passato il pericolo maggiore è consistito nella pretesa di ingabbiare il suo carisma concretizzandolo attraverso lo strumento giuridico-canonico, oggi il pericolo sta nell'eccesso opposto, ossia nel dissolverlo in una sorta di irresoluta filosofia di vita. Ecco perché è opportuno ricordare le parole di Francesco: «Io ho fatto il mio dovere; quanto spetta a voi, ve lo insegni Cristo!» (2Cel 214: FF 804); come pure: «La lettera uccide, lo spirito invece vivifica» (2Cor 3,6), espressione a lui cara (cfr. per es. Adm 7,1: FF 156). È Cristo la chiave di volta della sua e della nostra vita, è lui l'ispiratore di Francesco e solo lui può rinnovare in noi lo spirito e il carisma, non certo come arida e statica replicazione della sua figura ma come icona di Cristo viva e vivificante nel e del nostro tempo.
La riscoperta del carisma del fondatore non è una sorta di operazione di "archeologia spirituale", ma nuova e originale interpretazione della medesima e genuina radice: Dio non si ripete, ma crea sempre cose nuove. Questa è la ragione per cui non possiamo rifugiarci nel passato ma neppure in una illusoria fuga in avanti alla ricerca sterile e superficiale di novità fini a se stesse: occorre avere il patrimonio del passato e il coraggio del presente per porre delle solide basi al futuro. Quel coraggio e quella ricchezza che la Chiesa auspica anche nell'attuazione del rinnovamento conciliare tutt'altro che compiuto. La Chiesa, in questi pochi decenni che la separano dal Vaticano II, ha rinnovato molte delle sue strutture ma è ancora distante dall'aver raggiunto quella primavera dello Spirito tanto auspicata da Giovanni XXIII grazie alla quale essa sarà piú che mai come "città collocata sopra un monte" (Mt 5,14). Quella primavera verrà appunto nella misura in cui avremo il coraggio della fedeltà e della profezia: la fedeltà al deposito integrale della fede e il coraggio della testimonianza, cioè dell'attualizzazione piena del Vangelo.
Quello dell'attualizzazione, dell'inculturazione e dell'inserimento effettivo (perfino dal punto di vista locale) in seno alla comunità ecclesiale è, e sarà sempre, un tema difficile e scottante perché attualizzare significa operare e rischiare puntando tutto su Cristo, nell'oggi e fino in fondo. Non esiste fedeltà autentica senza attualizzazione. La realtà presente ci interpella e pone delle domande sulla nostra identità, sul nostro ruolo ecclesiale e sociale. Le riflessioni al riguardo sono innumerevoli e non mancano certamente nomi qualificati che in questo campo hanno offerto contributi preziosi e irrinunciabili. Perché allora porsi continuamente questa domanda? Perché non accontentarsi di attingere semplicemente alla messe copiosa di contributi e di studi valutando le opere esistenti? Sostanzialmente per due ragioni:
- la prima è che questa riflessione deve essere fatta anche a livello personale. È la persona concreta, con le sue doti e con i suoi limiti, che deve incarnare l'ideale evangelico e questo è un lavoro che ciascuno deve fare alla luce della Tradizione e della Parola di Dio;
- la seconda è che la nostra è un'epoca di rapidi cambiamenti in grado di riproporre continuamente le problematiche connesse all'attualizzazione. Ci sono problematiche esistenziali che hanno il loro peso e che devono continuamente essere valutate e ricomprese a fondo.
Questo è l'obiettivo della presente modesta riflessione, di questo infatti propriamente si tratta. È possibile trovare dei punti fermi? È possibile trovare una via? Il mondo odierno, incluso quello ecclesiale, si getta spesso a capofitto in un'attività analitica, in un'introspezione cosí sottile e profonda da essere talvolta perfino fuorviante. Interrogarsi cosí, soprattutto sui valori fondamentali, comporta il rischio di perdere l'orientamento. È una crisi seria quella del nostro tempo, talvolta aggravata dal peso che la cristallizzazione istituzionale porta con sé. Un ulteriore segno di questa crisi è la perdita di considerazione autentica per la persona e per le sue necessità spirituali piú profonde. Il movimento spesso cerca persone e carismi, l'istituzione corre invece il rischio di limitarsi a cercare numeri e capacità di adattamento alle sue esigenze strutturali.
Nel dettato Della vera e perfetta letizia Francesco si immagina forestiero e pellegrino presso un convento e, giunto presso la portineria, un frate gli chiede: "Chi sei"? lui risponde: "Frate Francesco". E quello dice: "Vattene, non è ora decente questa di arrivare, non entrerai". E mentre lui insiste, l'altro risponde: "Vattene, tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te» (cfr. VpLaet 9-11: FF 278). Questa è la risposta di un'istituzione che confida in se stessa, nel suo prestigio e nella sua grandezza, e rischia di disprezzare i doni di Dio: noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. Non è forse questo un atteggiamento radicalmente opposto a quello divino? Noi non abbiamo bisogno... Dio invece "vuole aver bisogno"... "si fa povero" ma per dispiegare tutta la potenza del suo amore e della sua misericordia (cfr. 2Cor 8,9). Nel disegno di Dio nessuna persona - mai - è di troppo. Non cosí invece, spesso, per le istituzioni. Talvolta si ha quasi l'impressione che le singole congregazioni religiose cerchino di appropriarsi di quella invincibilità ed inerranza che lo Spirito di Dio ha garantito solo alla Chiesa nella sua totalità. Ma lo Spirito soffia quando e dove vuole... e quando un'istituzione non ha piú motivo di essere in seno alla Chiesa vede concludersi inevitabilmente il suo ciclo vitale. Nell'ottica evangelica le vocazioni non sono semplici pezzi di ricambio nel meccanismo istituzionale ma persone chiamate a "rifondare carismaticamente" la vita religiosa: se non potranno farlo all'interno di un'istituzione, con la benedizione di Dio lo faranno altrove.

Paolo III approva l'opera dei Cappuccini presentati dalla Povertà Sebastiano Ricci - 1687-1688 (olio su tela)
2. Povertà evangelica: elementi di crisi e premesse per un'attualizzazione
Fra i consigli evangelici quello della povertà è forse il piú arduo da realizzare in un'ottica radicale come quella francescana. Non a caso è sulla povertà che la lunga e tormentata storia del primevo Ordine si giocherà fra alterne vicende portando alla nascita di riforme e movimenti sempre nuovi. La povertà rientra nel mistero della sofferenza, sempre inattesa ma misteriosamente feconda. «Un uomo non educato dal dolore rimane sempre bambino» affermava Niccolò Tommaseo, cosí un uomo vissuto fra gli agi spesso diventa insensibile, incapace di comprendere il dolore umano e perciò di aprirsi all'amore autentico. La povertà, come la sofferenza, può muovere il cuore umano alla confidenza in Dio dal quale in ultima analisi tutto spera.
Ma non è certo la povertà in sé che rende migliore il cuore umano, e meno che mai la miseria, che dal Vangelo non viene certo proposta ma condannata, in quanto frutto dell'ingiustizia umana: non darmi né ricchezza, né povertà, ma dammi soltanto ciò che mi è necessario per vivere, recita l'autore del Libro dei Proverbi (cfr. Pv 30,8). Se l'opzione fondamentale della persona non sarà retta, neppure dolore e povertà renderanno migliore il suo cuore. Molto piú di quella materiale, infatti, è la povertà di spirito a fare la differenza. È l'umiltà a rendere piú umana la persona e ad aprirla al trascendente. Occorre dunque migrare sempre dalla ricerca della povertà formale, strada spesso percorsa in passato, alla ricerca della povertà di spirito grazie alla quale tutti i beni vengono finalizzati alle esigenze del regno dei cieli.
Una delle chiavi di lettura che forse meglio possono aiutarci ad attualizzare la povertà evangelica è quella della povertà come disponibilità all'altro.
Occorre farsi poveri per arricchirsi di Dio amministrando i beni di questo mondo in modo prudente. Non è forse questa l'esortazione di Cristo? «Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché, quand'essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?» (Lc 16,9-12). L'uso dei beni di questo mondo tuttavia deve sempre tenere presente il monito circa il fatto che «nessun servo può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona» (Lc 16,13).
Prima di chiedersi se si possano avere o no dei beni forse ci si deve chiedere il perché ed il come li si possiede. Ci sono infatti dei possessi (e dei conseguenti usi) giustificabili e comprensibili e altri non comprensibili e non giustificabili. Ci sono motivazioni credibili e altre non credibili. La povertà, sia individuale che comunitaria, per essere autentica ed evangelica deve essere improntata anzitutto a questa credibilità di fondo, solo cosí sarà tale da non avere bisogno di interpretazioni. Non possedere "niente" è cosa impossibile all'atto pratico, a meno di ricorrere ad ambigue forme di fictio iuris, mentre è possibile, anzi necessario, possedere dei beni in misura ragionevole e adeguata alle necessità della propria vocazione e missione.
La scelta francescana delle origini realizzava il valore della povertà religiosa tramite il rifiuto del denaro, il rifiuto della proprietà dei beni e il lavoro come mezzo di sostentamento e di aiuto ai poveri. L'elemosina era ammessa solo in caso di manifesta necessità, specie per le necessità dei malati (RegNB VII, 1-7: FF 24). Ci si può domandare se questo modo di concretizzare la povertà sia ancora credibile. In gran parte lo è senz'altro, in parte deve essere ripensato avendo riguardo alla mentalità e alla cultura dell'uomo d'oggi, aspetto che in seguito verrà ulteriormente approfondito.
Altro elemento essenziale della scelta francescana e la scelta preferenziale per i poveri. Essa tuttavia non può essere ridotta a scelta ideologica e deve essere vissuta all'interno della dimensione ecclesiale. Infatti, "l'opzione preferenziale per i poveri, lungi dall'essere un segno di particolarismo o di settarismo, manifesta l'universalità della natura e della missione della Chiesa. Questa opzione non è esclusiva. È la ragione per cui la Chiesa non può esprimersi a sostegno di categorie sociologiche e ideologiche riduttrici, che farebbero di tale preferenza una scelta faziosa e di natura conflittuale" (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istruzione Libertatis conscientiae del 22 marzo 1986, n. 67).
Prima di proseguire oltre però è opportuno porsi anche una domanda concreta: chi sono i poveri? Quali poveri dobbiamo porre dinanzi alla nostra attenzione? Sono forse solo gli 'anawîm? Oppure deve essere oggetto della nostra attenzione chiunque soffra di una qualche indigenza materiale e/o spirituale e per qualsiasi motivo? Certamente la carità ci impone di non restringere la nostra attenzione ai poveri virtuosi, essa, infatti, non ama le esclusioni; semmai occorre evitare quei falsi poveri che approfittando della sensibilità e ingenuità altrui, fanno della mendicità una sorta di professione e - ciò che è oltremodo grave - privano di credibilità e di aiuto coloro che poveri lo sono per davvero. I primi biografi di Francesco riportano una severa sentenza di Francesco di Assisi circa l'abuso in materia di elemosine: «Frequentemente Francesco diceva queste parole ai suoi fratelli: "Non sono mai stato ladro di elemosine, nel chiedere o nell’usarne oltre il bisogno. Presi sempre meno di quanto mi occorreva, affinché gli altri poveri non fossero privati della loro parte; ché fare il contrario, sarebbe rubare"» (cfr. 2Spe 12: FF 1695). Nessuno, fatto salvo lo stato di reale e urgente necessità, ha il diritto di vivere a spese altrui rifuggendo alla comune legge del lavoro.
Nella realtà spesso non è facile discernere i veri poveri da quelli falsi tanto piú che per avvicinare i poveri e gli ultimi occorre anche essere accettati e in qualche modo riconosciuti come tali. Essere solidali, infatti, implica anche avvicinarsi al prossimo condividendo la sua condizione. Ma è davvero possibile essere riconosciuti come poveri dai poveri se non lo si è in radice? Pur apprezzando tutto il valore ideale di questo enunciato occorre dire che esso è in parte utopico. L'appartenenza ad un'istituzione ecclesiale, infatti, per quanto povera, rende molto difficile la sua realizzazione piena. Senza dubbio è possibile coltivarne l'intenzione e la tensione ma quanto all'attuazione pratica essa è possibile solo nella misura in cui si perde - almeno sociologicamente - quello status che l'appartenenza alla stessa struttura ecclesiale di fatto conferisce. È pur vero tuttavia che lo status sociale non costituisce una barriera assolutamente insormontabile, almeno non nella misura in cui il modo di essere della persona è capace di trascenderlo. In altri termini l'appartenere ai poveri è realizzabile piú che da un punto di vista sociologico da un punto di vista spirituale, considerazione questa che deve mettere in guardia da facili soluzioni demagogiche.
3. Povertà evangelica: alcune linee di discernimento
Occorre interrogarsi anche sul problema del rapporto fra la povertà e l'evangelizzazione. Risponde senza dubbio a verità che la povertà vissuta per il regno dei cieli, ossia fondata esplicitamente sull'amore per Cristo, ha un valore profetico ed è una via al Vangelo. L'evangelizzazione non dipende, infatti, della ricchezza dei mezzi ma scaturisce anzitutto dall'essere ricolmi dello Spirito di Dio. Come discernere dunque l'autentica evangelizzazione in rapporto alla povertà?
A questo proposito si possono rilevare alcuni punti fermi:
a) l'evangelizzazione in un'ottica di proselitismo e di ricerca di consenso non è autentica;
b) l'evangelizzatore che si pone come fine non è autentico;
c) l'evangelizzazione che confida nella disponibilità di mezzi, di potere e di privilegi non è autentica;
d) l'evangelizzazione deve rispondere alla realtà dell'uomo e deve al tempo stesso aiutarlo a discernere i suoi bisogni reali;
e) l'anima genuina dell'evangelizzazione risiede solo nella carità teologale;
f) l'evangelizzazione deve rispondere alla realtà ecclesiale e inserirsi nell'alveo della comunione e dell'obbedienza gerarchica.
Lo spirito di povertà implica anche alcuni criteri metodologici necessari che sono:
- l'uso equilibrato e ragionevole dei beni, proporzionato ai fini legittimi da conseguire;
- l'evitare le scelte demagogiche e semplicistiche, spesso di facciata;
- l'evitare la confusione fra "massima economicità" e "povertà" che non sempre coincidono.
Tutto questo non deve mai far dimenticare la realtà delle cose: il fatto stesso che si discuta sulla povertà e la si "scelga" è segno evidente di una sostanziale disponibilità di beni e di un qualche potere. L'umiltà, che è retta conoscenza di sé, ci impone di riconoscere la nostra situazione effettiva che può essere piú o meno agiata. Solo partendo da questa constatazione sincera sarà possibile gettare il primo gradino per cominciare a diventare "umilmente e interiormente poveri". L'essere "ricchi" e incapaci della povertà di Cristo per l'uomo di Dio costituisce fonte di umiliazione e deve muovere ad aiutare prontamente coloro che poveri lo sono realmente e spesso ineluttabilmente e disperatamente.
Occorre riconoscere che la kenosi di Cristo sarà sempre al di là delle nostre forze, benché possa e debba essere realmente e sempre oggetto di sequela e tensione spirituale. Non riconoscere questo significa rischiare di cadere nell'orgoglio spirituale. La forma piú efficace di redenzione per la nostra ricchezza è forse quella della condivisione: condividere fin dove è possibile e opportuno la condizione altrui e - ancor piú - condividere i nostri beni spirituali e materiali. In verità quanti beni condividiamo effettivamente con i poveri? Siamo in grado di darci una percentuale realistica e credibile? Alla fine, infatti, è questo che i poveri di oggi attendono con ansia, insieme al dono della fraternità e alla liberazione dalla solitudine, vera lebbra della moderna società del benessere.
Proseguendo nella riflessione dobbiamo chiederci anche qual è la discriminante tra un uso equilibrato e ragionevole dei beni, anche per le esigenze personali, e un uso disordinato. In altre parole, si potrebbe dire: come riconoscere il giusto rapporto fra la promozione della persona, l'evangelizzazione, il servizio, la formazione professionale e lo spirito di povertà? Una risposta ragionevole la si può trovare in un rapporto equilibrato fra l'edificazione della persona è l'edificazione vera della fraternità e del corpo ecclesiale. Questi due aspetti non sono certo in concorrenza fra loro, a patto che la promozione della persona si collochi nella stessa linea della promozione della fraternità e del corpo ecclesiale, dunque proceda nella linea dell'autentica carità.
La povertà richiama anche la realtà del lavoro. L'importanza del lavoro personale, e la sua valenza pedagogica circa il retto uso dei beni, meritano piú che mai di essere sottolineate. È importante interrogarsi sul valore che il lavoro assume nella vita quotidiana. Non è forse vero che il lavoro, anche nella vita religiosa, diventa non di rado una sorta di valvola di sicurezza? Non è forse vero che esso diventa anche una ragione di vita? La verità è che la vita cosí come si svolge in diversi contesti religiosi non è piú realistica, né proponibile alla maggior parte delle persone. Non sarà per questa ragione che a dispetto degli sforzi delle leadership generali e locali si constata l'evasione, a diverso titolo, dalla vita comune? A parte le ragioni "sociali" e quelle "economiche" non di rado non vi sono ragioni umane piú profonde per risiedere costantemente in una casa religiosa, sicché essa tende ad essere ridotta a puro luogo di appoggio. Il lavoro all'esterno della comunità non dovrebbe diventare né una via di fuga, né un'occasione diretta o indiretta per la ricerca del potere ecclesiale, politico o economico. Anche in questo caso occorre spirito di discernimento affinché l'umiltà o minorità garantisca la salvaguardia dell'autentico spirito religioso e della testimonianza evangelica. Tale discernimento tuttavia, per quanto prudente, non può concludersi semplicemente in una opzione deresponsabilizzante per l'individuo.
Oltre allo stile di vita comune anche l'itineranza e le esigenze pastorali/apostoliche in alcuni casi contribuiscono a rendere superficiale la vita di relazione del consacrato e a distaccarlo affettivamente dalle persone e dal proprio istituto. Se è vero che il lavoro, anche quello apostolico, può diventare motivo di privilegio o di inamovibilità, con tutte le conseguenze negative del caso, è pur vero che nemmeno una continua itineranza giova alla vita spirituale della persona e al ministero pastorale. Dopo una certa esaltazione della vita itinerante forse occorre una riflessione diversa, equilibrata e attenta su una ragionevole stabilità (stabilitas) finalizzata a garantire una maggiore regolarità della vita spirituale.
Il lavoro domestico è essenziale in una vita di reciproco servizio fraterno e occorre recuperarlo a patto che esso si estenda senza discriminazioni ma neppure demagogie a tutta la fraternità. Una fraternità davvero povera non dovrebbe avere personale esterno al suo servizio, essa stessa semmai si deve qualificare ad intra e ad extra come fraternità di servizio. Il lavoro domestico non condiviso può compromettere gravemente lo spirito di fraternità e di uguaglianza.
In ultima analisi si può dire che anzitutto «essere povero indica non la privazione nei confronti dei mezzi necessari per l'esistenza o per la soddisfazione dei bisogni sensibili, ma un tipo di relazione con gli altri uomini: la mediazione del denaro come potenza e seduzione non vi ha parte. Gesú è libero nei confronti del denaro, ma non è un predicatore di vita 'semplice', campestre. Denuncia la non-trasparenza delle relazioni tra gli uomini a causa del desiderio di potenza di cui il denaro è il simbolo astratto. Gesú afferma maggiormente la sua libertà in questa situazione umana, che nell'inumanità della miseria. Egli non è un esempio né di rassegnazione né di meschinità. Le condizioni di vita di Gesú, secondo i vangeli, non paiono dunque contrastanti con quelle della maggior parte degli uomini della sua epoca» (cfr. DUQUOC CHR., Cristologia. Saggio teologico. L'uomo Gesú. Il Messia, (Biblioteca di teologia contemporanea 15), Brescia 19712, 127).
C'è un altro aspetto della povertà intesa anche come libertà. Nel cristiano - e tanto meno nel consacrato - non può albergare il disprezzo per le cose create, per i beni di questo mondo, semmai il disprezzo per la schiavitú che può scaturire dal loro abuso:
«"Ma io so bene che tu mi obietterai: «Perché dunque egli ha creato il vino, se intendeva proibire di berlo"?. Ma egli non proibí di berlo, solo di ubriacarsene; del resto ha creato la donna per il matrimonio, proibendo l'impudicizia; ha creato il ferro per usarlo nei lavori agricoli, proibendo di adoperarlo per uccidere. In tal modo ha creato il vino per la nostra debolezza, proibendone l'uso smodato. Egli non biasima il bere, ma punisce l'ebbrezza. Anzi, il vino è addirittura necessario per chi è ammalato, per chi è triste e anche per il grande sacramento, proprio come sta detto: Il vino è per il triste, è la gioia di coloro che sono in afflizione (Pr 31,6). Per sovvenire ai bisogni vitali bastano pane, acqua e vesti; tutto il resto è voluttuario e non necessario. Alcuni vi sono incatenati per l'abitudine o per libera scelta, altri, con la volontà e l'abitudine, se ne sono liberati. Non lasciamoci dunque ridurre in schiavitú, per l'abitudine, dal pessimo, diabolico vizio del bere. No! Con ferma volontà teniamoci lontani dall'eccesso nel mangiare e dalla smoderatezza nel bere, per poter osservare sempre i suoi comandamenti; manteniamo l'ordine nei nostri costumi, conduciamo una vita virtuosa, diamoci al santo amore, osserviamo con fedeltà il digiuno, attendiamo alla preghiera, compiamo opere di misericordia e sforziamoci di essere modesti, di farci santi e salvare la nostra anima» (cfr. GIOVANNI MANDAKUNI ARMENO, Il vizio del bere, 8-10).

4. Approfondimento sulla povertà individuale
Riguardo al tema della povertà individuale si deve considerare come esso venga spesso evitato o affidato ad ambigue e multiformi prassi che talvolta mettono alla prova le coscienze dei singoli. Ci si potrebbe domandare se nella situazione odierna, specie nel contesto occidentale, sia il caso di riconsiderare entro determinati limiti quella rinuncia alla proprietà e alla gestione individuale dei beni che il voto di povertà comporta. Sarebbe possibile pensare all'introduzione di una responsabilità individuale che si integri armonicamente in quella comunitaria, evitata con cura ogni impostazione egoistica e speculativa? Nella situazione attuale il religioso perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza, dal punto di vista canonico, pone invalidamente ogni atto contrario al voto. È proprio questa radicale incapacità che nel contesto attuale, da un punto di vista psicologico e forse anche sociologico, non sembra piú del tutto opportuna. È accettabile, infatti, che la vita consacrata conduca ad una sorta di "interdizione" ecclesiale e civile? Alla luce del Vangelo era forse tale la povertà della comunità apostolica? Non pare proprio. La scelta della povertà è realmente e strettamente legata ad una dipendenza totale, soprattutto economica? Questo modo di concretizzare il consiglio evangelico della povertà non porta nei fatti l'autorità alla prevaricazione della persona e non di rado la persona a svincolarsi arbitrariamente da essa? In parte, infatti, questo è ciò che è dato di vedere. Non è forse possibile vivere la povertà religiosa anche all'interno di un ragionevole spazio di autonomia? La vita consacrata non risente ancora eccessivamente di una visione prettamente giuridica? È immaginabile vincolare a degli obblighi giuridici il gesto che Cristo propose al giovane ricco? O il coraggioso gesto di spoliazione di Francesco (Tre Comp. VI, 20: FF 1419) dinanzi al Vescovo di Assisi? La vita consacrata ha indubbiamente anche una dimensione giuridica ma essa non deve mai diventare preponderante e se ciò dovesse verificarsi è segno che è venuta a mancare gravemente o del tutto la dimensione spirituale. Guai se la lettera finisce con l'uccidere lo spirito (cfr. 2Cor 3,6). Il diritto è come la struttura portante di un corpo, ne costituisce l'ossatura, ma guai se l'ossatura diventa visibile, perché ciò accade solo in un corpo malsano o morto. Sono provocazioni queste alle quali occorre rispondere nella complessità della vita quotidiana.
In una diversa e ipotetica visione del consiglio evangelico della povertà si potrebbe optare non piú per la "rinuncia ad ogni forma di possesso" bensí per il possesso e la gestione "del necessario e dell'opportuno" nello spirito del Vangelo, all'interno di un disegno ecclesiale, comunitario e fraterno. In tal modo il consacrato se da un lato cesserebbe di essere "economicamente e strettamente dipendente" dalla persona del superiore e dalla comunità, che all'atto pratico spesso finiscono con il porre delle ipoteche alla sua libera auto-donazione, dall'altro verrebbe posto nelle condizioni di acquisire una responsabilità maggiore agendo con maggior dignità e libertà in seno alla Chiesa e al mondo. E la libertà non può essere considerata un pericolo. In alcuni dei suoi versi piú belli Péguy fa dire a Dio: «Tutte le prosternazioni e le sottomissioni del mondo non valgono il bell'inginocchiarsi diritto di un uomo libero» e aggiungiamo... libero a tutti gli effetti. Una tesi del genere tuttavia comporterebbe un ripensamento radicale nel modo di concepire e concretizzare il voto di povertà, si rende necessaria perciò una riflessione piú approfondita sulla base di alcuni testi fondamentali per la comprensione della materia.
Nell'episodio del giovane ricco (Mt 19,16-22) Gesú evidenzia la libertà di cui l'apostolo ha bisogno per testimoniare l'avvento del Regno. Egli ha bisogno di collaboratori liberi e del tutto disponibili e ad essi domanda di rinunziare radicalmente alle sollecitudini poste dalla famiglia (Mt 10,37) e dalle ricchezze. Si tratta certamente di una rinuncia vera e completa ma nel Vangelo non appare il rigorismo di principio che invece è dato di vedere in molte forme di vita religiosa. La comunità apostolica ha sí una sorta di "cassa" comune (Gv 12,6; 13,29), ma nel Vangelo non si parla di un esproprio meticoloso dei beni e finanche degli effetti personali, come accade lungo la storia della vita religiosa, dove talvolta la povertà è stata salvaguardata formalmente in modo rigoroso ma non di rado "a spese dei benefattori". Questo è il motivo per cui nella Regola Francesco d'Assisi vietò ai frati di ricevere denaro sia direttamente sia per interposta persona (RegB IV,2; RegNB VIII, 2-3 dove viene citata una norma del Codice Giustinianeo (C 9, 11, 1, 2). L'unica eccezione che egli ammetteva era data dalla necessità di curare i malati.
È interessante soffermarsi brevemente sulla questione dell'appartenenza della "cassa" comune del Collegio apostolico. È su tale questione che si incentra la tematica della povertà ecclesiale e quindi anche della povertà francescana. I beni economici che costituivano la "cassa" del Collegio Apostolico appartenevano a Dio (possesso cultuale) e appartenevano amministrativamente al Collegio Apostolico (persona morale collegiale) di cui Cristo era a capo. Come i beni di questo primo depositum pietatis appartenevano amministrativamente a tale Collegio, cosí i beni attuali della Chiesa appartengono amministrativamente alla Chiesa. In Mt 22,21 viene posta una linea di demarcazione fra le cose che il diritto naturale assegna al possesso degli uomini e le cose che il diritto religioso assegna al possesso cultuale di Dio (per la questione vedasi l'approfondimento di BONI A., Povertà ecclesiale e povertà francescana oggi, (Collectio Assisiensis 30), S. Maria degli Angeli - Assisi 2002, 37-39).
La complessa questione della povertà nell'Ordine minoritico è stata sempre dibattuta e ancora oggi è ben lungi dall'essere chiarita (cfr. BONI A., Povertà ecclesiale e povertà francescana oggi, (Collectio Assisiensis 30), S. Maria degli Angeli - Assisi 2002, 9). Se da un lato Francesco la ebbe sempre a cuore e riuscí ad osservarla con una fedeltà a tutta prova, dall'altra la prima leadership dell'Ordine premeva per una normativa piú flessibile, piú rispondente alle necessità apostoliche e piú allineata a quella degli istituti monastici dell'epoca. Interessante è la visione che scaturisce dalla Leggenda Perugina circa il modo in cui Francesco intendeva la povertà e la strenua ma vana lotta che condusse per difenderne la radicalità. Si tratta di due testi che forse sintetizzano bene la questione e che contribuiscono a far luce sulle tensioni che caratterizzeranno la storia francescana e la situazione odierna, come vedremo in seguito:
«Quando [Francesco] fu rientrato dai paesi d'oltremare, un ministro prese a discutere con lui sul capitolo della povertà, volendo conoscere il suo pensiero e la sua volontà sull'argomento. Nella Regola di allora stava scritto un capitolo circa le proibizioni del santo Vangelo, ad esempio quella che dice: Non porterete nulla nel vostro cammino ecc. Gli rispose Francesco: «Il mio pensiero è che i frati non dovrebbero avere che la tonaca e la corda e le brache, come prescrive la Regola, e le calzature per quelli che sono stretti da necessità». Replicò il ministro: «Cosa farò io, che ho tanti libri, del valore di oltre cinquanta lire?». Disse questo perché li voleva conservare con tranquilla coscienza, anche perché fino a quel giorno aveva patito rimorso nel tenere tanti libri con sé, sapendo che Francesco interpretava cosí strettamente il capitolo sulla povertà. E Francesco: «Fratello, non posso e non devo andare contro la mia coscienza e contro l'osservanza del santo Vangelo da noi professata». A queste parole il ministro si avvilí. Il Santo, vedendolo abbattuto, gli disse con ardore di spirito, intendendo nella persona di lui rivolgersi a tutti i frati: «Voi, frati minori, ci tenete che la gente vi consideri e chiami osservatori del Vangelo, ma in realtà volete conservare la vostre ricchezze!». I ministri, pur sapendo che secondo la Regola erano obbligati a osservare il Vangelo, fecero togliere da essa quel capitolo dove si legge: Non porterete nulla nel vostro cammino (Lc 9,3); illudendosi di non esser tenuti a osservare la perfezione evangelica. Francesco conoscendo questa soppressione in virtú dello Spirito Santo disse in presenza di alcuni frati: «Credono i frati ministri d'ingannare Dio e me. Ebbene, affinché tutti i frati sappiano e conoscano di essere obbligati a osservare la perfezione del santo Vangelo, voglio che al principio e alla fine della Regola sia scritto che i frati sono tenuti a osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesú Cristo. E affinché siano inescusabili dinanzi a Dio, voglio con l'aiuto del Signore osservare sempre e realizzare nel mio comportamento l'ideale che Dio mi ha rivelato per la salvezza dell'anima mia e per il bene dei fratelli». E davvero egli osservò il Vangelo alla lettera, dal tempo che cominciò ad avere dei fratelli fino al giorno della sua morte» (Leg. Per. 69: FF 1621-1622).
Ecco il testo della stessa Leggenda Perugina circa la lotta di Francesco per la povertà minoritica:
«[Rispose] Francesco: "Il Signore ti perdoni, fratello, questo tuo volermi essere oppositore e avversario, e di coinvolgermi in questioni che non mi riguardano piú". Proseguí: "Fin tanto che ebbi la responsabilità dei frati e i frati rimasero fedeli alla loro vocazione e professione, per quanto io abbia sempre avuto scarsa salute sin dalla mia conversione a Cristo, riuscivo senza fatica a soddisfarli con l'esempio e le esortazioni. Ma quando mi accorsi che il Signore moltiplicava ogni giorno il numero dei frati, e che essi per tiepidezza e languore di spirito cominciavano a deviare dalla strada dritta e sicura che finallora avevano seguito, e a incamminarsi per la via comoda, come hai detto tu, non badando al loro ideale, all'impegno preso, al buon esempio; quando dunque mi resi conto che non lasciavano il cammino sbagliato malgrado le mie esortazioni ed esempi, rimisi l'Ordine nelle mani del Signore e dei frati ministri. Rinunziai al mio incarico e diedi le dimissioni, adducendo davanti al Capitolo generale il motivo della mia malattia che mi impediva di seguire la fraternità in maniera adeguata. Tuttavia anche ora, se i frati avessero camminato e camminassero secondo la mia volontà, non vorrei, per loro conforto, che avessero altro ministro che me, sino alla mia morte. Infatti, quando il suddito è fedele e fervoroso nel conoscere ed eseguire la volontà del suo prelato, questi è in grado di soddisfare all'incarico con poca fatica. Di piú, proverei molta gioia nel vedere i fratelli cosí ferventi, e sarei tanto consolato nel mirare il mio e loro frutto spirituale che, sia pur giacendo a letto infermo, non mi sarebbe arduo guidarli". E soggiunse: "Il mio incarico di governo dei frati è di natura spirituale, perché devo avere dominio sui vizi e correggerli. Ma se non riesco a farlo con le esortazioni e l'esempio, non posso certo trasformarmi in carnefice per battere e scudisciare i colpevoli, come fanno i governanti di questo mondo. Quelli che sgarrano ho fiducia nel Signore che saranno puniti dai nemici invisibili, che sono i suoi "castaldi" incaricati di castigare in questo secolo e nel futuro i trasgressori dei comandi di Dio. Essi saranno puniti dagli uomini di questo mondo, a loro vituperio e vergogna, cosí che tornino a vivere l'ideale che hanno abbracciato. Comunque, fino al giorno della mia morte, con l'esempio, non smetterò d'insegnare ai fratelli che camminino per la via indicatami dal Signore e che ho mostrato loro, l'ideale a cui li ho formati, in modo che siano inescusabili dinanzi al Signore, e che non mi tocchi rendere conto al Signore di loro e di me"». (Leg. Per. 76: FF 1630).
Questi brani riportano alla memoria la deriva spirituale e disciplinare dell'Ordine primevo, l'allontanamento dal carisma del fondatore e l'intricata questione dell'obbligatorietà della Regola Francescana (per un approfondimento vedasi per es. A. BONI, L'obbedienza ecclesiale di S. Francesco al Papa e ai vescovi, in Anton. 57 (1982), 113-155). Per quanto possano essere interessanti i testi delle Fonti Francescane tuttavia non possono essere di sicuro aiuto nella comprensione della problematica della povertà. Il punto di riferimento, infatti, non è la povertà di Francesco ma la povertà di Cristo e degli apostoli. La povertà di Francesco si inserisce in quella di Cristo e degli apostoli e trova il proprio fondamento nel depositum fidei custodito e tramandato dai Padri della Chiesa. "Se cosí non fosse, il pensiero di S. Francesco sulla povertà in genere e sulla povertà di Cristo e degli Apostoli in specie, non sarebbe molto interessante. Il problema della povertà di Cristo e degli Apostoli, prima di essere un problema dell'Ordine dei Frati Minori è un problema della Chiesa di Cristo (povertà ecclesiale). In S. Francesco e nel suo Ordine non ci può essere niente di nuovo che prima non sia nella Chiesa" (cfr. BONI A., Povertà ecclesiale e povertà francescana oggi, (Collectio Assisiensis 30), S. Maria degli Angeli - Assisi 2002, 12). In tal senso Francesco non ha voluto altro che far propria la povertà di Cristo vivendola in seno alla Chiesa. La questione della povertà francescana purtroppo degenerò sempre piú a motivo del fatto che alla base delle controversie vennero posti i concetti del diritto romano (dominium e proprietas), quasi che la "povertà di Cristo e degli Apostoli" potesse soggiacere alle conclusioni dottrinali del diritto romano. Tale fu il limite delle stesse decretali pontificie che tentarono di dirimere la questione (Exiit qui seminat di Nicolò III del 14 agosto 1279 e Exivi de paradiso di Clemente V del 6 maggio 1312, poi recepite nel Corpus Iuris Canonici: c. 3,5,12; c. 1, 5, 11) (circa le conseguenze di tale impostazione e la dottrina di papa Giovanni XXII cfr. LAMBERT M. D., Povertà francescana, Milano 1995, 217; 238). La pericolosa commistione fra il diritto romano e le istanze teologiche su accennate venne denunciata, purtroppo senza successo, dal francescano Ruggero Bacone (+1294) che scrivendo al Papa Clemente V (1265-1268) non esitò ad affermare che il diritto canonico non si doveva richiamare tanto al diritto romano quanto alla Sacra Scrittura e alla dottrina dei Padri della Chiesa e pertanto si tratta di uno ius sacrum, concetto ribadito esplicitamente dal recente magistero pontificio ispirato dal Concilio Vaticano II (cfr. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione del 3 febbraio 1983, AAS 75 (1983), 461).
È un fatto che allo stato attuale in nessuno dei grandi Ordini francescani si emette la professione religiosa secondo la Regola bensí secundum Constitutiones Ordinis. In anni recenti l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini chiese alla Sede Apostolica la possibilità di tornare all'uso della formula tradizionale narbonense (voveo et promitto... secundum Regulam) ricevendo un responso negativo (cfr. AOFMCap. 98 (1982) 342-344). Alle origini di tale prudente diniego c'è l'opportunità di evitare appunto la riapertura dell'irrisolta questione dell'obbligatorietà della Regola, specie per quanto riguarda la questione della povertà, con tutte le problematiche di coscienza connesse. Quali possano essere i futuri sviluppi della questione è arduo poterlo anche solo immaginare.

Concilio Ecumenico Vaticano II
5. La povertà evangelica in alcuni documenti magisteriali
In materia di povertà bisognerà attendere il Concilio Vaticano II per vedere riportata la questione agli insegnamenti della Sacra Scrittura e alla dottrina dei Padri della Chiesa, sottraendola ad una visione giuridica pur necessaria ma insufficiente. Il Concilio ribadirà il fatto che la Chiesa non ha altro diritto di accedere ai beni economici se non la necessità di assicurare convenientemente il culto di Dio, di provvedere all'onesto sostentamento dei suoi ministri e di sostenere le opere di apostolato e di carità a favore dei poveri. Portando avanti la riflessione su questa strada dunque cercheremo di capire qual è il magistero della Chiesa circa il consiglio evangelico della povertà. Il primo testo di riferimento giuridico-teologico su cui è opportuno soffermarsi è quello conciliare della Perfectae caritatis. Il documento fra i "criteri pratici per l'adattamento", al nº 3 prescrive che "Il modo di vivere, di pregare e di agire deve convenientemente adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei membri, come pure, per quanto è richiesto dall'indole di ciascun istituto, alle necessità dell'apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze sociali ed economiche; e ciò dappertutto, ma specialmente nei luoghi di missione":
«La povertà volontaria scelta per la sequela di Cristo, di cui oggi specialmente essa è un segno molto apprezzato, sia coltivata diligentemente dai religiosi e, se sarà necessario, si trovino nuove forme per esprimerla. Per mezzo di essa si partecipa alla povertà di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi con la sua povertà (cf. 2Cor 8,9; Mt 8,20). Per quanto riguarda la povertà religiosa, non basta essere soggetti ai superiori nell'uso dei beni, ma occorre che i religiosi pratichino una povertà esterna e interna, ammassando tesori in cielo (cf. Mt 6,20). Nel loro ufficio si sentano impegnati nella comune legge del lavoro e, mentre in tal modo si procurano i mezzi necessari al loro sostentamento e alle loro opere, allontanino da sé ogni eccessiva preoccupazione e si affidino alla provvidenza del Padre celeste (cf. Mt 6,25). Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi. Gli istituti stessi, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare una testimonianza quasi collettiva della povertà, e volentieri destinino qualche parte dei loro beni per le altre necessità della Chiesa e per il sostentamento dei poveri, che i religiosi tutti devono amare nelle viscere di Cristo (cf. Mt 19,21; 25,34-46; Gc 2,15-16; 1Gv 3,17). Le province e le case degli istituti religiosi si scambino tra loro i beni temporali, in modo che le piú fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povertà. Quantunque gli istituti, in conformità alle regole e alle costituzioni, abbiano diritto di possedere tutto ciò che è necessario al loro sostentamento e alle loro opere, tuttavia evitino ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni» (PC 13).
Il Concilio auspica un'osservanza diligente nella povertà invitando anche alla ricerca di forme nuove nella sua concreta realizzazione. Il punto di riferimento per la povertà religiosa è anzitutto Cristo e il Concilio non elenca altre ragioni accanto ad essa (come per esempio ragioni caritative o sociologiche). Viene sottolineato il fatto che per essere poveri "non basta dipendere dai superiori nell'uso dei beni", ma occorre che i membri siano "poveri di fatto e di spirito". Viene ribadita indirettamente la "dipendenza" dai Superiori, quasi debba essere intesa come scontata, insieme ad una povertà vera, esteriore e interiore. I religiosi sono invitati a sostentarsi anzitutto con il lavoro e a porre la propria fiducia nella Provvidenza. Gli istituti possono permettere nelle loro costituzioni che i membri rinuncino ai beni patrimoniali. Si tratta di una concessione generica rivolta a tutti gli istituti; evidentemente è una possibilità che il Concilio accorda ai membri di quegli istituti dove con la professione non si perde il dominio dei beni. Il documento conciliare sottolinea l'importanza della testimonianza "in qualche modo collettiva" della povertà. Tale testimonianza, per esempio, si può concretizzare evitando ogni parvenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulo dei beni.
Nella Presbyterorum Ordinis non si tratta certo del consiglio evangelico della povertà in seno agli istituti di vita consacrata, tuttavia viene sottolineata l'importanza, anche per i presbiteri e i vescovi, del distacco dai beni materiali:
«Grazie ai rapporti di amicizia e di fraternità tra di loro e con gli altri uomini, i presbiteri sono in grado di imparare ad avere stima per i valori umani, e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio. Vivendo in mezzo al mondo devono però avere sempre presente che, come ha detto il Signore nostro maestro, essi non appartengono al mondo. Perciò, usando del mondo come se non ne usassero, possono giungere a quella libertà per la quale, liberati da ogni disordinata preoccupazione, sono resi docili all'ascolto della voce di Dio nella vita di tutti i giorni. Da questa libertà e docilità si sviluppa la discrezione spirituale che consente di mettersi nel giusto rapporto con il mondo e le realtà terrene. Tale rapporto è importante nel caso dei presbiteri, dato che la missione della Chiesa si svolge in mezzo al mondo, e i beni creati sono del tutto necessari per lo sviluppo personale dell'uomo. Siano perciò riconoscenti per tutte le cose che concede loro il Padre perché possano condurre una vita bene ordinata. È però indispensabile che sappiano esaminare attentamente alla luce della fede tutto ciò con cui hanno a che fare, in modo da sentirsi spinti a usare rettamente dei beni in conformità con la volontà di Dio, respingendo quanto possa nuocere alla loro missione. I sacerdoti infatti, dato che il Signore è la loro «parte ed eredità» (Nm 18,20), debbono usare dei beni temporali solo per quei fini ai quali tali beni possono essere destinati d'accordo con la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa. Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli, come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di esperti laici; devono sempre impiegarli per quegli scopi per il cui raggiungimento la Chiesa può possedere beni temporali, vale a dire: la sistemazione del culto divino; il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente per i poveri. Quanto ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i vescovi, salvi restando eventuali diritti particolari, devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente vogliano destinarlo per il bene della Chiesa e per le opere di carità. Non trattino dunque l'ufficio ecclesiastico come occasione di guadagno, né impieghino il reddito che ne derivi per aumentare le sostanze della propria famiglia. I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze, debbono evitare sempre ogni bramosia e astenersi accuratamente da qualsiasi tipo di commercio. Anzi, essi sono invitati ad abbracciare la povertà volontaria, con cui possono conformarsi a Cristo in un modo piú evidente ed essere un grado di svolgere con maggiore prontezza il sacro ministero. Cristo infatti da ricco è diventato per noi povero, affinché la sua povertà ci facesse ricchi. Gli apostoli, dal canto loro, hanno testimoniato con l'esempio personale che il dono di Dio, che è gratuito, va trasmesso gratuitamente, sapendo ugualmente avere grandi disponibilità che essere nell'indigenza. Ma anche un certo uso in comune delle cose - sul modello di quella comunità di beni che viene esaltata nella storia della chiesa primitiva - contribuisce in misura notevolissima a spianare la via alla carità pastorale; inoltre, con questo tenore di vita i presbiteri possono mettere lodevolmente in pratica lo spirito di povertà raccomandato da Cristo. Mossi perciò dallo Spirito del Signore, che unse il Salvatore e lo mandò ad evangelizzare i poveri, i presbiteri - come pure i vescovi - cerchino di evitare tutto ciò che possa in qualche modo indurre i poveri ad allontanarsi, e piú ancora degli altri discepoli del Signore eliminino dalle proprie cose ogni ombra di vanità. Sistemino la propria abitazione in modo tale che nessuno possa ritenerla inaccessibile, ne debba, anche se di condizione molto umile, aver timore di frequentarla» (PO 17).
Il Concilio invita i sacerdoti ad avere stima dei valori umani nel loro ministero e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio. Il documento intende fugare ogni possibile ombra di visione manichea circa le realtà create, anzi, si sottolinea che la missione della Chiesa si svolge in mezzo al mondo e che i beni creati sono "necessari allo sviluppo personale dell'uomo". È interessante constatare come in PC 13 sia del tutto assente ogni analoga considerazione. Forse che il Concilio intendeva porre un accento sulla necessità della "fuga mundi" da parte dei religiosi? Alla luce dei principi generali di rinnovamento espressi nella stessa Perfectae caritatis non pare si possa affermare questo, piuttosto nei documenti conciliari appare una suddivisione per cosí dire pedagogica. In realtà Perfectae caritatis e Presbyterorum Ordinis, in tale problematica, andrebbero in certo qual modo integrati l'uno con l'altro. Anche il religioso, pur avendo fatto una scelta di povertà, necessita dei beni creati per il suo sviluppo personale. Dove sta allora la differenza rispetto al presbitero? Giuridicamente parlando nel fatto che il religioso può usarne, senza averne il possesso, ma solo nella dipendenza da un Superiore e conformemente ad una ben definita regula vitae.
Il presbitero diocesano viene esortato ad usare rettamente dei beni in conformità alla volontà di Dio. Tertulliano affermava che i beni economici a disposizione della Chiesa costituiscono un depositum pietatis (cfr. Apologeticum adversus gentes, 39 (PL 1,533)). Tale depositum in possesso cultuale di Dio è finalizzato all'esercizio del suo culto, all'onesto sostentamento dei suoi ministri e alle opere di apostolato e di carità. È proprio in quest'ottica che i presbiteri devono usare dei beni temporali "solo per quei fini ai quali questi possono essere destinati secondo la dottrina di Cristo Signore e gli ordinamenti della Chiesa". Il presbitero ed il vescovo titolari di qualche ufficio ecclesiastico, fatti salvi eventuali diritti particolari, vengono esortati ad impiegare i beni per il "proprio onesto mantenimento" e per "l'assolvimento dei doveri del proprio stato". Ciò che avanza - esorta il Concilio - "lo destinino al bene della Chiesa e alle opere di carità". La Presbyterorum Ordinis rivolge l'invito esplicito ad abbracciare la povertà volontaria poiché è con essa che i presbiteri possono conformarsi a Cristo in un modo piú evidente e svolgere il loro ministero con maggiore prontezza. Anche in questo caso il riferimento cristologico è lo stesso della PC 13 (2Cor 8,9). Il Concilio ripropone "un certo uso comune delle cose", sul modello della primitiva comunità di Gerusalemme (At 4,32-35). Una cura particolare il presbitero la deve porre nell'evitare tutto ciò che possa in qualsiasi modo indurre i poveri ad allontanarsi, deve eliminare dal proprio costume di vita "ogni ombra di vanità" e anche nel sistemare la propria abitazione deve far sí che essa non venga ritenuta inaccessibile e che nessuno, anche se di condizione molto umile, "nell'accedervi si trovi a disagio". Spiritualmente parlando, ma anche molto concretamente, il presbitero diocesano può seguire da vicino la scelta di povertà tipica di un religioso. Si tratta però di una scelta libera, non soggetta certamente ad alcuna forma di prescrizione giuridica, quale quella che caratterizza i membri degli istituti di vita consacrata.
Il documento che segue è stato emanato dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. Si tratta di una lettera sugli atti del Capitolo generale speciale emessa in data 10 luglio 1972, dove al numero 2º si tratta del voto di povertà:
«La materia del voto di povertà e la sua pratica devono essere determinate dal capitolo in modo assai preciso. Tale spiegazione include vari fattori. Le religiose devono riconoscere l'importanza e la dignità del lavoro guadagnandosi da vivere. Il loro stile di vita, caratterizzato come si deve dalla semplicità, dovrà permettere una autentica condivisione fraterna. Povertà e vita comunitaria ne faranno intrinsecamente parte. In tale ambito sarà manifestato un senso corretto della dipendenza, non solamente nei testi ma anche nella vita reale. Le decisioni del capitolo che tendessero a sopprimere qualsiasi tipo di dipendenza o di "accountability" non si possono accettare. "Le forme della povertà di ognuno e di ciascuna comunità dipenderanno dal tipo di istituto e dalla forma di obbedienza, che vi è praticata; cosí si realizzerà, secondo le particolari vocazioni, il carattere di dipendenza, che è inerente ad ogni povertà" (Evangelica testificatio, n. 21 e anche nn. 16-22)» (CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Lettera sugli atti del Capitolo Generale Speciale, 10 luglio 1972, n. 2; cfr. EV IV, 1728).
Il documento, rivolto alle congregazioni femminili, è particolarmente interessante in quanto riguarda il periodo postconciliare ricco di fermenti, di ricerche e di nuove esperienze, per quanto non tutte positive. Si sottolinea il fatto che la materia del voto di povertà e la sua pratica devono essere determinate dal Capitolo "in modo assai preciso", principio questo non sempre applicato. Non bastano, infatti, delle indicazioni generiche o delle semplici esortazioni. Altro aspetto importante è quello del lavoro. Il documento ne sottolinea la dignità invitando anche le religiose a "guadagnarsi da vivere" e ad attuare un'autentica condivisione fraterna. In verità, in alcune congregazioni religiose l'esortazione al lavoro ha trovato un'applicazione fin troppo sollecita, facendo della vita religiosa un'attività lavorativa a tempo pieno e a basso costo. Forse occorrerebbe una riflessione piú profonda circa l'equilibrio fra vita attiva e contemplativa, mai abbastanza ribadito (cfr. Lc 10,38-42). Anche in questo testo, piuttosto puntuale, viene sottolineato il "senso corretto della dipendenza", non solamente nei testi ma anche nella vita concreta. Si precisa ulteriormente che le decisioni capitolari "che tendessero a sopprimere qualsiasi tipo di dipendenza o di "accountability" (responsabilità o rendiconto) non si possono accettare". Lo stesso concetto è ribadito nuovamente quando si afferma che "si realizzerà, secondo le particolari vocazioni, il carattere di dipendenza, che è inerente ad ogni povertà". L'elemento della dipendenza dunque appare costantemente ribadito in modo chiaro e certo.
Il documento successivo è la lettera di sua santità Giovanni Paolo II del 31 maggio 1983, ai vescovi degli Stati Uniti d'America, sui problemi della vita consacrata:
«p. 20. Il consiglio evangelico della povertà ad imitazione di Cristo richiede una vita povera, di fatto e di spirito, soggetta al lavoro e vissuta con frugalità e distacco dai possessi materiali. Tale professione, fatta con voto, comporta per i religiosi dipendenza e limitazione nell'usare e disporre delle cose temporali secondo le norme del diritto proprio dell'istituto (can. 600).
p. 21. Con il voto di povertà il religioso rinuncia al libero uso e alla disponibilità di beni che abbiano un valore materiale. Prima della prima professione cede l'amministrazione dei suoi beni a chiunque voglia e, a meno che le costituzioni non determino altrimenti, dispone liberamente del loro uso e usufrutto (can. 668). Qualsiasi cosa il religioso venga ad acquisire con il proprio lavoro, per donazione o con la propria industria, è acquisita dall'istituto; anche quanto riceva come pensione, sussidio o assicurazione è acquisito per l'istituto, a meno che il diritto proprio dell'istituto non preveda altrimenti (can. 668, §3)» (cfr. GIOVANNI PAOLO II, lettera su i problemi della vita consacrata, 31 maggio 1983, n. 5; EV IX, 266-267).
La lettera conferma sostanzialmente le norme già date nel Codice di diritto canonico. Vi si afferma chiaramente che il religioso deve condurre una "vita povera, di fatto e di spirito, soggetta al lavoro e vissuta con frugalità e distacco dai possessi materiali". Si ribadisce ancora una volta che "il voto comporta per i religiosi dipendenza e limitazione nell'usare e disporre delle cose temporali secondo le norme del diritto proprio dell'istituto" e la "rinuncia al libero uso e alla disponibilità di beni che abbiano un valore materiale". Le medesime sottolineature le troviamo nell'esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata ai numeri 87 e 90:
«87. Il compito profetico della vita consacrata viene provocato da tre sfide principali rivolte alla stessa Chiesa: sono sfide di sempre, che vengono poste in forme nuove, e forse piú radicali, dalla società contemporanea, almeno in alcune parti del mondo. Esse toccano direttamente i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, stimolando la Chiesa e, in particolare, le persone consacrate a metterne in luce e a testimoniarne il profondo significato antropologico. La scelta di questi consigli, infatti, lungi dal costituire un impoverimento di valori autenticamente umani, si propone piuttosto come una loro trasfigurazione. I consigli evangelici non vanno considerati come una negazione dei valori inerenti alla sessualità, al legittimo desiderio di disporre di beni materiali e di decidere autonomamente di sé. Queste inclinazioni, in quanto fondate nella natura, sono in se stesse buone. La creatura umana, tuttavia, debilitata com'è dal peccato originale, è esposta al rischio di tradurle in atto in modo trasgressivo. La professione di castità, povertà e obbedienza diventa monito a non sottovalutare le ferite prodotte dal peccato originale e, pur affermando il valore dei beni creati, li relativizza additando Dio come il bene assoluto. Cosí coloro che seguono i consigli evangelici, mentre cercano la santità per se stessi, propongono, per cosí dire, una «terapia spirituale» per l'umanità, poiché rifiutano l'idolatria del creato e rendono in qualche modo visibile il Dio vivente. La vita consacrata, specie nei tempi difficili, è una benedizione per la vita umana e per la stessa vita ecclesiale.
90. In realtà, prima ancora di essere un servizio per i poveri, la povertà evangelica è un valore in se stessa, in quanto richiama la prima delle Beatitudini nell'imitazione di Cristo povero. Il suo primo senso, infatti, è testimoniare Dio come vera ricchezza del cuore umano. Ma proprio per questo essa contesta con forza l'idolatria di mammona, proponendosi come appello profetico nei confronti di una società che, in tante parti del mondo benestante, rischia di perdere il senso della misura e il significato stesso delle cose. Per questo, oggi piú che in altre epoche, il suo richiamo trova attenzione anche tra coloro che, consci della limitatezza delle risorse del pianeta, invocano il rispetto e la salvaguardia del creato mediante la riduzione dei consumi, la sobrietà, l'imposizione di un doveroso freno ai propri desideri. Alle persone consacrate è chiesta dunque una rinnovata e vigorosa testimonianza evangelica di abnegazione e di sobrietà, in uno stile di vita fraterna ispirata a criteri di semplicità e di ospitalità, anche come esempio per quanti rimangono indifferenti di fronte alle necessità del prossimo. Tale testimonianza si accompagnerà naturalmente all'amore preferenziale per i poveri e si manifesterà in modo speciale nella condivisione delle condizioni di vita dei piú diseredati. Non sono poche le comunità che vivono e operano tra i poveri e gli emarginati, ne abbracciano la condizione e ne condividono le sofferenze, i problemi e i pericoli. Grandi pagine di storia di solidarietà evangelica e di dedizione eroica sono state scritte da persone consacrate, in questi anni di profondi cambiamenti e di grandi ingiustizie, di speranze e di delusioni, di importanti conquiste e di amare sconfitte. E pagine non meno significative sono state e sono tuttora scritte da altre innumerevoli persone consacrate, le quali vivono in pienezza la loro vita «nascosta con Cristo in Dio» (Col 3, 3) per la salvezza del mondo, all'insegna della gratuità, dell'investimento della propria vita in cause poco riconosciute e meno ancora applaudite. Attraverso queste forme diverse e complementari, la vita consacrata partecipa all'estrema povertà abbracciata dal Signore e vive il suo specifico ruolo nel mistero salvifico della sua incarnazione e della sua morte redentrice» (cfr. GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata, 25 marzo 1996, nn. 87 e 90).
L'Esortazione evidenzia il profondo significato antropologico dei consigli evangelici e la testimonianza profetica insita in essi davanti ad un mondo afflitto dal peccato. La povertà evangelica, lungi dal giustificarsi, ad esempio, per ragioni sociologiche, ha un preciso valore intrinseco. Essa richiama la prima delle Beatitudini nell'imitazione di Cristo povero. "Alle persone consacrate è chiesta dunque una rinnovata e vigorosa testimonianza evangelica di abnegazione e di sobrietà, in uno stile di vita fraterna ispirata a criteri di semplicità e di ospitalità, anche come esempio per quanti rimangono indifferenti di fronte alle necessità del prossimo". Altro rilievo è dato all'amore preferenziale per i poveri da manifestarsi specialmente "nella condivisione delle condizioni di vita dei piú diseredati". In questo importante e recente testo del 25 marzo 1996 non viene richiamato esplicitamente il concetto di dipendenza. Tuttavia occorre rilevare che il documento non ha un carattere giuridico puntuale come quelli precedentemente esposti, bensí prevalentemente teologico ed esortativo. Nel numero 4 dello stesso documento, infatti, si afferma: «Aderendo al desiderio manifestato dall'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi raccolta per riflettere sul tema "La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo", intendo proporre in questa Esortazione apostolica i frutti dell'itinerario sinodale e mostrare a tutti i fedeli - Vescovi, presbiteri, diaconi, persone consacrate e laici -, come pure a quanti vorranno porsi in ascolto, le meraviglie che il Signore anche oggi vuole compiere attraverso la vita consacrata». L'esortazione Vita consecrata insomma testimonia l'importanza che oggi la Chiesa annette al consiglio evangelico della povertà in un'ottica carismatica e profetica.
Giungiamo infine al Codice di diritto canonico, che nei cann. 600 e 668 afferma quanto segue:
«Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti» (can. 600).
Il canone partendo dal principio cristologico menziona una "vita povera di fatto e di spirito", sottolinea l'importanza dell'operosità e della sobrietà, confermando il principio della limitazione e della dipendenza nell'usare e disporre dei beni.
Ǥ1. Avanti la prima professione i membri cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni non stabiliscono altrimenti, liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono inoltre, almeno prima della professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile.
§2. Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.
§3. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall'istituto, a meno che il diritto proprio non disponga diversamente.
§4. Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai suoi beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa. Ugualmente proceda il professo di voti perpetui che a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o a parte di essi, con licenza del Moderatore supremo.
§5. Il professo che per la natura dell'istituto ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni che ricevesse dopo tale rinuncia toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio» (can. 668).
Il canone 668 prescrive al §1 l'obbligo di cedere l'amministrazione dei beni antecedentemente alla prima professione. Prima della professione perpetua il religioso deve redigere un testamento valido anche secondo il diritto civile. A seconda del diritto proprio dell'istituto egli, dopo la professione perpetua, perde anche l'uso e l'usufrutto. Come prescrive il §3 anche ciò che il religioso acquista successivamente con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. A norma del §5 e avuto riguardo alla natura dell'istituto il professo che ha compiuto la rinuncia radicale ai beni (è il caso, per es., degli ordini francescani) perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza per il diritto canonico pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà. I beni che ricevesse dopo tale rinuncia saranno di proprietà dell'istituto, a norma del diritto proprio.
In base ai documenti cosí esaminati appare evidente che non è possibile escludere dal voto di povertà la "dipendenza", essendoci oltretutto un legame anche con il voto di obbedienza che postula tale modo di concretizzare il voto stesso. Pur avendo riguardo alle ragioni psicologiche e sociologiche, che spingerebbero ad un riesame della modalità di concretizzazione del voto, non è proponibile la tesi di una proprietà e gestione individuale dei beni, da parte di un religioso, sia pure all'interno di un progetto comune. Tale stile di vita, infatti, sarebbe proprio di un presbitero diocesano piuttosto che di un religioso, ancorché vissuto in un contesto comunitario. Ripensare in tale modalità il voto di povertà e di obbedienza - e quindi la vita religiosa -, infatti, significherebbe non mutarne ma snaturarne la natura stessa cosí come è stata costantemente definita nella dottrina teologica e canonica. Sarebbe un tentativo umano di rispondere ad una problematica la cui soluzione non è puramente umana ma soprannaturale: "Esistono molte cose che mantengono il loro senso, anche se manca la fede; nella vita religiosa nulla ha senso se manca la fede radicale. Forse è proprio qui l'origine di molti dispiaceri e assurdità presenti oggi nella vita religiosa" (cfr. DIEZ F. M., La nuova frontiera. Dal rischio dell'estinzione alla sfida della rifondazione della vita religiosa, Cinisello Balsamo 2002, 73-74).
Resta la possibilità tuttavia di valutare tale tesi in proposte di spiritualità secolare, certo non qualificabili come "vita religiosa", ma pur sempre potenzialmente efficaci per il bene delle anime e per l'azione apostolica. In verità occorre prestare attenzione a non identificare, cosa piuttosto frequente, "vita consacrata" con "vita religiosa". Nei cann. 573-578 CIC viene data una descrizione della vita consacrata, che da una parte non è sufficiente a definire la vita religiosa, perché questa comporta altri elementi (cfr. can. 607); e d'altra parte ne è piú ampia, perché il valore della consacrazione, che sigilla la dedizione totale a Dio con la sua sequela Christi e la sua dimensione ecclesiale, compete anche agli Istituti secolari.
La strada da intraprendere per promuovere il rinnovamento della vita consacrata pertanto è un'altra ed è quella di ripristinare quella tensione spirituale - ove la preghiera e la contemplazione occupano il primo posto - che sola rende possibile la scelta radicale del Vangelo. Papa Paolo VI nella Evangelica testificatio (nº 19) ribadiva:
«In una civiltà e in un mondo contrassegnati da un prodigioso movimento di crescita materiale quasi indefinita, quale testimonianza offrirebbe un religioso che si lasciasse trascinare da una ricerca sfrenata delle proprie comodità, e trovasse normale concedersi senza discernimento né ritegno tutto ciò che gli viene proposto? Mentre, per molti è aumentato il pericolo di essere invischiati nella seducente sicurezza del possedere, del sapere e del potere, l'appello di Dio vi colloca al vertice della coscienza cristiana: ricordare cioè agli uomini che il loro progresso vero e totale consiste nel rispondere alla loro vocazione di "partecipare come figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti gli uomini"».
6. Appunti sulla vita penitenziale
Fra i segni piú evidenti della crisi della vita religiosa c'è quello della perdita dello spirito penitenziale strettamente collegato ad una profonda vita di preghiera. Se in passato la vita del religioso era costellata di pratiche penitenziali, talora molto formali e superate (si pensi alla pratica della disciplina, ossia della flagellazione, mantenuta fino agli anni '60), oggi prevale l'orientamento di lasciare la loro attuazione concreta agli individui, riducendone cosí drasticamente la dimensione comunitaria. Non si può non rilevare l'effetto deleterio di contro-testimonianza che tale prassi ha sia a livello spirituale e pastorale, sia a livello vocazionale.
Una prassi penitenziale significativa, equilibrata e rispondente alla sensibilità odierna è quanto mai necessaria. Non si rileverà mai abbastanza quanto sia deleteria, soprattutto nei giovani, una vita religiosa imborghesita, priva di segni e gesti concreti. Cosí scrive Paolo VI nella Paenitemini del 17 febbraio 1966:
«La vera penitenza però non può prescindere, in nessun tempo, da una ascesi anche fisica: tutto il nostro essere, infatti, anima e corpo, anzi tutta la natura, anche gli animali senza ragione, come ricorda spesso la sacra scrittura, deve partecipare attivamente a questo atto religioso con cui la creatura riconosce la santità e maestà divina. La necessità poi della mortificazione del corpo appare chiaramente se si considera la fragilità della nostra natura, nella quale, dopo il peccato di Adamo, la carne e lo spirito hanno desideri contrari tra loro. Tale esercizio di mortificazione del corpo, ben lontano da ogni forma di stoicismo, non implica una condanna della carne, che il Figlio di Dio si è degnato di assumere; anzi, la mortificazione mira alla "liberazione" dell'uomo, che spesso si trova, a motivo della concupiscenza, quasi incatenato dalla parte sensitiva del proprio essere; attraverso il "digiuno corporale" l'uomo riacquista vigore e "la ferita inferta alla dignità della nostra natura dall'intemperanza, viene curata dalla medicina di una salutare astinenza"» (cfr. PAOLO VI, cost. ap. Paenitemini, 17 febbraio 1966, n. 2; EV II, 636).

Lettera circolare del Ministro Generale OFMCap. p. Salvatore da Ozieri del 4 ottobre 1853. Il documento testimonia in modo schietto la difficile situazione della vita religiosa in un'epoca turbolenta caratterizzata dalla soppressione arbitraria degli Ordini religiosi a seguito delle leggi Siccardi (1850), volute dalla violenta politica anticattolica dei Savoia.
«Pp., e Ff. carissimi si badi bene a' Noviziati, perché è ormai evidente, che le Provincie, dove sgraziatamente poco, o nulla si bada a questi luoghi di sperimento, sono divenute l'obbrobrio dell'Ordine, e lo scandalo dei medesimi secolari, che meglio di noi conoscono le qualità delle persone, che lasciano le loro case per vestire l'abito religioso talvolta senza altro fine, che di assicurare la loro sussistenza, o di scuotere il giogo de' propri Genitori... Per carità o Ministri Provinciali, e quanti siete Religiosi di zelo e che, per misericordia di Dio, formate la gran maggioranza dell'Ordine, allontanate da luoghi dove questi nemici di Dio, e delle anime, si annidano, allontanatene la Gioventù. Si armino tutti i buoni di un santo zelo contro queste belve feroci, che aspirano alla distruzione dell'Ordine, non già ad offendere le loro persone; ma a smascherarli in faccia a' Superiori, e a distruggere le perverse loro massime; non solamente combattendole colle opportune vostre istruzioni; ma vieppiù coll'esattezza, ed esemplarità della vostra vita».
7. Appunti sulla fraternità e sul rapporto con la povertà
In seno agli Ordini francescani, in seguito alla svolta conciliare e in parte come reazione alla secolare problematica sul tema della povertà, si è optato in anni recenti per un mutamento di indirizzo, che non ha mai formalmente abolito la sottolineatura della povertà, ma ha posto nettamente in risalto il valore della fraternità, assurta di fatto a tratto distintivo dell'istituzione e talvolta tratteggiata piú o meno ufficiosamente anche quale carisma. L'accentuazione eccessiva della fraternità - mediaticamente certo piú affascinante della povertà - può comportare tuttavia un grave errore pedagogico: l'idea che la fraternità sia in certo qual modo un dato di fatto, una caratteristica affermata e non tanto un obiettivo da raggiungere. Quante difficoltà e crisi provengono dalla constatazione che essa non è certo una realtà acquisita ma anzitutto e sempre acquirenda? Ciò è vero sia all'interno della dimensione religiosa sia all'esterno, nella dimensione apostolica:
«E oggi, all'alba di un nuovo millennio, l'avventura francescana ha ancora un senso, ha ancora qualche probabilità di successo? Mai la vera fraternità è stata al tempo stesso tanto auspicata e cosí poco vissuta. Mai il carisma francescano è stato piú attuale per offrire il Cristo totale a un mondo spaccato che ha paura di una fraternità solidale di tutti gli uomini senza esclusione. A fraternità universale, solidarietà universale e non selettiva secondo i propri interessi o comodità: si scelgono gli amici ma non i fratelli e le sorelle, ciò che rende, per il suo carattere indelebile, la fraternità assai onerosa» (cfr. omelia del cardinal Roger Etchegaray per il giubileo della Famiglia francescana, Basilica di san Giovanni in Laterano, 9 aprile 2000).
Pur sottolineando il valore della fraternità sembra ben piú opportuno invece spostare l'attenzione verso i valori e i principi sui quali essa si fonda: la preghiera in primo luogo. È la dimensione verticale del rapporto con Dio che è fondativa di quella orizzontale con il fratello e non viceversa, ancorché questa sia la verifica di quella. In questo senso l'antica accentuazione sulla sequela della povertà di Cristo era forse più aperta alla dimensione verticale del rapporto con Dio. Ciò assodato forse si tratterà molto meno della fraternità e delle sue problematiche ma si acquisteranno alcuni indubbi vantaggi: quello del realismo e quello dell'operare fruttuoso che proviene dall'azione dello Spirito. È essenziale questa ricerca, forse è opportuno un ripensamento, un nuovo equilibrio fra povertà e fraternità. I doni dello Spirito non sono acquisiti una volta per sempre. Senza questa tensione anche i grandi Ordini e le Congregazioni che vantano i carismi piú grandi possono perderli e, di conseguenza, venir meno alle loro responsabilità ecclesiali. In questo caso sorgeranno nuovi movimenti e altre entità ecclesiali dedite ad una piú autentica sequela evangelica.
In qualità di peccatori siamo tutti incapaci di stabilire relazioni fraterne piene e perfette. La realtà concreta ci vede tutt'altro che fratelli, come ci ricorda la spesso disprezzata ma quanto mai vera e saggia dottrina del peccato originale. Siamo e saremo sempre esposti alla tentazione dell'egoismo e della prevaricazione ecco perché, senza cadere nella visione pessimista di un passato recente, si deve ricuperare una dimensione ascetica e spirituale della vita che richiede il superamento di sé e del proprio egoismo. Recuperarla significa recuperare appunto quella "dimensione verticale" della vita che apre all'altro e che può mutare sostanzialmente la vita di una comunità, generando quella tensione spirituale che fa la differenza con il mondo. Il mondo non sa che farsene di una Chiesa o di una comunità che parlano di se stesse, ma è irresistibilmente affascinato da una Chiesa e da una comunità dove si avverte il mistero di Dio. Ma fino a che punto le comunità religiose di oggi rispondono ancora e concretamente alle indicazioni della LG 43?
In questi ultimi decenni i religiosi hanno parlato troppo di se stessi e dei propri problemi, fra di loro, fino alla noia; occorre invece che ricomincino a parlare di Dio e - ancor piú - a parlare con Dio, sia ad intra, sia ad extra. Una lunga stagione di "convegnismo" e di introspezioni non sempre felici, ci ha forse fatto ricadere in una sorta di grigio egoismo comunitario e individuale dalla quale non potevano non emergere soprattutto i limiti e questo a dispetto di ogni saggia prassi spirituale, che esorta sí ad effettuare l'esame di coscienza, ma in modo sincero e conciso, senza eccessive e pericolose indulgenze. I principali problemi concernenti la vita religiosa sono stati sviscerati e non sono piú a carattere teorico, sono problemi pratici, di impegno e di azione. Si dovrebbe passare dal dire al fare, in caso contrario si correrà il rischio che i discorsi diventino solo un pretesto per differire la conversione.
L'uomo di Dio risolve i suoi problemi non ponendosi di fronte a se stesso ma di fronte a Dio. Solo il mondo, di cui parla l'apostolo Giovanni, quel mondo che non ha conosciuto Dio (1Gv 3,1), ritiene di potersi salvare da sé. È cosí che il politico confida nel potere, l'uomo d'affari nella ricchezza e l'intellettuale ripone tutte le sue speranze nel sapere umano. L'uomo di fede invece, con tutta la sua forza, con tutte le sue ricchezze e con tutto il suo sapere guarda anzitutto a Dio, fonte di ogni speranza e di ogni bene. Guardando verso Dio, progettando la vita su un'esperienza radicale di Dio, forse senza neppure rendersene conto, ci si ritrova piú vicini ai fratelli, al di là di ogni aspettativa. L'ideale sommo della vita religiosa non è la perfezione morale ma l'esperienza radicale di Dio. Senza questa ricerca di Dio, senza il recupero delle basi teologali della vita religiosa, a ben poco gioverà il ribadirne disciplinarmente gli obblighi comunitari e l'osservanza regolare. I voti non sono mere rinunce a qualcosa di cattivo. Vivere i voti nella loro dimensione teologale significa trasformarli in temi di spiritualità, non di pura ascetica o di morale.
«Andate e annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno» (Mt 28,10). «La vita religiosa deve interrogarsi con grande onestà dove sia la propria Galilea e la propria Gerusalemme. È una domanda fondamentale per identificare le vere radici dell'attuale notte oscura e per cercare una via d'uscita dalla crisi. Bisogna collocarsi nel luogo esatto per ricevere il dono della fede radicale e per incontrare il Risuscitato. Questo luogo è la Galilea, il luogo della sequela. Coloro che cercano di seguire Gesú si accostano alla fede pasquale, riconoscono il Risuscitato. Coloro che accedono alla fede pasquale sono capaci di una sequela fedele. [...] La vita religiosa deve domandarsi oggi se non è troppo abituata a vivere a Gerusalemme, nel centro, nel luogo delle grandi tradizioni religiose, dove si eliminano i profeti e non si attende nulla di nuovo... Deve domandarsi se è disposta a vivere la sequela in Galilea, nelle periferie, nelle zone di frontiera» (cfr. DIEZ F. M., La nuova frontiera. Dal rischio dell'estinzione alla sfida della rifondazione della vita religiosa, Cinisello Balsamo 2002, 117-118).
8. Gli altri aspetti della vita consacrata: ipotesi per un'attualizzazione
Nella società odierna un bene che diventa sempre piú prezioso è quello del tempo. La forma piú grave di povertà per l'uomo moderno, immerso nel benessere, è quella della scarsità del tempo libero; libero però affinché divenga "tempo per Dio e per l'altro". Questo è uno dei grande inganni della società moderna che con la tecnologia si proponeva di affrancare l'uomo dal lavoro-schiavitú restituendolo al lavoro creativo; ebbene spesso non è andata cosí.
Se c'è un luogo dove occorre riappropriarsi il piú possibile del tempo per consacrarlo a Dio è quello della vita religiosa: occorre tempo e luogo per realizzarsi secondo la propria vocazione. Il tempo è la "prima Galilea", il primo "luogo" della sequela. Il discernimento dei superiori e della fraternità in tale materia è quanto mai delicato e importante. La vita religiosa, lungi dal diventare una mera struttura organizzativa assoggettata ai ritmi ossessivi del mondo, deve consentire una riappropriazione del tempo, vissuto come luogo di incontro con Dio, con se stessi e dunque anche con il prossimo. La vita religiosa non può e non deve mai scadere nell'attivismo e pur avendo una valenza apostolica non può essere mai ridotta alle esigenze della pastorale. Piú essa si inquadra e si auto-riduce in un'ottica di servizio pastorale, piú rischia di perdere il suo carico di testimonianza e di profezia. Secondo J. B. Metz si è difatto verificata una "parrocchializzazione della vita religiosa" con conseguenze nefaste per la vita religiosa stessa e per la Chiesa che ha portato all'indebolimento della sequela radicale di Cristo nella comunità cristiana (cfr. METZ J. B., Tempo di religiosi? Mistica e politica della sequela, Brescia 1978). Tale parrocchializzazione ha rappresentato una perdita per la vita religiosa, per la Chiesa e per la società intera.
Posta questa necessaria premessa occorre chiedersi anche quali possano essere le altre cause che contribuiscono a determinare la crisi odierna della vita religiosa. Esse sono indubbiamente molteplici e non risiedono unilateralmente né nei singoli, né nelle istituzioni. Sono in parte anche un frutto della nostra epoca e di una sofferta stagione post-conciliare dove il necessario e legittimo mutamento di regole e di consuetudini ha portato inevitabilmente con sé confusione e disorientamento. Sarebbe disonesto tuttavia attribuire questa situazione alla sola svolta conciliare, soprattutto se si considera l'epoca di sconvolgimenti sociologici e tecnologici che ancora ci vede soggetti attivi e passivi.
Viviamo in un epoca che piú di ogni altra è caratterizzata dalla libertà e dall'individualismo e i cui effetti sono evidenti anche nella tendenza ad abbandonare gli abiti religiosi per privilegiare quelli borghesi (vedasi per es. la direttiva sull'abito religioso della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari del 12 novembre 1976 in EV Suppl. 1, 644-648). L'individualismo è anche l'effetto collaterale della rivalutazione della persona che la nostra cultura ha giustamente promosso. Non mancano quelli che propongono un attacco frontale all'individualismo additandolo come la fonte di tutti i mali. In parte è cosí, tuttavia il senso della realtà dovrebbe far comprendere che sarebbe pressoché vano contrastarlo in tal modo. Piú saggio forse sarebbe tenere conto di questa realtà dell'uomo d'oggi nel servire la causa del Vangelo. Del resto cosa viene insegnato nella parabola della zizzania? Ecco:
«I servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano» (Mt 13,27-29).
Il pericolo è che nel tentativo di estirpare l'individualismo si calpesti la persona e si cada nella tentazione dell'autoritarismo in un conflitto che avrebbe ben poco di evangelico. Così la pedagogia divina non è quella di sopraffare la persona ma di recuperarla e purificarla dal suo egoismo con la medicina dell'amore e della sofferenza della vita.
Un altro limite che non di rado affligge le istituzioni religiose e l'insufficiente responsabilizzazione della persona. Quante volte il singolo non sente di appartenere davvero ad una comunità, ad un corpo vivo e di offrire il proprio contributo? Forse molti religiosi sono stati ridotti a piccoli ingranaggi di un meccanismo abnorme e impersonale. Quante volte si viene ridotti a meri esecutori di ordini e disposizioni non sempre comprensibili? E quante volte l'assegnazione delle responsabilità è preclusa a tanti? Si viene davvero educati poi alla responsabilità? O forse viene chiesto per lunghi anni soltanto di rendere approssimativamente conto di se stessi? Si viene posti in condizione di imparare a gestire anche i beni di questo mondo? Non è forse scandaloso che per le urgenze pastorali si conferisca quanto prima l'ordinazione sacerdotale mentre si presti spesso un'attenzione piú che scrupolosa nella scelta di economi e amministratori? Qual è la vera gerarchia di valori che guida scelte così gravi? Ancora una volta è il caso di chiedersi se non si stia dando troppa importanza al "poco" e decisamente poca al "molto" (cfr. Lc 16,11-12).
Un'altra problematica è quella dell'insufficiente libertà evangelica. Non semplicemente libertà ma libertà evangelica. Nella realtà quotidiana la vita religiosa diventa anche un fatto giuridico, un insieme di obblighi. Essa conduce anche a delle forme di "controllo comunitario/sociale" che alla lunga possono rendere il consacrato asservito ad un contesto anziché protagonista principale e sempre nuovo della sua scelta, ciò che si può chiamare: "esproprio della scelta" o "esproprio della vocazione". Ciò accade soprattutto quando l'autorità non piú propositiva e povera di tensione spirituale, assume principalmente la funzione di controllo e/o di coazione. Questo modo di intendere l'autorità può compromettere anche il modo di intendere l'obbedienza consacrata che nel Vangelo non è mai intesa more militari come dovere pressoché incondizionato, ma come libera e costante donazione di sé che può scaturire solo dalla carità.
La crisi delle vocazioni e il conseguente calo numerico ha fra le sue conseguenze la sottovalutazione dell'aspetto formativo. Le esigenze della pastorale e dell'apostolato prendono talvolta il sopravvento su altri principi, cosicché il religioso e il sacerdote vengono ridotti a forza lavoro e a funzionari di culto. La piú grave delle carenze formative spirituali e culturali tocca il nostro modo di essere e di intenderci come cristiani: abbiamo bisogno di una cultura cattolica, dobbiamo acquisire un pensiero, una visione e un respiro genuinamente cattolici, liberi tuttavia da ogni ottuso integralismo che ne limiti gli orizzonti. Oggi piú che mai la Chiesa ha bisogno di religiosi e di sacerdoti colti e preparati ad affrontare le sfide del mondo e della modernità. Se si vuole che il Vangelo ne diventi l'anima occorre saper evangelizzare anzitutto la cultura. È più che mai urgente riscoprire l'importanza della carità intellettuale contro una falsa e deleteria demagogia pauperistica che ha spesso condannato lo studio e la cultura come espressioni e forme del potere e della ricchezza. Eppure quanto era esigente Francesco di Assisi circa l'autenticità della fede e del culto:
«Tutti i frati siano cattolici e vivano e parlino cattolicamente. Se qualcuno a parole o a fatti si allontanerà dalla fede e dalla vita cattolica e non se ne sarà emendato, sia espulso totalmente dalla nostra fraternità» (RegNB XIX, 1-2: FF 51).
«Quei frati, poi, che non vorranno osservare queste cose, non li ritengo cattolici, né miei frati: io non li voglio vedere, non ci voglio parlare finché non abbiano fatto penitenza» (EpOrd 44: FF 229).
Non meno importante è la contemporanea raccomandazione di Francesco circa il rapporto fra lo studio e la vita di preghiera:
«A frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco augura salute. Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa occupazione, non estingua lo spirito dell'orazione e della devozione, come sta scritto nella Regola» (EpAnt 1-2: FF 251-252).
La castità per il regno dei cieli è la dimensione piú importante della vita consacrata, come sottolinea giustamente il Concilio ponendola al primo posto (PC 12-14). Essa può e deve essere oggetto di una decisa rivalutazione, tanto piú quanto piú oggi essa è contestata. È ora che non si accettino piú, in alcun modo, un linguaggio e una pedagogia che la sminuiscano o la facciano considerare come rinuncia alla dimensione dell'amore. Proprio la castità invece è la risposta radicale alle sue esigenze piú profonde; è la scelta dell'Unico e del Solo che merita una "donazione totale"; è il tesoro nascosto in un campo per cui vale la pena di vendere tutti i propri averi per possederlo (Mt 13,44). In quest'ottica è il consiglio evangelico che piú promuove la persona rendendola potenzialmente aperta, nella totalità e intimità del suo essere, alla presenza e all'azione dello Spirito. La solitudine umana legata alla castità costituisce il consacrato in uno stato iniziale di povertà affettiva, che può renderlo solidale con i sofferenti, e che al tempo stesso pone la premessa per un orizzonte relazionale piú ampio. L'amicizia, necessaria per l'umano equilibrio e per una vita spirituale ricca e feconda, rientra in special modo in questo orizzonte illimitato. Lo stesso Signore ha coltivato l'amicizia intrecciando relazioni umane profonde e significative (Gv 11,1-44).
L'amicizia nella vita del consacrato pertanto dovrebbe costituire una costante e uno stile di vita, pur senza eccessivi ed immaturi attaccamenti umani. È molto importante infatti, anche nel piú profondo dei rapporti di amicizia, mantenere la giusta indipendenza affettiva. In altre parole, l'amico non può diventare una ragione di vita, non deve rendere secondaria quella dinamica relazionale che l'uomo deve instaurare anzitutto con Dio (Mt 10,37; Lc 14,26). L'amico autentico, lungi dallo sminuirlo, facilita proprio questo rapporto con Dio. «La virtú della castità si dispiega nell'amicizia. Indica al discepolo come seguire ed imitare colui che ci ha scelti come suoi amici, si è totalmente donato a noi e ci rende partecipi della sua condizione divina. La castità è promessa di immortalità. La castità si esprime particolarmente nell'amicizia per il prossimo. Coltivata tra persone del medesimo sesso o di sesso diverso, l'amicizia costituisce un gran bene per tutti. Conduce alla comunione spirituale» (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1992, n. 2347).
Esiste un grado di amicizia, vicino alla perfezione, quando l'uomo, mediante l'amico, diventa l'amico dell'Uomo-Dio. In una simile amicizia, mentre s'approfondisce l'unione affettiva con l'amico, parallelamente si penetra in ulteriore intimità amichevole col Cristo: "et sic per amoris gradus ad Christi conscendens amicitiam, unus cum eo spiritus efficitur in osculo uno" (cfr. AELREDUS RIEVALLENSIS, De spirituali amicitia, 1. II, PL 195, 672). Un'amicizia sincera e fondata sull'amore gratuito di Dio non solo non sarà di ostacolo alla vita fraterna ma la arricchirà ed approfondirà, a tutto vantaggio della vita spirituale e di unione con Dio (cfr. PESENTI G. Gr., Affettività, in AA. VV., Dizionario enciclopedico di spiritualità, I, a cura di Ermanno Ancilli e del Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresianum, (Collana Grandi Opere), Roma 1990, 37-39). Un'amicizia sincera nel Signore dunque può essere un aiuto determinante per la scelta celibataria ma è anzitutto in Cristo Uomo-Dio che il consacrato trova il suo amico e modello, colui che totalmente si dona nell'amore. Ed è soprattutto nel cammino spirituale, nella preghiera, che sarà di prezioso aiuto la contemplazione dell'umanità di Cristo (cfr. S. TERESA DI GESÚ, Opere, Roma 19858, 210-221).
Fra le cause della crisi odierna della vita consacrata si deve infine rilevare anche la poca autenticità e concretezza del modo di vivere la povertà, sulla quale sopra si è ampiamente riflettuto. Non di rado il modo di intenderla e realizzarla non risponde alla realtà attuale e rischia di relegare il religioso entro un orizzonte umano e culturale ristretto e limitato. Tradizionalmente il voto di povertà si concretizza nel rifiuto del denaro (o meglio nella rinuncia alla sua gestione personale), nel rifiuto della proprietà individuale dei beni (privilegiando la proprietà comunitaria) e in alcuni casi nel lavoro come mezzo di sostentamento principale e di aiuto ai poveri. L'elemosina, nella comunità francescana delle origini, era ammessa solo in caso di necessità (RegNB VII, 1-7: FF 24). Ma questo modo di concretizzare la povertà - potremmo chiederci - è ancora credibile? Può essere ripensato avendo riguardo alla mentalità dell'uomo d'oggi? La povertà di fatto non è diventata una sorta di assistenzialismo ecclesiale che lascia il religioso incapace di iniziativa e lo rende oggetto di una sorta di previdenza istituzionale? Si tratta di uno stile di povertà deresponsabilizzante, di una sorta di interdizione socio-ecclesiale che non è formativa né circa la realtà della vita, né circa il valore genuino dei beni materiali.
La rinuncia totale alla proprietà comunitaria, strada seguita in passato con poco successo, per esempio, dalla riforma francescano-cappuccina, farebbe pensare ad un rischio velleitario se non fosse sancita dal Concilio di Trento (cfr. Concilium Tridentinum, Sess. XXV, De regularibus et monialibus, cap. III). Tale via, dai tentativi ambigui dei patroni laici, non esenti da abusi, si concluse poi in molti casi con l'ennesima fictio iuris dell'intestazione dei beni immobili alla Santa Sede. La situazione odierna con la creazione di enti morali propri e di altri istituti giuridici simili appare in ultima analisi piú seria e credibile. In merito alla capacità di possesso comunitaria è interessante il can. 634, §1 che afferma: «Gli istituti, le province e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a meno che tale capacità non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni». Resta dunque confermata la possibilità di una rinuncia al possesso anche comunitario dei beni, benché essa non appaia molto diffusa. Tuttavia all'atto pratico "pensare ad un religioso povero in una religione ricca, di cui il religioso è parte complementare, in quanto la famiglia religiosa è persona morale collegiale (persona giuridica) è semplicemente assurdo" (cfr. BONI A., Povertà ecclesiale e povertà francescana oggi, (Collectio Assisiensis 30), S. Maria degli Angeli - Assisi 2002, 80-81. San Gerolamo, già ai suoi tempi, notava questa contraddizione: «Sunt divitiores monachi quam fuerant saeculares; possident opes sub Christo paupere, quas sub locuplete diabolo non habuerant: et suspirat eos Ecclesia divites, quos tenuit mundus ante mendicos» (Epistula ad Heliodorum Episcopum (PL 22, 596)).
Questi sono i paradossi dell'organizzazione comunitaria della vita religiosa, organizzazione che però è solo una sua conseguenza e non un fatto costitutivo. All'atto pratico l'organizzazione, la struttura, può paradossalmente distruggere quella vita religiosa che invece dovrebbe servire. Non bisogna dimenticare poi che prima ancora che con l'organizzazione (Ordine o Congregazione) il religioso si impegna con Cristo a seguirlo nella povertà e nell'umiltà della vita. La struttura non può contraddire ciò che Cristo ha posto in essere. Di fatto, con il tempo, gran parte degli Ordini cosiddetti "mendicanti" rientreranno piú o meno negli schemi delle comunità religiose canonicali e monastiche. Per avere un'idea della novità, anche giuridica, dell'impostazione francescana e della sua difficile comprensione basti pensare all'affermazione di un noto giurista medioevale: «Minorum fratrum sacra religio fuit a Christi confessore Francisco in altissima paupertate fundata: et a summis pontificibus approbata: cuius vita tanta est novitas quod de ea in corpore iuris non reperitur auctoritas» (BARTHOLUS A SASSOFERRATO, Tractatus minoricarum in Iacobo de Grumello, Miscellanea Iuris Franciscalis, Brescia 1502, fr. 177).
Come già sottolineato non è possibile - neanche in un'ottica di attualizzazione - escludere dal voto di povertà la "dipendenza". Vi sono certamente ragioni psicologiche e sociologiche che spingerebbero ad un riesame della modalità di concretizzazione del voto, ma non è proponibile la tesi di una proprietà e gestione individuale dei beni, neppure all'interno di un progetto comune. Ripensare cosí il voto di povertà e di obbedienza - e quindi la vita religiosa -, infatti, significherebbe snaturarne la natura cosí come è stata costantemente definita nella dottrina teologica e canonica. "Esistono molte cose che mantengono il loro senso, anche se manca la fede; nella vita religiosa nulla ha senso se manca la fede radicale. Forse è proprio qui l'origine di molti dispiaceri e assurdità presenti oggi nella vita religiosa" (cfr. DIEZ F. M., La nuova frontiera. Dal rischio dell'estinzione alla sfida della rifondazione della vita religiosa, Cinisello Balsamo 2002, 73-74). Sono possibili invece - ed esistono già - proposte di spiritualità secolare non qualificabili come "vita religiosa", ma comunque efficaci per il bene delle anime e per l'azione apostolica. La strada da intraprendere per promuovere il rinnovamento della vita consacrata non può essere che quella di ripristinare una tensione spirituale - ove preghiera e contemplazione occupano il primo posto - che sola rende possibile la scelta radicale del Vangelo.
9. Conclusione
In questo contesto storico ed ecclesiale cosí complesso e incerto è necessario trovare il coraggio per riproporre in modo nuovo il tesoro di fede e di cultura che abbiamo ricevuto come preziosa eredità. Non si tratta certo di un patrimonio statico ma di un tesoro che chiede a ciascuno di noi un contributo originale, piccolo o grande che sia. Quante volte si ha l'impressione deludente di vivere in un contesto senza fede e senza dignità, dove è stata dimenticata se non addirittura messa al bando un'autentica tensione spirituale?
Senza fede e senza dignità! Non è certo un giudizio azzardato poiché sappiamo benissimo che... «tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtú della redenzione realizzata da Cristo Gesú» (Rm 3,23-24).
In Cristo abbiamo non solo la via ma anche il modo e la forza per realizzare questo cammino... «finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,13). Il quale ci ha insegnato che... «chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui» (Gv 14,21). Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, già qui e non ancora, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo cosí come egli è (cfr. 1Gv 3,2).
**