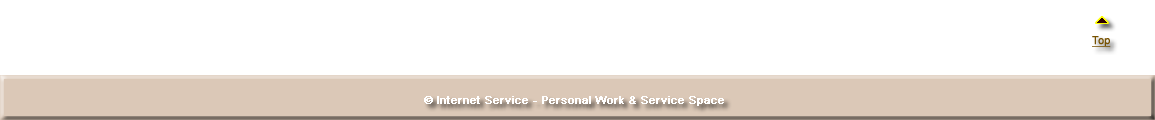È cosí che la Radio vaticana ed altre, senza dubitare della serietà delle suddette trasmissioni, raccoglievano e comunicavano con scrupolosa esattezza ai parenti dei prigionieri elenchi di italiani già deceduti da tempo. Col rientro dei circa undicimila soldati ed ufficiali italiani sopravvissuti alla mortalità dei primi otto mesi di prigionia, il Governo di De Gasperi per dover patrio si interessò dei nostri dispersi.
Uomini di cuore, dal 1945-46 consacrarono se stessi e tutte le loro energie per cercare di far luce su questo doloroso problema. Purtroppo, la mancata reale visione delle cose non solo impedí a molti di loro di conoscere e credere all'incredibile ecatombe avvenuta negli ultimi combattimenti (del novembre-dicembre 1942 e nei primi mesi del 1943 sul fronte russo) ma addirittura falsò ai loro occhi quanto avvenne nelle "marce del davài" e nei campi di morte!
Notizie meno approssimative sulla morte degli italiani in Russia sono state comunicate ai congiunti solamente da qualche compagno dei dispersi o dai cappellani superstiti i quali, come ho già spiegato, cercarono, finché poterono, di tenere aggiornate le liste di chi non sarebbe piú tornato.
È bene anche far presente, per amore della verità, che, al momento della cattura, i reparti italiani avevano già perduto, negli ultimi durissimi combattimenti della sanguinosa ritirata, dal venti al quaranta per cento degli effettivi. Dopo la cattura, la farne, la sete, le epidemie, i collassi fecero salire la mortalità a circa il novanta per cento.
Il periodo piú funesto coincise col quadrimestre gennaio, febbraio, marzo e aprile 1943 e specialmente in marzo e aprile, quando nei vagoni chiusi la sete faceva impazzire: allora si beveva orina, si leccavano i bulloni gelati e la morte era considerata come una dolce liberazione. La mortalità per i soldati continuò nel 1944 sino al principio del 1945, ma con percentuali piú basse.
La conclusione alla quale ci si deve cristianamente rassegnare stringe il cuore, ma ad essa non ci si può sottrarre, se non altro per carità di patria. Ed è questa: che nella quasi totalità dei casi l'espressione "disperso" è da parificare a quella di "caduto" - caduto sul campo o durante la prigionia - e che i nomi di questi martiri non si conosceranno mai con certezza assoluta.
Gettati nelle fosse comuni da Tambow a Krinovaja, dai campi della Siberia agli Urali, da Susdal a Oranki, sono sparsi i sessantaduemila italiani che mancano all'appello, ufficiali, sottufficiali, soldati di tutte le armi.
Quegli italiani, che a centinaia morivano di fame e di sete, chiusi nelle tane dei lager, mentre fuori dal campo i magazzini rigurgitavano di viveri, quegli italiani che pure non morivano abbastanza in fretta secondo le sistre sovietiche, le quali, sorridendo, chiedevano ogni mattina: "Scolco sivonia caput?", quanti ne sono morti, e quando il numero era inferiore al centinaio: "Malo," aggiungevano, pochi, sempre pochi; quegli italiani che seminarono delle proprie ossa i campi di Russia e invano attesero fino all'ultimo che arrivasse loro uno scritto da casa, poche parole della moglie, della madre, dei figli, la scrittura a lettere tremule dei bimbi che avevano lasciato in fasce. E sarebbe stato un dolce morire, solo che quelle lettere avessero preceduto la morte di pochi attimi.
La posta, ecco uno degli aspetti piú crudeli, piú inutilmente spietati della prigionia in Russia. A coloro che proclamavano ad ogni piè sospinto di essere depositari di democrazia e di civiltà, sarebbe costato tanto poco un gesto di umana generosità: bastava che ad ogni fuoruscito italiano, spedito nei campi a spruzzar veleno, fosse consegnato un pacco delle numerose lettere che rimasero invece ammucchiate a migliaia negli uffici propaganda dei sovietici, a testimonianza di una civiltà fatta solo di belle parole.