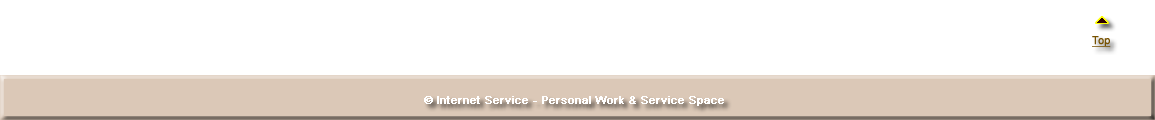Natale 1946. Neve, gelo, silenzio. Sarà l'ultimo Natale? Vietato rigorosamente il presepio, non rinunziammo alla Messa di mezzanotte, che celebrai alla presenza di cinque cattolici e del professore protestante Noak.
L'inanità mi tormentava, ora che la salute andava un po' meglio, ero fermamente deciso a gettarmi anima e corpo nell'assistenza a coloro che soffrivano piú di me. Ci riuscii allorché venni destinato al lazzaretto come aiutante del dottor Reginato.
Nel lazzaretto affluivano tutti gli ammalati del lager di Kiev e i settecento posti disponibili erano in permanenza occupati. Per quattro mesi, sino a tutto aprile del 1947, proseguí il mio apostolato senza sosta, dalle prime ore del mattino sino a tarda notte. Mi ero assunto uno dei compiti piú pesanti: accogliere i malati, lavarli e sistemarli nei giacigli ad essi destinati. Piú che uomini, assistevo scheletri viventi, macerati dalla distrofia, rosi dalla febbre, senza piú forza né volontà di vivere.
Il lavoro massacrante mi ridusse presto in uno stato di estrema anemia, ma mi fu di enorme sollievo spirituale. La miglior ricompensa per la mia coscienza l'avevo dal sorriso riconoscente degli agonizzanti.
Quando mi chinavo su di essi per impartir loro l'estrema benedizione, baciarli e raccomandarli a Dio, essi mi dicevano cogli occhi tutta la loro riconoscenza per aver trovato, prima di lasciare questo mondo per sempre, quella fraternità di cui essi avevano perduto persino il ricordo.
L'assistenza di Reginato ai malati e ai moribondi fu semplicemente sublime. Basta ricordare l'abnegazione con cui si prodigò per mitigare le sofferenze di un soldato ungherese, un certo Katona, affetto da una malattia di cui si verificano nel mondo casi assai rari: il pèmfigo. La sua pelle si sfibrava a poco a poco, finché il corpo si trasformò in una sola, tremenda, dolorosissima piaga.
Reginato, che in un congresso scientifico tenutosi in Italia prima della guerra aveva studiato profondamente le origini e il decorso del morbo, pronunciò subito una diagnosi infausta, avvertendo il maggiore medico Kurbatof, capo del servizio sanitario, e le dottoresse russe Kippermann o Grimper, che l'infelice Katona non avrebbe potuto essere strappato alla morte. Nel Camerun francese avevo curato moltissimi lebbrosi, ma mai avevo notato presso di essi il fetore che emanava da quel corpo martirizzato.
Con Reginato, una prigioniera tedesca e il prigioniero tedesco Bruno Puff, cercai di mitigare, per quel che era possibile, la crudele agonia dell'ungherese. Proposi anzi che lo rimpatriassero, perché prima di morire potesse almeno rivedere i suoi. Insistemmo, facemmo petizioni al comandante del campo, ma ci rispose sempre scuotendo il capo: «Impossibile, impossibile, impossibile».
La mattina di Pasqua del 1947 Katona spirò. Prima che esalasse l'ultimo respiro gli impartii la Comunione, e finché non morí, tenne davanti agli occhi - come ultimo estremo conforto - la fotografia dei suoi bimbi. La brutalità dei sistemi sovietici continuava a fare vittime. A Kiev non c'era posto per la pietà.
(1) La fotografia è tratta dalla pubblicazione del Ministero della Difesa, CSIR-ARMIR. Campi di prigionia e fosse comuni, Gaeta 1996, 85.