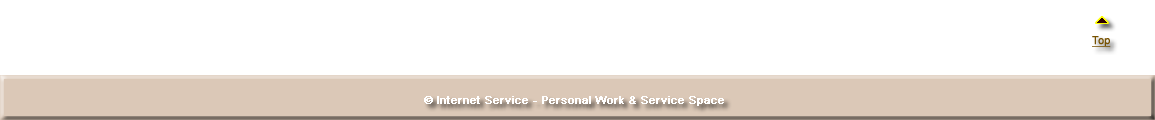«Qui in Russia migliaia di prigionieri di guerra sono ricorsi allo sciopero della fame piú volte, o per salvaguardare il loro onore di soldati o per tutelare i loro diritti umani. Ora mi dite che i miei digiuni di protesta sono reato, "sabotaggio", dite, e voi per primi siete convinti del contrario.
Sapete che non debbo rispondere di alcun crimine né davanti a Dio né davanti a voi. Qualunque sia il mio destino, però, prima o poi al di là delle vostre frontiere sapranno - rammentatevelo - di questa nuova tragica commedia giudiziaria».
«Chi vi fa pensare che lo si saprà?» mi chiese il presidente. «Ne siete convinto voi stesso, anche se fingete di stupirvi», ribattei. «Qui siete in quattro, seduti al tavolo rosso. Ebbene, tutti e quattro avete paura uno dell'altro, e lo sapete molto bene che uno di voi trasmetterà oltre cortina quanto state facendo».
I quattro cercarono di abbozzare un sorriso di commiserazione, ma non vi riuscirono e non ebbero il coraggio di guardarsi in viso. La condanna fu confermata. Dieci anni di carcere e di campo di lavoro e di «rieducazione morale». All'uscita dall'aula le guardie della scorta mi osservarono con una certa simpatia, passandomi persino delle sigarette.
Mentre attendevo di essere ricondotto al carcere, mi si avvicinò, sorridendo, un individuo. Era vestito in borghese. «Sei il pope Brevi?» mi chiese in perfetto francese. «Si, e lei chi è»? «Non importa il mio nome. Cosa pensi stavolta della tua nuova condanna? Il momento buono per rimpatriare era nel 1946, e sarebbe bastato un semplice atto di sottomissione.
Sempre cosí voi italiani, quando vi ci mettete. Ora sai che ti sono tutti contro, dal maggiore Procuranof a Laurentief. E gli altri non li conti? Credi forse che Togliatti, D'Onofrio, Robotti e via dicendo ti vogliano in Italia? Da' un addio all'Italia, pope Brevi, stavolta sei spacciato per sempre».
La mia reazione gli smorzò quel sorriso ilare che gli aleggiava sulle labbra. «Ritornerò», gli risposi. «Mai come in questo momento mi sento sicuro di tornare in Italia. Sono stato in Siberia, ho visto l'inferno dei campi di lavoro e di schiavitú, ho visto che cosa sia in verità il vostro "paradiso", ne sono uscito vivo tra migliaia di morti. Questa nuova condanna non mi spaventa, è una condanna che ha soltanto lo scopo di giustificare agli occhi dei gonzi la mia illegale prigionia contraria a qualsiasi norma di civiltà. Dasvidania».
Quando arrivammo al carcere, in piena notte, prima di consegnarmi all'ufficiale di servizio, le guardie gli batterono la mano sulla spalla. «Compagno, ti riportiamo qualcuno che non ha paura del partito», mormorarono all'ufficiale di servizio. «Ci capita assai di rado uno spettacolo simile a quello cui abbiamo assistito oggi». Rimasi circa una settimana nella celletta con l'ex capitano di aviazione, quindi fui trasferito in un'altra cella, dove trovai due nuovi compagni di prigionia: un meccanico russo e un ebreo. Appena entrai mi osservarono con una certa diffidenza, poi cominciarono a discutere. Parlavano del partito, della grandezza del partito, della intelligenza dei capi del partito, dei formidabili risultati degli ultimi piani quinquennali del partito. «Strano», pensai, «o sono scemi o sono spie».
L'enigma durò sino all'indomani, allorché l'ebreo fu chiamato per un interrogatorio. Chiusasi la porta alle sue spalle, il meccanico mi si avvicinò e tenne questo discorso: «Non si deve meravigliare, otiez ( In russo: padre) per ciò che sente dire da me e dal mio compagno quando siamo insieme. Le uniche cose vere le diciamo quando siamo soli, e lei capirà il perché. Non ci fidiamo, né io di lui, né lui di me. Aspettiamo di essere processati: solo Dio e Stalin sanno perché ci hanno messo qua dentro.
Evidentemente, come sempre, perché hanno urgenza di ripopolare i vuoti che la morte sta facendo in Siberia e in Asia. Ma in attesa del processo dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo. Una parola può costarci la deportazione e la vita. Di lei mi fido, ho saputo cosa ha detto a quelli del tribunale. Io debbo stare attento, crede lei che non pensi le sue stesse cose, e peggio? Ma ho famiglia. lo, odio a morte questo regime di sangue e di terrore. Ma chi se la sente di rischiare»? La porta si spalancò, le sue labbra si chiusero. All'apparire dell'ebreo ricominciò tra i due la concorde apologia del partito.
Aprile 1950. Una settimana prima di Pasqua indirizzai al comandante del carcere formale istanza per celebrare la Messa. Il Martedí Santo, mentre attraverso un buco della porta stavo guardando nel corridoio per vedere se vi apparisse Reginato durante la consueta passeggiata, il battente si aprí di scatto e mi comparve davanti il vice-comandante del carcere.
"Pope Brevi, il regolamento vieta di guardare attraverso i buchi delle porte. Lo sai o no»? «Lo so», risposi facendo spallucce. «Qui da voi che cosa non è reato? Ma io sono innocente e voglio rivedere i miei compagni». «Bada, pope Brevi, se insisti su questo tono sarò costretto a punirti». «Eh, se lo so...» «Ma ti sei accorto che questo non è il Vaticano»? «Domanda inutile. Perché me la fate»? «Perché hai chiesto di dir Messa». «Naturale, che l'ho chiesto».
«E io ti ripeto che qui non siamo in Vaticano». «E io vi ripeto che me ne sono, accorto da tempo, con quale gente ho a che fare...». «Pope Brevi, ancora una volta: o la smetti di piantare grane, come dite voi italiani, o finisci in cella di rigore...». «Io non cesserò mai di protestare in nome dei miei diritti». «Bene. Allora medita sui tuoi diritti in cella di punizione. Davài...» concluse il vice-comandante. «Cosí imparerai come si dice la Messa nelle nostre prigioni». Mezz'ora dopo ero negli scantinati, in cella di segregazione.
Era una stanzetta larga due metri e lunga due, umida, sporca e priva di aria. Un piccolo barattolo in un angolo, ovverosia l'intera dotazione dei "servizi", mandava un puzzo insopportabile. Una debole luce filtrava attraverso un finestrino profondo circa un metro, e largo nemmeno una spanna. Uno scampolo di legno conficcato nel muro serviva da sedile. Il pancaccio veniva portato dalle guardie soltanto a mezzanotte per essere ritirato alle quattro. In cella di punizione erano consentite quattro ore di sonno.
Non si poteva dormire nemmeno per terra, tant'era l'umidità. Il menu constava di pane ed acqua per due giorni consecutivi e di una zuppa a mezzogiorno di ogni terzo giorno. Cosí via, sino al termine del periodo di punizione. Faceva freddo e mi avevano levato anche il cappotto. In tali condizioni il mio prossimo futuro era pienamente segnato: un ricovero all'infermeria per pleurite, o broncopolmonite, come avveniva normalmente per tutti gli ospiti delle celle di segregazione.
Meditai un poco sulla mia tutt'altro che invidiabile posizione e infine mi decisi. Mi svestii e cominciai a tempestare la porta di pugni. Appena si schiuse lo sportellino lanciai tutto il mio vestiario nel corridoio, tenendomi addosso appena un paio di capi indispensabili per non apparire completamente nudo.
(1) La fotografia è tratta dalla pubblicazione del Ministero della Difesa, CSIR-ARMIR. Campi di prigionia e fosse comuni, Gaeta 1996, 61.